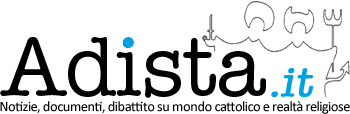Contro l'apartheid, l'unica arma è l'azione popolare
Tratto da: Adista Documenti n° 34 del 07/10/2017
Per l'introduzione a questo intervento, clicca qui
La questione di una soluzione del problema israelo-palestinese continua ad alimentare il dibattito tra coloro che, nel mondo, hanno a cuore la sorte dei due popoli, israeliano e palestinese. È parere diffuso che un’eventuale soluzione non possa prescindere dal tipo di assetto politico-istituzionale da dare al territorio complessivo: uno Stato unico o due Stati per due popoli. Per affrontare la questione occorre fare alcune premesse:
1. il dibattito è appannaggio di pochi intellettuali che, per la gran parte, vivono fuori del territorio palestinese, ovvero la questione non è all’ordine del giorno del dibattito politico sia israeliano sia palestinese. Con ciò non si vuole sminuire l’importanza della discussione, la si vuole solo situare nella cornice concreta in cui si svolge;
2. la situazione attuale è quella di uno Stato unico, lo Stato d’Israele, che esercita la sua sovranità di fatto sull’intero territorio della Palestina mandataria. Tale Stato si fonda su una dottrina di esclusione/inclusione, la dottrina sionista, in base alla quale è stato realizzato un sistema di apartheid che condiziona ogni aspetto della vita quotidiana, sia quella degli esclusi, i palestinesi, sia degli inclusi, gli israeliani, e di cui il muro di separazione è solo la manifestazione più eclatante;
3. il sistema israeliano è sorretto da un’opinione pubblica interna e internazionale favorevole: da ciò deriva che gli conviene la situazione attuale. I palestinesi invece, impazienti di risolvere il problema del peso dell’occupazione e della minaccia all’esistenza stessa della comunità, accetterebbero qualsiasi soluzione;
4. ma nessuna soluzione è pensabile se la cosiddetta “comunità internazionale” non è partecipe. Per una serie di motivi, tra i quali figura l’alta concentrazione di interessi geopolitici ed economici che, oltre alla Palestina, coinvolgono le aree vicino e medio orientali. Non bisogna dimenticare inoltre che del problema israelo-palestinese furono artefici le potenze internazionali, non quelle regionali, e che continua a essere gestito, e fomentato, da quelle stesse potenze.
Procedo all’esame dei punti elencati sopra con l’obiettivo di dimostrare la fattibilità o meno della soluzione “due Stati” o “uno Stato” nel medio termine.
1. Il dibattito politico internazionale, da quando la prima potenza occupante, la Gran Bretagna, investì della questione gli organismi internazionali – la Società delle Nazioni prima e l’Organizzazione delle Nazioni Unite poi – verte esclusivamente sulle modalità di spartizione del territorio in modo da assicurare la creazione e la sopravvivenza di uno Stato destinato ai coloni, Israele, e di un eventuale Stato per gli indigeni, i palestinesi. La maggioranza degli israeliani sostiene l’attuale sistema politico dell’unico Stato esistente, quello dell’apartheid, mentre la maggioranza dei palestinesi sembra convinta che la soluzione risieda nella costituzione di uno “Stato” separato.
L’idea di creare uno Stato “per gli ebrei” in Palestina implicò il problema sul come eliminare la popolazione autoctona, considerata di troppo ai fini del processo che si stava per innescare. Uno Stato “per gli ebrei” comporta di necessità l’esclusione dei non ebrei, ossia degli abitanti autoctoni. Il passaggio all’attuazione pratica iniziò con l’occupazione britannica della Palestina, nel 1917. Durante i primi anni dell’occupazione il ministro delle colonie Winston Churchill pensava che si potesse spostare tutta la popolazione palestinese in Transgiordania. È con questa motivazione che viene creato l’emirato di Transgiordania. Nel 1937 una commissione d’inchiesta del governo di Londra – la Commissione Peel – spedita in Palestina per sedare la rivolta degli abitanti, raccomandò la spartizione della Palestina “tra le due comunità”, e lo “scambio” di territori e popolazioni, ossia l’espulsione dei palestinesi dai territori destinati allo Stato ebraico. Il meccanismo di spartizione e di “scambio di popolazione”, a volte esplicito, ma più spesso taciuto, resta ancora oggi lo strumento per attuare il progetto coloniale ed escludere da ogni diritto gli indigeni. I diversi piani di spartizione proposti servivano, e servono ancora oggi, a creare ed estendere lo spazio territoriale allo Stato “per gli ebrei”. Basta uno sguardo alla successione nel tempo delle carte geografiche per rendersi conto della continua erosione del territorio a scapito dei palestinesi.
In linea generale qualsiasi spartizione o cantonalizzazione tende a separare, a creare barriere, ad alimentare sentimenti di superiorità e quindi fomenta il razzismo e la conflittualità.
In sintesi, il dibattito internazionale tende a rimodellare la spartizione secondo le esigenze israeliane, mentre il dibattito ‘popolare’, constatato il fallimento della spartizione, cerca modelli alternativi.
2. Ogni sistema coloniale è, per sua stessa definizione, razzista. Uno Stato basato sull’idea di “razza”, comunque camuffata, non può non avere un impianto d’apartheid. Per dimostrare tale affermazione non è sufficiente dire che lo Stato ebraico, per sua stessa definizione, esclude chi ebreo non è. È invece sufficiente osservare la politica demografica discriminatoria dello Stato d’Israele, ma ricordiamo anche le dichiarazioni d’intenti del fondatore del sionismo organizzato, Theodor Herzl: «Tenteremo di trasferire oltre confine la popolazione priva di denaro offrendo un impiego nelle nazioni di transito e al contempo impedendo qualunque possibilità di occupazione nel nostro territorio [...]. Le espropriazioni e il trasferimento dei meno abbienti debbono essere effettuati con discrezione e circospezione (The Complete Diaries of Theodor Herzl, I, p. 88, citato tra gli altri da B. Morris, Esilio, Rizzoli, 2005, p. 89, e da E. Said, La questione palestinese. La tragedia di essere vittima delle vittime, Roma, Gamberetti, 1995, pp. 38-39»).
Pur non soffermandoci a ricordare la pulizia etnica del 1948-49, quella in scala minore del 1956 e quella del 1967, è sufficiente osservare la politica attuale, quella effettiva, al di là delle parole, dello Stato d’Israele. La politica israeliana odierna è la stessa dalla fondazione dello Stato: acquisire il massimo possibile di territorio che contenga il minor numero di “arabi”. La politica di discriminazione razziale si esplicita nella prassi in ogni aspetto della vita quotidiana. Si manifesta non solo con la costruzione del muro che delimita e restringe le aree in cui è confinata la popolazione autoctona, ma soprattutto si realizza con la confisca delle terre, l’incessante demolizione delle case, la cancellazione di 512 centri urbani dalla carta geografica, la costruzione di insediamenti ad uso esclusivo degli ebrei (il Comitato Israeliano contro la Demolizione delle Case-ICAHD stima che oltre 130.000 case di palestinesi, comprese quelle dei beduini, siano state demolite in tutta il Paese dal 1948. Cfr. Jeff Halper, "Espellere i beduini è economicamente remunerativo", in www.zeitun.info, 6/9/2017). E questo avviene non solo nei territori occupati nel 1967, ma anche e tuttora nei territori dichiarati Stato d’Israele nel 1948, e si attua attraverso il sequestro delle fonti d’acqua, la carcerazione amministrativa, anche dei minori, il confinamento di due milioni di palestinesi a Gaza e tanti altri innumerevoli soprusi che rendono impossibile la vita quotidiana. Si manifesta soprattutto attraverso un sistema di leggi che dà valore legale all’apartheid. Un esempio: la legislazione israeliana permette che i bambini palestinesi vengano processati da tribunali militari, mentre i minori ebrei possono essere giudicati solo da tribunali per minori. Le leggi fondamentali dello Stato sono discriminatorie, a cominciare dalla legge sulla cittadinanza, “la legge del ritorno”, o quella sulla proprietà della terra, o sulla “proprietà degli assenti”, dove gli assenti sono i palestinesi, anche quando sono fisicamente presenti.
Ma cosa bisognerebbe fare? In sintesi, occorre modificare il sistema giuridico israeliano, razzista, per farlo rientrare nella legalità internazionale e bisogna applicare le risoluzioni internazionali riguardanti la Palestina perché si avvii un concreto processo di riconciliazione e si proceda sulla strada di una soluzione, qualunque essa sia.
3. La politica del governo israeliano ha il consenso della maggioranza degli israeliani. Sarebbe facile, ma non sufficiente, motivare che i cittadini eleggono democraticamente una classe politica che rappresenta i loro ideali. Bisogna però ricordare che il governo trova consenso perché gli israeliani ne hanno un tornaconto in campi fondamentali: demografico (di qui l’azione politica mirata a fare in modo che sul territorio la maggioranza della popolazione sia ebraica), terra come “spazio vitale” (in modo da accrescere il possesso ebraico del territorio e ridurre quello di cui i palestinesi potrebbero disporre), economia (in questo campo tutto il sostegno è dato alle imprese ebraiche e si sabotano quelle palestinesi), armamenti (per cui si fa ogni sforzo, economico e diplomatico, per aumentare la potenza militare dello Stato e per la destabilizzazione e la distruzione dei Paesi limitrofi).
Ma tale consenso è sorretto anche e soprattutto dal consenso delle istituzioni delle potenze colonialiste o ex colonialiste che per varie ragioni, strategiche ed economiche (gli interessi per il petrolio), ideologiche e ancestrali (come l’islamofobia alimentata ad arte), potenziano e approvano il militarismo israeliano sostenendo lo Stato di Israele nonostante le conseguenze devastanti anche per i propri Paesi. Occorre perciò un radicale cambiamento nella società israeliana affinché diventi possibile modificare il sistema. La società israeliana è profondamente malata di sionismo, una mistura di “diritto di colonizzare”, fanatismo nazionalistico, irredentismo religioso, affermazione ed esercizio del proprio dominio con conseguenti razzismo e sadismo. Questa mistura è continuamente alimentata dalle correnti più intransigenti del sionismo europeo e americano, oltre che dal fondamentalismo cristiano statunitense.
4. Ormai non è controverso il motivo che spinse la Gran Bretagna a installare una colonia europea permanente in Palestina: proteggere il Canale di Suez che era la via principale verso l’India, ossia proteggere gli interessi imperiali in Oriente. Gli interessi strategici oggi sono diversi, ma gli strumenti sono rimasti gli stessi: l’intervento militare diretto e il terrorismo.
Non è forse superfluo ricordare che il modo stesso, la violenza e la guerra, con cui fu impiantato lo Stato d’Israele in Palestina sia parte della politica di frammentazione del mondo arabo-islamico. Lo Stato d’Israele, sino a quando continuerà a essere funzionale agli interessi delle grandi potenze, sarà un’arma puntata contro le popolazioni arabe, a guardia di interessi strategici, economici e dell’assetto geopolitico regionale. Nella prospettiva coloniale e imperiale, il controllo del “Medio Oriente” – essenzialmente delle risorse petrolifere –, è imprescindibile per esercitare l’egemonia su scala planetaria. È sufficiente a questo proposito ricordare i recenti interventi militari della Nato in Iraq e Libia, o l’uso del terrorismo in Siria.
L’insurrezione delle masse popolari in Palestina nel 1987, nota come intifada, così come quelle in Tunisia, in Egitto e nello Yemen in anni più recenti, sono segnali del possibile sgretolamento del sistema neo-coloniale.
Quell’intifada, se da una parte ha reso evidente l’impossibilità di annettere la Cisgiordania e Gaza e la non praticabilità, almeno nel breve periodo, di un’espulsione di massa dei palestinesi, dall’altra ha creato un oggettivo, fino ad allora impensabile, interesse comune tra il governo israeliano e la leadership dell’OLP, preoccupati entrambi dalla crescente capacità di mobilitazione della popolazione e dall’emergere nei territori occupati di figure di leader giovani non controllati dall’organizzazione palestinese. Il timore della dirigenza palestinese di perdere potere l’ha spinta a firmare il riconoscimento della legittimità dello Stato ebraico in cambio della promessa di un regime d’autonomia in un non ben precisato spazio territoriale.
La firma degli accordi di Oslo ha comportato la liquidazione dell’azione popolare, unica carta in mano ai palestinesi, e ha permesso al governo israeliano, sotto la coltre fumogena del “processo di pace”, di moltiplicare gli insediamenti e i coloni in Cisgiordania, di rosicchiare altri pezzi di territorio e di ridurre le aree ancora abitate da palestinesi a veri e propri campi di concentramento. Ciò è stato possibile attraverso la creazione della cosiddetta “autorità nazionale palestinese”, pensata come strumento dell’occupazione e divenuta perno del meccanismo che permette di perpetuare l’occupazione stessa. Del resto, per controllare le popolazioni sottomesse è una vecchia pratica delle potenze coloniali quella di smembrare i territori conquistati e di creare élite locali con cospicui interessi legati ai centri del potere mondiale.
Il cosiddetto “processo di pace” avrebbe dovuto portare alla creazione di uno Stato palestinese accanto a quello israeliano. Ma su quale territorio? La gran parte del territorio cisgiordano è stata requisita dagli israeliani, sia per costruire gli insediamenti degli ebrei sia per usi militari e altre fette consistenti sono state inglobate dal muro di separazione. Così è riemerso di nuovo il discorso dello “scambio di territori”. Il che, tradotto, significa una cosa soltanto: “espulsione”. L’eventuale creazione di uno Stato palestinese, su un territorio “di scambio”, può diventare lo strumento per legalizzare un’ulteriore espulsione di palestinesi. Uno Stato del genere è destinato a durare il tempo necessario per accogliere quei palestinesi che Israele vorrà espellere sotto la copertura dello “scambio di popolazione”, un modo per “trasferire” gli “arabi israeliani”, ossia espellere i palestinesi non espulsi nel 1947-49 dai territori della prima conquista israeliana.
Basta uno sguardo alla carta geografica della Cisgiordania per rendersi conto che la colonizzazione procede con ritmi sempre più accelerati e con essa il numero dei coloni, mentre i palestinesi sono costretti in aree sempre più ristrette, in attesa che per espellerli arrivi il momento opportuno.
Il governo Netanyahu sta anche procedendo a demolire interi centri abitati da palestinesi con cittadinanza israeliana, privandoli della cittadinanza semplicemente cancellando i loro nomi dai registri dell’anagrafe.
La pulizia etnica cominciata nel dicembre del 1947 continua ancora oggi, a distanza di 70 anni.
A questo punto è evidente che nelle condizioni attuali non c’è spazio per una soluzione, né quella di “uno Stato” né quella dei “due Stati”. Solo l’azione popolare costante contro il muro e i 550 checkpoint permanenti, contro il sequestro delle terre, la demolizione delle case, la carcerazione preventiva, le esecuzioni extragiudiziarie e le lotte per il diritto allo studio, al lavoro, alla libera circolazione porteranno a modificare il quadro attuale. È per questo che serve il supporto del movimento di boicottaggio del sistema coloniale d’apartheid israeliano: smantellare l’apartheid è condizione preliminare per qualsiasi soluzione del “problema palestinese”.
* Wasim Dahmash è saggista, docente e traduttore palestinese nato in Siria. Insegna lingua e letteratura araba all’università di Cagliari. Si occupa principalmente di traduzione letteraria e di dialettologia araba, con particolare riferimento ai dialetti dell’area siro-palestinese.
* * Foto di OneArmedMan, tratta da Wikimedia Commons, immagine originale e licenza
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!