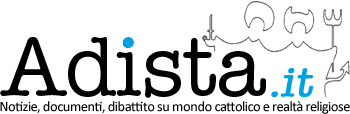Noi diciamo riserve, loro dicono casa
Tratto da: Adista Documenti n° 24 del 01/07/2017
«Ma non avete paura delle tigri?». La risata del jenu kuruba spaventò gli uccelli sugli alberi. E anche il mio cuore si mise a battere più forte, scosso senza preavviso dalla quiete silenziosa della foresta di Nagarhole, una Riserva delle Tigri situata nello Stato di Karnataka, nell’India meridionale. Ritrovata la calma, l'anziano uomo mi disse con dolcezza: «Certo che no! Non siamo spaventati da nessun animale! Abbiamo vissuto insieme per generazioni. Non abbiamo mai fatto del male agli animali. Noi siamo la ragione per cui la foresta si è preservata fino ad oggi». La mia domanda doveva sembrargli assurda. Come se chiedessero a noi se abbiamo paura di cani e gatti. Posi la stessa domanda altre volte, ad altri occhi pieni della stessa dignità e dello stesso stupore. E altre risate risuonarono nella folta giungla di Kanha, nel verde tropicale della riserva di BRT Hills, e in tante altre foreste. Eppure, solo qualche settimana prima di addentrarmi nella natura mozzafiato dell’India, avevo visto un documentario in cui un famoso esponente indiano della conservazione dichiarava: «Loro si sentono profondamente legati a questi posti, anche se hanno una vita molto difficile qui. Vivono nella paura costante degli elefanti, dei leopardi, delle tigri. E, quando hanno dei bambini piccoli, quelle sfide diventano ancora più grandi». Ma qualcosa non mi convinceva. Mi guardai intorno. La foresta mi sembrava indistinta e silenziosa. Mi faceva anche un po’ paura. Ma di lì a poco i millenari custodi di quei luoghi, i popoli tribali, mi avrebbero insegnato che ci sono mille tonalità di verde, che ogni foglia è diversa dall’altra, e che, dietro a quell’apparente silenzio, si nasconde il rumore assordante del brulichio degli insetti.
I migliori custodi della natura
Prima ancora che quei luoghi diventassero riserve delle tigri, o aree da “conservare”, i popoli tribali avevano già sviluppato misure efficaci per preservare la ricchezza dei loro ambienti. I Soliga, ad esempio, accendevano piccoli fuochi per ripulire la terra e prepararla all’agricoltura sostenibile. Ma da quando questa pratica è stata vietata nel nome della conservazione, gli ecosistemi locali si sono deteriorati a causa della diffusione di un’erba selvatica invasiva chiamata lantana. È un problema anche per le tigri, che rimangono intrappolate nei grovigli di rami formati da questa pianta. «Il Dipartimento alle Foreste non ha le conoscenze necessarie alla conservazione. Noi abbiamo conservato la foresta per molti anni. Loro non sanno come proteggere la nostra foresta», mi ha detto un uomo soliga. Non è un caso che tutte le riserve delle tigri siano anche la casa dei popoli tribali. Molti popoli tribali dell’India venerano le tigri, e le considerano parte della loro famiglia spirituale allargata. Così come non è un caso se la stragrande maggioranza dei 200 luoghi oggi a più alta biodiversità del pianeta è data da terra indigena. Infatti, prove sempre più numerose e schiaccianti dimostrano che questi popoli sanno prendersi cura dei loro ambienti meglio di chiunque altro. Ad esempio, all’interno della prima riserva dell’India in cui le tribù locali si sono viste riconoscere il diritto a restare (BRT Hills), la popolazione delle tigri è quasi raddoppiata, passando da 35 a 68 esemplari. Un incremento decisamente superiore al tasso di crescita media nazionale. Se ci spostiamo dall’India per avere un quadro più ampio, vediamo che i territori indigeni costituiscono la migliore barriera contro la deforestazione in Amazzonia. E che i frutteti degli Orang Asli, nella riserva di Krau in Malesia, attirano nell’area molti animali, compresi i grandi mammiferi. Questi orti forniscono cibo e costituiscono anche una delle principali modalità di diffusione dei semi, colmando un ruolo che un tempo era di elefanti e rinoceronti, ora scomparsi dall’area. L’agricoltura indigena su piccola scala aiuta spesso a incrementare la biodiversità.
Dati che non dovrebbero sorprenderci
I popoli indigeni hanno vissuto e gestito i loro ambienti per millenni. Avendo abitato quei luoghi per generazioni, hanno sviluppato un sapere enciclopedico su ogni pianta, minerale e animale con cui convivono. I “Pigmei” Baka, ad esempio, conoscono così profondamente gli elefanti da utilizzare 15 parole per definirli a seconda del sesso, dell’età e persino del carattere. I popoli indigeni hanno una relazione di reciprocità con la foresta basata sul rispetto dei cicli della natura e sul senso di responsabilità per le generazioni future. Secondo i loro insegnamenti, non bisognerebbe mai prendere più di quanto non sia necessario e non sprecare nulla. Molti cercano di restituire alla natura ciò che da essa prendono. Quando raccolgono il miele dagli alberi alti, i Soliga ne lasciano un po’ a terra per le tigri, perché «le tigri non possono salire sugli alberi e prendere il miele». Come una donna chenchu mi ha detto: «Se gli stranieri entrano nella foresta, taglieranno tutti gli alberi e toglieranno tutti i frutti. Noi non tagliamo gli alberi e prendiamo solo i frutti di cui abbiamo bisogno». La foresta non è solo la loro casa. La foresta è sacralità, è vita, è medicina, è fonte di nutrimento. Le tribù la trattano con amore e rispetto. Un uomo chenchu mi ha spiegato: «Amiamo la foresta come un bambino ama sua madre».
Il lato oscuro della conservazione
Nonostante i popoli indigeni siano gli indiscutibili custodi della foresta, con la nascita del movimento conservazionista e nel nome della protezione della natura, hanno cominciato a essere sfrattati illegalmente dalle loro terre ancestrali. E oggi rischiano arresti, pestaggi, torture e morte solo perché svolgono le loro attività quotidiane. «Come possiamo vivere senza la giungla?», mi dice un uomo baiga. Gli altri attorno a lui aggiungono: «E come può la giungla vivere senza di noi?». Per i popoli indigeni e tribali la terra non è un’entità da sfruttare bensì un universo da sostenere e mantenere in equilibrio a cui l’essere umano appartiene al pari di qualsiasi altro essere vivente. Difenderla è semplicemente il loro modo di vivere, e non un dovere, perché dal suo stato di salute dipende la loro stessa sopravvivenza e quella delle future generazioni. Alla base del concetto di “conservazione” c’è invece una concezione dualistica del rapporto essere umano-natura che considera la natura come un dominio autonomo distinto dalla sfera delle azioni umane. Un luogo incontaminato in cui l’essere umano si pone come una mera forza distruttiva, finché non interviene a esercitare la sua giurisdizione per assicurarne la preservazione. Tuttavia, secondo i popoli indigeni, la natura non è “vergine” né “selvaggia” se non nell’immaginario occidentale. E, a conferma della loro visione, oggi esistono prove scientifiche che dimostrano come la fisionomia della maggior parte delle regioni ecologicamente più importanti del pianeta, così come le conosciamo noi oggi, sia il prodotto culturale di una manipolazione molto antica della flora e della fauna, operata da società umane a loro volta condizionate e plasmate da secoli di convivenza con esse. L’approccio non potrebbe essere più distante. Da un lato un rapporto dell’essere umano con la natura fondato su valori di uguaglianza, reciprocità ed equilibrio: la visione eco-centrica dei popoli indigeni, capaci di sfruttare le risorse dei loro ambienti senza mai alterarne i principi di funzionamento e i cicli di riproduzione. Dall’altra un movimento conservazionista radicale e razzista che, a partire dagli USA del XIX secolo, si è espanso soprattutto in Africa e in Asia sfrattando illegalmente milioni di indigeni dalle loro terre ancestrali per farne santuari inviolabili, liberi da qualsiasi presenza umana, con conseguenze drammatiche. Alcuni popoli tribali dell’India vengono sfrattati illegalmente dalle loro terre nel nome della conservazione delle tigri. Vengono fatte loro promesse di terre alternative, di case e denaro, ma si tratta di menzogne: spesso ricevono poco o nulla, e finiscono per vivere ai margini del loro territorio, nello squallore più totale. Quando non se ne vogliono andare, le guardie forestali li arrestano, li multano, li picchiano e li minacciano fino a quando non vanno via. I “Pigmei” Baka nel bacino del Congo rischiano arresti e pestaggi, torture e morte per mano dei guardaparco che li accusano di “bracconaggio” perché cacciano per nutrire le loro famiglie. Le guardie sono finanziate dal WWF (Fondo Mondiale per la Natura) che ha un ruolo chiave anche nel furto delle terre baka. Un approccio che non danneggia solo i popoli indigeni, ma anche la natura, perché sta distruggendo i migliori alleati dell’ambiente. «Noi non abbiamo paura degli animali», mi dice un jenu kuruba. «Abbiamo paura delle atrocità commesse dai conservazionisti. Questa è l’unica ragione che ci spinge a lasciare la foresta. Ma noi non lasceremo questa foresta. Rimarremmo qua e moriremo qua».
Quello che non trovi su Google maps
L’anziano jenu kuruba mi racconta di quando i colonizzatori inglesi arrivarono e chiesero il suo aiuto per mappare la foresta, tanto tempo fa. È stato lui a dire ai primi conservazionisti il nome degli alberi, a indicare i punti più ricchi di biodiversità, a segnalare il rifugio degli animali selvatici, a guidarli nei meandri della fitta foresta indiana. Quella mappa desta la mia curiosità, e gli chiedo se gli inglesi gli abbiano lasciato una copia. Ride di nuovo, questa volta per un secondo. E guardandomi diritto negli occhi dice: «Assolutamente no! Gliela chiesi pure e mi risposero: tu non hai bisogno di mappe, hai i tuoi occhi, gli occhi della foresta». E come dargli torto?
* Fiore Longo è ricercatrice di Survival International, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni impegnato dal 1969 a difenderli dalla violenza genocida, dalla schiavitù e dal razzismo e a proteggere le loro terre e il loro diritto all’autodeterminazione. A finanziare il lavoro di Survival, che è rigorosamente apartitica e aconfessionale, sono quasi esclusivamente le donazioni dei singoli, insieme ai proventi di piccole iniziative di raccolta fondi. Tra le principali campagne, c’è quella per un nuovo modello di conservazione della natura, che si opponga allo sfratto dei popoli indigeni dalle terre ancestrali e alla violazione dei loro diritti umani operata nel nome della protezione dell’ambiente. Per sostegno o maggiori informazioni: www.survival.it.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!