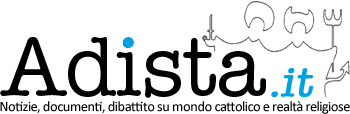DESAPARECIDOS, PRESENTI!
- Infine è stato condannato al carcere a vita il dittatore argentino Jorge Videla
Tratto da: Adista Contesti n° 7 del 29/01/2011
Tratto dal quotidiano argentino pagina/12 23 dicembre 2010. Titolo originale “El abrazo de la Justicia”
Se la giustizia avesse braccia lunghe, ieri sarebbe stata in grado di abbracciarci tutti: le donne del fazzoletto bianco, unite per mano e braccia in alto in segno di vittoria, la ragazza che si era dipinta sul viso “Nunca más” (mai più, ndt), gli ex prigionieri politici che sventolavano davanti alle telecamere una leggera bandiera, quella madre e quella figlia che piangevano abbracciate mescolando lacrime e sudore e sorrisi per essere più unite in questo momento. Il dittatore (Jorge Videla, ndt) è stato condannato: il Tribunale Numero 1 di Córdoba ha disposto il suo immediato trasferimento ad una unità penitenziaria federale. Nella sala dove avviene il giudizio scoppiano gli applausi, il giudice che legge la sentenza di condanna chiede silenzio e sembra parlare anche a quanti, a 700 km di distanza, nel Microcentro porteño (zona di Buenos Aires ad alta concentrazione di imprese, banche e servizi, ndt), affollano a straripare lo spazio dove uno schermo gigante riprende l’aula che ospita il processo. Taty Almeida si toglie il fazzoletto bianco e disegna con esso nell’aria una sorta di passo di zamba (danza folcloristica argentina, ndt), avvolgendo poi Estela Carlotto. Madre, l’una, e Nonna, l’altra, «di Piazza di Maggio» ballano saltellando come adolescenti, come se questo atto di giustizia avesse cancellato le tracce del tempo. Una condanna non può cancellare tutto, ma certamente ripaga un po’ dei tanti anni di impunità.
Alba Lanzillotto, con la foto delle sue due sorelle desaparecidas sul petto, Ana María e María Cristina, racconta un aneddoto mentre agita il suo ventaglio. Parla di una Madre - così, con la maiuscola - che dopo anni passati in stato di incoscienza, ha avuto un istante di lucidità. E allora uno dei suoi figli le ha detto: «Mamma, li stiamo giudicando, hanno appena dato l’ergastolo al Turco Julián» (soprannome del sergente maggiore Hector Julio Simon, di cui è stato provato l’incredibile sadismo, ndt). La donna ha ascoltato e ringraziato: «Che gioia essere ancora viva per poter essere testimone di questo momento». Ed è ripiombata nel suo stato di incoscienza. «Io non posso festeggiare – dice Alba -, non mi viene di essere euforica. Ma so perfettamente che queste condanne sono un rimedio, una cura per il Paese tutto e per molte singole persone». Quando dallo schermo allestito nell’auditorium Emilio Mignone, della Segreteria dei Diritti umani, si è udita la sentenza su Videla, Alba ha diretto gli occhi con determinazione sulle foto che portava sul petto e le ha accarezzate amorosamente.
Il dittatore Jorge Rafael Videla, il tipo dai baffi folti che porta il nome di due morti (i suoi due fratelli maggiori), nel 1977, quando molti desaparecidos erano ancora vivi, si vantò in una conferenza stampa del fatto che «i desaparecidos non sono né vivi né morti, sono scomparsi»; lo stesso uomo anni dopo, coperto dall’indulto che Carlos Menem regalò a lui come ad altri suoi sodali, disse a un giornalista (secondo quando risulta dal libro El Dictator, di María Seoane e Vicente Muleiro): «Mettiamo un numero, mettiamo cinquemila. La società argentina non avrebbe sopportato le fucilazioni: ieri due a Buenos Aires, oggi sei a Córdoba, domani quattro a Rosario, e così fino a cinquemila. Non c’era altro modo. Eravamo tutti d’accordo su questo. E chi non era d’accordo se ne è andato. Far sapere dove stanno i resti? Ma h, che possiamo dire: nel mare? Nel Rio de la Plata, nel Riachuelo? C’è stato un momento in cui abbiamo pensato di rendere note le liste. Ma poi si è pensato: se li si danno per morti, subito verranno le domande cui non si può rispondere, chi ha ucciso, dove, come?».
Poi al processo è venuto il turno di Luciano Benjamin Menéndez, il signore dei coltelli. Si è ascoltato il ‘grappolo’ di delitti di cui è stato giudicato colpevole. Si sono ascoltate le parole magiche che hanno scongiurato l’impunità: ergastolo a vita, interdizione perpetua, più pene accessorie e costi per spese legali da smaltire in carcere. Ha avuto maggior fortuna il sedicente “soldato vittorioso sulla guerriglia marxista”: a lui spetta che una commissione medica valuti se è in condizioni di seguire Videla in un carcere comune. Menéndez ha uno strano record: è al suo quinto ergastolo. Un ragazzo con una t-shirt che dice «Giudizio e Castigo» osserva: «Si spera che avrà la salute per morire in carcere». Non è un desiderio pietoso. È un desidero allevato in tanti anni di attesa di atti di giustizia come quello avveratosi ieri.
Eduardo Jozami è passato per cinque case penali durante la dittatura, da Devoto a Rawson, ha percorso mezzo Paese con trasferimenti improvvisi e arbitrari. Non ne parla, ma come qualsiasi altro prigioniero politico deve aver visto compagni morire in carcere. Per lui, questo giudizio, queste condanne che si succedono con la voce monocorde del giudice di Córdoba hanno il peso specifico del resoconto che la repressione era una trama alla quale partecipava lo Stato a tutti i livelli, finanche burocratici. “Questa è un riscatto anche per i prigionieri politici”, sostiene Lita Boitano, dei Familiari di detenuti e desaparecidos per ragioni politiche. “Perché a volte sembra che i prigionieri non se la siano passata tanto male quanto altri, che il carcere è stato un sopravvivere”, insiste Lita, sorridendo emozionato. Lo dice non per fare una gerarchia fra le vittime, ma perché niente si perda fra le pieghe. È che la profondità delle ferite si vede nella penombra e che ancora molto c’è da dire, da fare, da giudicare, da riparare. Anche di ciò deve interessarsi la giustizia, magari con tempi lenti e con il contagocce. Oltre alle condanne, ciò che è stato detto in questo giudizio rimarrà scritto a lettere di stampa come impone la legge. E potrà essere consultato per molte generazioni da qui in avanti.
Il silenzio si impossessa dell’aula mentre la lettura della sentenza avanza, operativa, formale, reiterativa. E indifferente a quello che significano per molte persone in questo uditorio, alle porte del Tribunale di Cordoba e in tanti altri posti frasi come «imposizione di tormenti aggravata dalla condizione di perseguitato politico della vittima». Descrivono né più né meno la pianificazione di un massacro. Descrivono anche l’indicibile che hanno passato persone amate - un figlio, una madre, un fratello - che sono state cercate, per le quali si è reclamato, che continuano a mancare. Questa reiterazione del tormento, tormento aggravato, tormento seguito da morte, come un martello pneumatico che colpisce con forza sempre maggiore. Forse è un sollievo questo applaudire e festeggiare ogni volta che la descrizione dei fatti si traduce in condanna.
Ci sono cornetti e panini nell’aula, c’è mate, latte e caffè, bibite fresche per una serata arroventata. Agueda non mangia né beve. Basta guardarla negli occhi perché una piccola inondazione si produca fra le sue palpebre. Non è di quelli che festeggiano, non può farlo sebbene sia lì per ascoltare insieme ad altri e ad altre come la Giustizia si faccia strada. I suoi genitori, Luis Goyochea e Nelly Moreno, sono desaparecidos di Córdoba. È stata già testimone di un’altra condanna inflitta a Benjamin Menéndez, a questo generale ultranazionalista che nei primi anni della democrazia ancora si sentiva così potente da permettersi di tirar fuori il suo coltello militare e brandirlo contro chiunque lo ripudiasse in una delle sue tante “visite” a un tribunale. Menéndez, comandante del Terzo Corpo dell’Esercito, capo e padrone del Campo Clandestino di Detenzione e Sterminio di La Perla, dove la mamma di Agueda fu assassinata, andrà in carcere, o ovunque saranno destinate le sua ossa dalla commissione medica, senza dire tutto quello che sa sul destino di tanti. Ed è una cosa che ad Agueda non va giù. O meglio, è un cosa che le fa male. Che non parlino o che parlino per recitare la parte del soldato eroico. D’altronde sa - come sanno le altre “figlie” che la circondavano (così facile è chiamare chi ha i genitori desaparecidos: “sono figlia” è sufficiente, perché il vincolo è qualcosa di più che un’ovvietà, è una relazione politica) - che ci sono incubi che cominciano a dissiparsi, come quello di incontrare per strada un repressore e non sapere cosa fare, cosa dire. In questo gruppo di quattro figlie, tutte hanno qualcosa da raccontare: la volta che incrociarono Astiz, la volta che Lucía si sentì male vedendo il Turco Julián seduto in un bar a Corrientes. Questo almeno non succederà più.
Al cellulare di chi scrive arrivano molti messaggi quando già sono stati annunciati 15 ergastoli nel processo per la fucilazione di 31 prigionieri politici a Córdoba. La maggior parte degli sms dice poco; cose come “un forte abbraccio”. Però dovrei correggermi: questo è lontano dall’esser poco; al contrario, dice di un sostrato d’affetto che ricorre a molti modi di esprimersi, che condivide quello che succede qui, in questa aula, dove sono Madri, Nonne, ex prigionieri politici, qualche funzionario, molti militari giovani: l’allegria di sapere che alcune sentenze sono ben più di questo, sono un obiettivo da compiere. E quella che diceva “carcere comune, a vita ed effettivo, per gli assassini, i loro complici e i loro istigatori” - e che i ragazzi e le ragazze di “Hijos” scandiscono ritmandolo - sta cominciando a compiersi, piano piano, effettivamente. Con l’insopportabile costo della scomparsa di Julio López e l’assassinio di Silvia Suppo, anche loro presenti, anche loro dolorosamente assenti.
Dallo schermo si sente la voce che dice: «Il processo è terminato», e subito si sente il grido che accompagna tanti di questi atti giudiziari: 30 mila compagni desaparecidos, presenti! L’abbraccio della Giustizia questa volta è tanto lungo e tanto caldo quanto freddo e intransigente con chi ha dovuto esserlo.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!