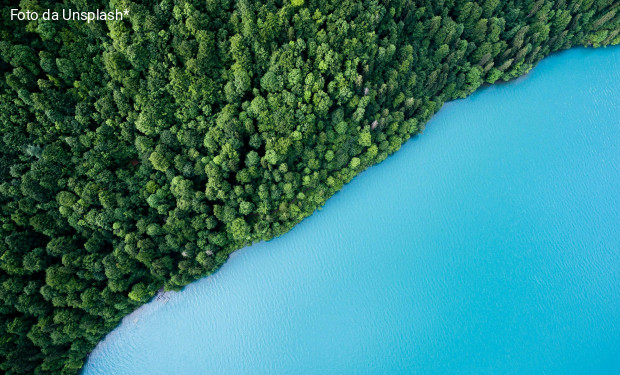
Comunità cattoliche di fronte all’inferno climatico e sociale
Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 43 del 14/12/2024
A luglio di ogni anno porto un gruppo di giovani tra i 20 e i 35 anni a camminare sulle Alpi Occitane, 6 giorni in tenda sopra i 2000 metri leggendo capitolo per capitolo la Laudato si’ di papa Francesco, e discutendola in relazione alle proprie esperienze di crescita, di attivismo, di impegno e stili di vita. Dalle reazioni di tante e tanti giovani – non sempre praticanti e qualche volta non credenti – traggo due riscontri: quel testo è ancora intriso di una forza profetica, è potente, parla alla vita di chi è in ricerca di senso e di “Casa comune”. L’altro riscontro, purtroppo, è che non si è fatto molto per proporlo dentro le comunità cristiane con il rilievo che merita.
D’altronde le generazioni meno giovani – quelle che spesso trainano oggi le comunità – sono in tutti gli ambiti della società quelle che si dimostrano meno sensibili alla conversione ecologica, troppo abituate a viverla come un tema di sfondo rispetto a ben altre priorità e troppo a lungo immerse in uno stile di vita e di lavoro difficile da ripensare. Come traspare bene da un fortissimo passaggio vissuto dalla Chiesa cattolica nel 2019, il Sinodo sull’Amazzonia, è poco probabile poter incarnare questa battaglia se non la si vive sulla propria pelle. Per questo abbiamo ancora bisogno di ridare voce alle culture indigene del mondo, che hanno mantenuto una relazione profonda, spirituale e sociale, con i cicli vitali del cosmo. Le comunità native non “disquisiscono” sul tema, esse lo “sono”, lo incarnano e lo vivono, lo soffrono e lo godono nel corpo e nello spirito.
«La ricerca di vita in abbondanza dei popoli indigeni amazzonici – si legge nel documento finale di quell’assemblea sinodale – si concretizza in quello che essi chiamano il “buon vivere”, il quale si realizza pienamente nelle Beatitudini. Si tratta di vivere in armonia con se stessi, con la natura, con gli esseri umani e con l'essere supremo, giacché esiste un'intercomunicazione tra tutto il cosmo, dove non ci sono né escludenti né esclusi, e dove possiamo forgiare un progetto di vita piena per tutti. Tale comprensione della vita è caratterizzata dalla connessione e dall'armonia dei rapporti tra acqua, territorio e natura, vita comunitaria e cultura, Dio e le varie forze spirituali. Per essi, “buon vivere” significa comprendere la centralità del carattere relazionale trascendente degli esseri umani e del creato, e implica il “buon fare”».
Segni di un cambiamento
Dalla pubblicazione della Laudato si’ nel 2015 la Chiesa cattolica non dovrebbe essere più la stessa. Questo lavoro ha fatto sintesi di cammini, riflessioni, azioni e culture da sempre esistenti e sempre ignorati dai sistemi di potere, di profitto, di materialismo e di capitalismo. Ha ridato centralità per la fede cristiana a una relazione con la Madre Terra che non solo non è eretica, ma è anzi fondante per potersi aprire a Dio e all’umanità in maniera “integrale”. E a proposito di Dio, l’enciclica sulla cura della Casa comune ha contribuito autorevolmente a disvelare una corretta re-interpretazione del mito di Genesi e di altri passi scritturali spesso piegati a un ottuso antropocentrismo. Di Genesi ci consegna in particolare due verbi fondanti del mandato che Dio dà all’umanità nel relazionarsi col Creato: coltivare e custodire. Non basterebbero giorni interi a meditare sull’applicazione di queste due dinamiche a tutti i livelli del nostro vivere comunitario, sociale, economico e anche religioso.
La Laudato si’ ha poi addirittura anticipato il fenomeno Greta Thunberg e tutti i nuovi movimenti per la giustizia climatica sorti negli ultimi 7-8 anni in Europa. Ha dato vita a inedite collaborazioni e corrispondenze con personalità pubbliche non credenti del mondo accademico, economico e scientifico. E in alcune comunità cattoliche ha generato veri e propri sub-movimenti a tema, come il Laudato Si’ Movement o le Comunità Laudato Si’, o specifiche campagne all’interno di movimenti ecclesiali come AGESCI e Azione Cattolica. Un impatto che raramente un documento papale ha avuto negli ultimi decenni.
Nel corso di dieci anni oltre 570 organizzazioni cattoliche in tutto il mondo hanno annunciato il disinvestimento da fonti fossili, aderendo di volta in volta a campagne, appelli e pronunce in occasione di ricorrenze o conferenze mondiali sul clima. La misura di mancati introiti supera ben oltre i 20 miliardi di dollari, oltre il 35% del disinvestimento globale. Questa è forse l’azione di lobbying più tangibile in relazione alla crisi climatica e al surriscaldamento globale. Eppure riguarda ancora soltanto una minima parte delle organizzazioni cattoliche in Europa e nel mondo. Segno di una enorme fatica diffusa a cogliere i segni dei tempi e incarnare – oltre le parole – una buona notizia profetica per l’umanità odierna.
Tutto farebbe presagire oggi un ruolo di primo piano delle comunità e personalità cattoliche a difesa della Casa comune, nelle cui disuguaglianze e turbolenze guidate da pochissimi straricchi soffrono e periscono per primi quei “più piccoli” indicati da Gesù come destinatari di gesti d’amore contro corrente, in quanto «l’avrete fatto a me». Eppure ancora molta è la strada da fare, tanto sugli stili di vita (vogliamo parlare di quante comunità non sono nemmeno in grado di fare bene la raccolta differenziata, o utilizzano le stoviglie monouso, per non parlare di forniture energetiche da fonti fossili o conti correnti nelle banche armate?) quanto nel mobilitarsi e mobilitare persone nelle battaglie politiche locali e nazionali, nelle azioni di denuncia e di disobbedienza civile, nel voto green.
Contraddizioni
Il bruciare delle contraddizioni e delle sfasature come ferite aperte emerge talvolta in qualche scena più iconica. È il caso dell’episodio avvenuto nel marzo di quest’anno, quando due attivisti del movimento Ultima Generazione sono stati condannati in appello dal Tribunale vaticano per essersi incollati al basamento del Laocoonte nei Musei Vaticani per attirare attenzione mediatica e politica sulla crisi emergenziale in corso. «Abbiamo fatto questa azione spinte da amore e cura, assolutamente senza violenza. Che cos’è la violenza? È rimanere indifferenti di fronte allo sfacelo, o è cercare una via per portare l’attenzione affinché il disastro venga arginato? (…) L’accanimento della Città del Vaticano nei confronti degli attivisti climatici è senza dubbio una sorpresa per i cittadini e le cittadine di Ultima Generazione, che comunque continuano a riconoscere nel ruolo di papa Francesco una delle voci più coraggiose e fuori dal coro per quanto riguarda la sensibilizzazione delle persone rispetto all’emergenza climatica».
Oggi per dirla con le parole, nel 2022, del segretario delle Nazioni Unite António Guterres «il tempo stringe, siamo in lotta per la nostra vita e stiamo perdendo. Le emissioni di gas serra continuano a crescere, le temperature globali continuano ad aumentare e il nostro pianeta si sta avvicinando rapidamente a punti critici che renderanno il caos climatico irreversibile. Siamo su un’autostrada per l’inferno climatico con il piede ancora sull’acceleratore». Lo stesso Bergoglio ha sentito l’esigenza di pubblicare un’esortazione “sequel”, Laudate Deum, dove richiama con toni inequivocabili l’inazione delle istituzioni globali e nazionali e l’assenza di reazioni adeguate da parte dei popoli occidentali. La sfida oggi è agire per evitare il maggior numero possibile di morti e sfollati climatici che siamo destinati ad avere.
Contaminazione tra fedi
Che fare allora oggi, noi, a partire dalle nostre piccole comunità più o meno reattive, più o meno frammentate, più o meno motivate? Lavorare a spazi e momenti “ibridi”, contaminabili, dove si ritrovino facilmente insieme diverse fedi, diverse sapienze umane, per avere la riprova di quali battaglie trasversali, di quali percorsi possibili perché ugualmente ci interpellano e accendono. Rinforzare a ogni occasione l’argine popolare all’escalation guerrafondaia dei mercanti di armi, che dominano con la propaganda mediatica e sorvolano qualunque richiesta di trasparenza e democrazia. Riscoprire la pace come disarmo e accordi tra interessi, per salvare vite innocenti ed evitare devastazioni che vanificano ogni progresso civile.Investire energie, esperienze e testimonianze nell’educazione a stili di vita più radicali e integrati; reinventare metodi di pressione politica per contrastare la crisi climatica, i cattivi governanti e i crescenti astenuti a prescindere; favorire progetti di autoproduzione, di gruppi di acquisto solidale e comunità energetiche, di filiere corte ed eque. Nulla di nuovo, ma condannato alla nicchia, mai prioritizzato come via maestra del credente.Rimetterci alla scuola delle tradizioni indigene e delle avanguardie di pensiero interreligioso, unendo la ricerca del “buon vivere” a quella della “vita buona”. E molto semplicemente, camminare di più in natura, fare l’orto collettivo, ricreare il più possibile un sistema alternativo in miniatura nella propria rete territoriale. Fare meno lunghe riunioni, incontri frontali, disquisizioni e sensibilizzazioni eterne chiusi in stanze attorno a tavoli dove ci riempiamo di concetti.
Abbiamo pensato che l’ecologia riguardasse la salvezza della natura, degli animali, del pianeta. Oggi cominciamo a capire – e solo la spiritualità integrale di una nostra relazione con il cosmo, la Presenza, la Vita ci può plasmare in questa consapevolezza – che essa riguarda la ricerca di una nostra realizzazione come creature, di una salvezza come popoli ancora preda di serpenti ingannatori, di un benessere per le nostre famiglie, di una libertà per maturare esistenze piene. Capaci di dare la vita: come il seme che muore e che dunque porta frutto.
Giacomo D’Alessandro è camminatore e comunicatore, è attivo nelle comunità del Forte Tenaglie e del Centro Banchi a Genova, nell’associazione Percorsi di Vita e nel gruppo Luci sul Kivu. Per le edizioni E/O ha pubblicato nel 2023 il libro “Fare quanto è giusto. Le fatiche dei ‘buoni’ nel Paese che declina”. Il suo sito è https://ilramingo.it.
*Foto presa da Unsplash, immagine originale e licenza
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


