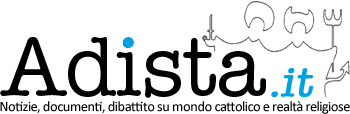Sabra e Chatila negli occhi di chi c'era
Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 32 del 26/09/2015
A metà agosto tre delegazioni italiane sono partite alla volta di Libano, Giordania e Cisgiordania per ribadire il diritto al ritorno dei profughi palestinesi – cacciati nel 1948 e nel 1967 – e dei loro discendenti, nella convinzione che la questione, troppo spesso dimenticata, sia invece centrale per il futuro del popolo di Palestina. Le missioni inizialmente dovevano interessare tutti i luoghi della diaspora palestinese, quindi anche la Striscia di Gaza e la Siria. La ferocia del conflitto che da anni insanguina la Siria ha però sin da subito reso impraticabile questa ipotesi e, a pochi giorni dalla partenza, anche la delegazione diretta a Gaza ha dovuto rinunciare a raggiungere la sua meta a causa della chiusura del valico di Rafah. Di seguito la seconda e ultima parte del resoconto della nostra redattrice che ha partecipato, dal 15 al 22 agosto, alla missione in Libano guidata da Maurizio Musolino del comitato “Per non dimenticare Sabra e Chatila” (la prima è stata pubblicata sul numero 30/15 di Adista Segni Nuovi).
«Hanno ucciso mio padre con un colpo di pistola alla testa. Alla mia vicina di casa incinta di 9 mesi hanno squarciato la pancia. Dei dieci uomini cui ho raccontato quello che stava succedendo e che hanno deciso di andare a parlare con gli israeliani che presidiavano le uscite dei campi, neppure uno ha fatto ritorno».
Jamila mi guarda fisso negli occhi mentre mi dice di far sì che quelle parole non rimangano tra le quattro mura della sua casa. Siamo nel campo profughi di Chatila, alla periferia sud di Beirut. Seduta accanto a lei c'è sua madre, un fagotto di rughe scavate.
La storia che Jamila vuole che racconti è quella del massacro dei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila, di cui ricorre il 33° anniversario: non perché pensa che ci sia qualcuno che non la conosca, ma perché nessuno fino ad oggi ha pagato per quelle 40 ore di sangue.
Verso la strage
È il 16 settembre del 1982. La guerra civile tra cristiani maroniti e musulmani dilania il Libano da sette lunghe estati. Da giugno l'esercito israeliano ha occupato il sud del Paese. A fornire al primo ministro, Menachem Begin, e al ministro della Difesa, Ariel Sharon, il pretesto per varcare i confini e mettere alle strette l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) – che in Libano ha traslocato dopo aver lasciato la Giordania e che è direttamente coinvolta nel conflitto – è l'attentato in cui rimane ferito Shlomo Argov, ambasciatore israeliano a Londra. Ne è responsabile un commando del gruppo di Abu Nidal, ex membro di Fatah espulso da Arafat già nel lontano 1974: l'Olp è dunque totalmente estranea ai fatti, ma il governo israeliano non si lascia sfuggire l'occasione per dire che il Libano va bonificato dalla presenza palestinese. Ad agosto la dirigenza dell'Olp – la cui presenza era sempre stata mal digerita, costituendo di fatto uno Stato nello Stato – accetta di lasciare il Paese a condizione che l'esercito israeliano non entri a Beirut ovest (dove si trovano i campi palestinesi e le sedi e gli uffici dell'organizzazione) e che un forza multinazionale garantisca la sicurezza dei campi profughi, a quel punto privi della protezione dei fedayn e dunque alla mercé dei falangisti cristiani e degli israeliani.
Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, l'Olp, insieme ai suoi combattenti, abbandona il Libano. Ma a dispetto degli accordi presi e delle assicurazioni fornite dall'inviato statunitense Philip Habib, il contingente composto da Usa, Italia e Francia lascia il Paese il 13 settembre, con 15 giorni di anticipo. Neanche 24 ore dopo, il leader delle Falangi Libanesi, Bashir Gemayel, eletto da un paio di settimane – per la gioia di Israele – presidente della Repubblica, viene ucciso da un'esplosione nella sede del suo partito.
L'attentato dà ancora una volta a Sharon l'alibi per rompere gli accordi ed entrare a Beirut ovest. Il 16 settembre l'occupazione della città è completata e i campi sono circondati dall'esercito israeliano. Tutto è pronto per far partire il piano concordato con i falangisti capitanati da Elie Hobeika.
Mancano poche ore al massacro di Sabra e Chatila. Quando la mattina del 18 settembre si porrà fine alla strage, strade e vicoli dei due campi saranno bagnati dal sangue di oltre 2mila persone (la cifra precisa non è mai stata accertata).
Nessuna giustizia
Jamila Khalife, in quel settembre del 1982, ha solo 14 anni. È fidanzata con un ragazzo che poi diventerà suo marito. «Quel 16 settembre ero nascosta in un rifugio insieme a tutta la mia famiglia», ci racconta. «Mia madre, mio padre, le mie sorelle e mio fratello. Quando abbiamo capito cosa stava succedendo siamo usciti. Tutti tranne mio padre. Siamo andati alla moschea per dare l'allarme: dieci uomini che erano lì hanno deciso di andare a parlare con gli israeliani. Non sono più tornati. A mio padre hanno sparato. Quando ho ritrovato mia madre al Gaza Hospital stava piangendo, ma non mi ha detto che papà era morto. Abbiamo dormito lì una notte ma il giorno dopo, non sentendoci sicuri, ci siamo spostati in una scuola».
Complici i razzi illuminanti sparati dall'esercito israeliano, il massacro prosegue incessantemente giorno e notte. Nessuno nel resto della città sa cosa sta succedendo. I soldati che circondano i campi respingono indietro, a morte certa, chiunque provi a uscire.
Uomini, donne, bambini, anziani (palestinesi ma anche libanesi che vivono nei campi e che tentano, inutilmente, di salvarsi mostrando la loro carta d'identità) sono falciati dalla ferocia dei falangisti. Giaceranno a terra, seviziati e mutilati, fino alla fine del massacro. Il caldo di quei giorni di settembre farà sì che molti sopravvissuti riusciranno a riconoscere i loro congiunti solo grazie agli indumenti e agli effetti personali.
Per tanti altri non ci sarà neppure questa consolazione: di molti non si troverà infatti mai il corpo. Così, per esempio, non si saprà più nulla del figlio diciannovenne di Abu Jamal che incontriamo per tre volte e che per tre volte ci mostra la foto di quel figlio perso per sempre.
Solo il 17 settembre cominciano a circolare le prime notizie della strage. Israeliani e falangisti sanno che resta loro poco tempo per tentare di occultare il bagno di sangue. Le milizie cristiane si mettono subito all'opera scavando fosse comuni per nascondere i cadaveri.
Il loro piano però fallisce e il 18 settembre il mondo viene a sapere cosa è successo.
Inutili i tentativi di parte israeliana di scaricare ogni responsabilità: la loro complicità con i falangisti è chiara.
Nonostante lo sdegno internazionale nessuno ha pagato per quel crimine di guerra. Non Elie Hobeika, a capo delle milizie falangiste, che dopo la fine della guerra civile sarà eletto più volte al Parlamento libanese. Non Ariel Sharon che nel 2001 diventerà addirittura primo ministro.
Mentre, con il resto della delegazione, posiamo una corona al memoriale del massacro (creato grazie al comitato “Per non dimenticare Sabra e Chatila" e in particolare grazie all'impegno del giornalista italiano Stefano Chiarini) penso che questa storia meriti ogni parola spesa per raccontarla. Ancora e ancora, come mi dice Jamila.
* La foto ritrae Umm Hussein, una delle sopravvissute al massacro, davanti al memoriale in ricordo delle vittime
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!