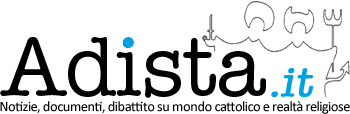Che il popolo si ribelli
- Intervista ad Arturo Rojo Flores e a Daniela Rea
Tratto da: Adista Documenti n° 14 del 16/04/2016
Clicca qui per leggere l'introduzione di Adista al documento
Quello di suo figlio è uno degli innumerevoli casi di persone scomparse. Come è accaduto?
ARTURO ROJO FLORES: Mio figlio, Vicente Rojo Martínez, è scomparso il 21 marzo 2009 a Piedras Negras, nello Stato di Coahuila, insieme ad altre 11 persone impegnate nella vendita di vernici porta a porta, per conto dell'impresa Atlanta Duramex S.A, con sede nello Stato di Messico (uno dei 32 Stati del Paese, ndr). Erano partiti dalla capitale, accompagnati dal responsabile dell'impresa, Daniel Rentería, con tre furgoni Ford 150 ed erano giunti alla città di Sabinas, nello Stato di Coahuila, il 20 marzo. Qui si era fermato uno dei tre furgoni, quello color rame. Gli altri due avevano proseguito verso Piedras Negras, a una distanza di 4-5 ore l'uno dall'altro, con l'obiettivo di riunirsi successivamente. Il 21 marzo l'autista del furgone azzurro chiama Daniel Rentería per dirgli che aveva perso il contatto con i compagni del furgone rosso, i quali non rispondevano neanche al cellulare. Tra loro c'era anche mio figlio. Daniel gli suggerisce di chiedere alla centrale di polizia della città. Il furgone azzurro era parcheggiato a un distributore di benzina di Villa de Fuente, una zona in cui si trovano telecamere di sorveglianza e posti di blocco della polizia, ma, quando Daniel giunge lì, il furgone già non c'era più. Un impiegato del distributore di benzina gli dice che erano arrivati gli uomini della polizia federale, avevano parlato con i lavoratori e li avevano portati via, finché un altro impiegato del distributore non viene a dirgli di tenere la bocca chiusa. Né del furgone azzurro né di quello rosso si è più saputo nulla. Le autorità dello Stato di Coahuila non hanno mostrato alcun interesse al nostro caso ed era chiaro che non volevano che sporgessimo denuncia. La polizia chiedeva invece informazioni su di noi, dove era il nostro alloggio, su quale veicolo viaggiavamo. Ci siamo allora rivolti alla Procura Generale della Repubblica, dove però ci hanno avvisato di non farci illusioni, perché, ci hanno detto, le persone scomparse sono migliaia e migliaia. Abbiamo presentato denuncia presso la Siedo (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) e presso la Commissione Nazionale per i Diritti Umani (Cndh), che l'ha inviata a sua volta alla Cdhec (Commissione per i Diritti Umani dello Stato di Coahuila). A Toluca, la capitale dello Stato di Messico, dove ci eravamo recati per parlare con il governatore Eruviel Ávila Villegas, il Procuratore di Giustizia dello Stato ci ha detto che lì non si poteva far niente, che bisognava andare a Piedras Negras. Ma a Coahuila, in tre anni, sono già cambiati qualcosa come sei pubblici ministeri e ogni volta bisogna ricominciare da capo. Non si registra alcun passo in avanti. Eppure le autorità sanno. Quando nell'ottobre del 2012 hanno ucciso il figlio di Humberto Moreira, ex governatore di Coahuila e dirigente del Pri (il Partito Rivoluzionario Istituzionale ininterrottamente al potere per 70 anni e tornato al governo nel 2012, dopo un’assenza di 12 anni, ndr), mi è venuto in mente di quando ci diceva che capiva quello che stavamo passando: no, lui non poteva capire, gli avevo risposto; per farlo, avrebbe dovuto trovarsi al posto nostro. Così, quando ho saputo della morte di suo figlio, ho pensato: ora sì che capirà come ci si sente. E l'ho pensato senza risentimento.
A partire dal 2006, in Messico sono stati uccisi 56 giornalisti e 16 sono quelli scomparsi. È stato pericoloso scrivere un libro di denuncia come Nadie les pidió perdon?
DANIELA REA: Io non ho ricevuto minacce, ma, durante il lavoro di ricerca e di indagine, qualche rischio l'ho corso, per esempio quando ho realizzato un reportage sui gruppi di autodifesa sorti nello Stato di Guerrero. In generale, comunque, fare giornalismo a Città del Messico comporta rischi molto più ridotti che esercitare la professione negli altri Stati, dove manca qualsiasi forma di protezione. Nella capitale, il rischio maggiore è più che altro quello della censura o dell'autocensura. È nel resto del Paese, dove i governi statali esercitano un forte controllo sui mezzi di counicazione, che i pericoli aumentano in maniera esponenziale. La maggior parte delle minacce sofferte dai giornalisti proviene proprio dalle autorità statali e municipali. Per fare solo un esempio, nello Stato di Chihuahua, la giornalista Patricia Mayorga, corrispondente del settimanale Proceso, è vittima di una violenta campagna di intimidazione e di discredito da parte dei mezzi di comunicazione vicini al governo dello Stato, a causa dei suoi servizi sul lavoro forzato e sulle violenze a danno dei migranti centroamericani e messicani nella Sierra Tarahumara da parte dei narcotrafficanti. In Vera Cruz, dove sono stati già assassinati 14 giornalisti, le minacce e le intimidazioni sono frequenti, come pure le forme di censura. E tutto ciò senza contare che in molti casi si lavora senza contratto, senza copertura previdenziale, senza assicurazione sanitaria e questo aumenta molto l'insicurezza del giornalista.
Una delle piaghe del Messico è quella del femminicidio: dal dicembre del 2006 all'ottobre del 2012, sono state assassinate nel Paese 3.726 donne, per lo più in casi di violenza domestica. Cosa significa essere giornalista e donna?
DANIELA REA: La violenza di genere è un fenomeno molto grave nel Paese, dove un qualunque funzionario può pensare di intimidirti e di minacciarti per il semplice fatto che sei una donna. Riguardo poi alla mia professione, la guerra ha avuto un impatto particolare sulle giornaliste, le quali erano generalmente abituate ad occuparsi di questioni relative alla povertà, all'educazione, allo sviluppo sociale. Così, mentre gli uomini si sono dedicati a coprire gli aspetti della guerra più legati all'aspetto giudiziario, noi siamo state spinte a seguire maggiormente una prospettiva sociale, occupandoci delle persone scomparse, della sorte delle famiglie dei desaparecidos, dell'impatto della guerra sulle scuole, sulle periferie, sui bambini, sulle vedove. E tutto questo ci ha esposto naturalmente a nuovi pericoli.
La recente visita di papa Francesco in Messico è stata letta in modi diversi e persino opposti. C'è chi si è rallegrato per le parole del papa e chi invece ha denunciato il carattere generico delle sue denunce, il suo scagliarsi contro il peccato senza dire nulla del peccatore. C'è chi ha apprezzato la sua silenziosa preghiera dinanzi alla tomba di mons. Samuel Ruiz e chi ha lamentato l'assenza, nel suo discorso, di qualsiasi riferimento all'opera del vescovo degli indios (come pure di Bartolomé de las Casas). E, in particolare, molti sono rimasti delusi per il mancato incontro con le vittime della pedofilia e con i gruppi dei familiari dei desaparecidos. Un dramma, quest'ultimo, che il papa non ha neppure menzionato. Qual è la vostra opinione al riguardo?
ARTURO ROJO FLORES: Il governo ha fatto di tutto per mostrare che in Messico è tutto tranquillo. Non a caso, ad ascoltare il papa, in prima fila, c'era la gente in giacca e cravatta; i poveri e gli indigeni stavano dietro. Papa Francesco si è espresso bene, ma in maniera generica, senza far riferimento alla realtà dei desaparecidos che si registra in tutto il territorio messicano. Perché il fatto è che continuano a sparire persone. E dietro alla tragedia di tutta questa gente che scompare non c'è solo il crimine organizzato, ci sono anche le forze federali. Stiamo parlando di un numero di desaparecidos superiore di tre, quattro, cinque volte rispetto a quello delle 20mila persone di cui è stata registrata la scomparsa. Perché molta gente non denuncia per timore di rappresaglie. E dove è finita tutta questa massa di gente?
DANIELA REA: Il papa si è recato nei luoghi simbolo della violenza che scuote il Paese. È stato in Chiapas, lo Stato segnato da una violenza brutale contro gli indigeni, dalla disuguaglianza e dallo sfruttamento dei popoli originari. È stato a Ciudad Juarez, la città più violenta del mondo negli anni 2010-2011, dove gran parte della violenza è generata dalle forze dello Stato, dall'esercito e dalla polizia federale. È stato a Ecatepec, in una delle regioni maggiormente contrassegnate dalla povertà urbana, dall'emarginazione e dall'esclusione sociale, il municipio con il maggior numero di casi di scomparsa di donne, adolescenti e giovani, e straziato da femminicidi. È stato a Michoacán, il luogo in cui, nel 2006, Felipe Calderón dichiarò guerra al crimine organizzato, quello in cui, il 15 settembre del 2008, durante la festa dell'indipendenza, esplose una granada nella piazza centrale di Morelia, uccidendo 8 persone e ferendone 106, in quello che è stato considerato il primo atto di terrorismo nella guerra contro il crimine organizzato. Luoghi che rappresentano la massima espressione non solo della violenza criminale, ma anche di quella statale e non solo della violenza sanguinaria, ma anche di quella strutturale. Tuttavia, la visita del papa è risultata utile, più che alle organizzazioni per i diritti umani, al governo federale e ai governi statali, i quali l'hanno sfruttata per legittimarsi. Basti pensare all'arrivo di Francesco a Città del Messico: sembrava uno spettacolo di Televisa (il grande gruppo radio-televisivo privato messicano, il maggiore produttore di programmi in spagnolo al mondo, ndr). E il messaggio del papa non è risultato sufficientemente dirompente da svincolarlo da tutto ciò. Sì, è vero che ha ricordato come l'ambizione e i privilegi di pochi producano la miseria di tanti, ma poi a Ciudad Juarez si è riunito con i gruppi imprenditoriali che di quei privilegi sono portatori. E, sì, ha pregato di fronte alla tomba di Samuel Ruiz, il simbolo delle lotte ispirate alla Teologia della Liberazione, ma poi la sua presenza è servita a legittimare il governo del Chiapas. Infine, se anche non riteneva opportuno incontrare i familiari dei desaparecidos, aveva perlomeno il dovere di ascoltare le vittime della pedofilia, cioè le vittime della violenza commessa dalla sua stessa istituzione.
Dalla classe politica fino alla gerarchia ecclesiastica, sembra che le organizzazioni popolari non possano aspettarsi nulla dalle istituzioni messicane...
DANIELA REA: In Messico abbiamo, da una parte, la Chiesa di Raul Vera López, di preti come Pedro Pantoja e José Alejando Solalinde (in prima linea nella difesa dei diritti dei migranti, ndr), di suore come Consuelo Morales Elizondo (impegnata in particolare a fianco delle madri dei desaparecidos, ndr) o Leticia Gutiérrez (anche lei attiva nella difesa dei migrant, ndr) e di tante altre figure che, in varie parti del Paese, accompagnano le lotte dei familiari delle persone scomparse, dei popoli indigeni, dei lavoratori e, dall'altra parte, abbiamo una gerarchia ecclesiastica potente e conservatrice che è sempre servita a legittimare i governi che si sono succeduti e l'attuale guerra contro il narcotraffico. Quanto alla classe politica, non solo non esistono differenze di rilievo tra destra, sinistra e centro – la sinistra che ha governato Città del Messico non si è minimamente distinta nella lotta contro l'impunità e la corruzione – ma è il concetto stesso di Stato a soffrire una profonda crisi. Lo Stato non esiste. Non è mai stato così chiaro, in Messico, come lo Stato non abbia affatto lo scopo di proteggerci. Pensiamo alla grande mobilitazione per una pace con giustizia e dignità svoltasi nel 2011 per iniziativa del poeta Javier Sicilia, che aveva condotto alla discussione di una Legge sulle vittime e alla creazione di una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): ebbene, tutta quella protesta di migliaia e migliaia di messicani decisi a fermare l’escalation di violenza e rigenerare il tessuto sociale e comunitario del Paese cosa ha prodotto? Una legge che non funziona - perché non ci sono risorse, perché nessuno vuole applicarla, perché non c'è castigo per chi la viola -, e una commissione composta da gente che vive sul dolore delle vittime, incapace e insensibile. Né abbiamo speranze di assistere a processi contro i funzionari colpevoli: non c'è in Messico un sistema giudiziario in grado di punire i responsabili. Il governo non indagherà mai su di sé. Eppure, malgrado l'assenza di speranze, siamo comunque determinati a lottare, a imparare a condurre le ricerche, a perseguire la via giudiziaria, a capire, a decifrare la situazione attuale. Non ci fermeremo.
ARTURO ROJO FLORES: L'unica speranza è che il popolo stesso si ribelli. Non tutti sono consapevoli della situazione: se lo fossero, le cose cambierebbero. A me non interessa morire. Con la scomparsa di nostro figlio, è come se ci avessero ucciso interiormente. Però ora non abbiamo più paura, possiamo affrontare chiunque.
Hanno ragione allora gli zapatisti a puntare sulla via della costruzione lenta dell’autonomia territoriale e dell’autogoverno, dell’esercizio della giustizia e dell’attivazione di sistemi di salute ed educazione ai margini del governo statale e federale?
DANIELA REA: Gli zapatisti oggi hanno una visibilità inferiore proprio perché hanno concentrato il loro lavoro all'interno delle comunità. Ma quello che stanno facendo è un esempio che dovremmo seguire anche negli altri Stati per proteggerci dalla nascita di gruppi di autodifesa vincolati al crimine organizzato, dal paramilitarismo, dall'estrattivismo, dal saccheggio dei territori. Il loro messaggio resta attualissimo.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!