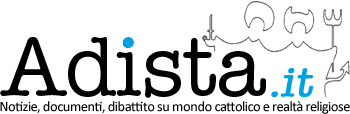Romero sugli altari. Ma, per il popolo, resterà sempre un santo della strada
- Intervista a Fredis Sandoval, Alejandro Díaz, Sofía Hernández e Claudia Martínez
Tratto da: Adista Notizie n° 37 del 27/10/2018
39541 ROMA-ADISTA. Per l'enorme rilevanza simbolica che mons. Oscar Romero riveste non solo in El Salvador o in America Latina, e neppure solo tra i cattolici, ma in tutto il mondo, ci si poteva attendere qualcosa di più delle poche parole spese da papa Francesco per ricordare l'arcivescovo martire: di lui nella sua breve omelia, il papa ha detto solo che «ha lasciato le sicurezze del mondo, persino la propria incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri e alla sua gente, col cuore calamitato da Gesù e dai fratelli». E nient'altro.
Se insomma la cerimonia vaticana voleva essere anche una sorta di riabilitazione dopo l'accanimento mostrato nei confronti dell'arcivescovo dalle gerarchie ecclesiastiche, gli intrighi e le meschinità dell'istituzione, persino la minaccia di togliergli l’incarico o di svuotarglielo, nominando un vescovo coadiutore con pieni poteri – per non parlare poi di tutti gli ostacoli posti, dopo il suo martirio, al processo di canonizzazione – l'operazione è riuscita davvero in maniera parziale.
Per fortuna, a celebrare nel modo migliore la canonizzazione di mons. Romero ci ha pensato il popolo salvadoregno, quel popolo che l'arcivescovo considerava suo maestro e suo profeta: tutto il Paese si è fermato per onorarne la memoria, attraverso le più diverse iniziative, culminate la sera della vigilia con il "pellegrinaggio della luce" in direzione della plaza Gerardo Barrios, la piazza civica di fronte alla cattedrale, a cui è seguita, dopo la messa, la grande festa di popolo, a base di testimonianze, di musica, di canti e di balli e persino di fuochi d'artificio, fatti esplodere al momento della proclamazione della santità di Romero trasmessa sui maxischermi. Un risarcimento pieno, in questo caso, rispetto alla tragica celebrazione del funerale dell'arcivescovo svoltasi in quella stessa piazza, quando, di fronte alla sterminata folla accorsa a dare l’ultimo saluto al proprio pastore, sfidando l'imposizione dello stato d'assedio, la Giunta di governo aveva deciso di mettere a tacere il dolore e l'indignazione popolari, appostando cecchini nel Palazzo Nazionale perché sparassero sulla folla indifesa (con un bilancio di 40 morti e più di 250 feriti).
Di certo la canonizzazione ufficiale, se non potrà aggiungere nulla alla figura di Romero – a proclamarlo santo ci ha già pensato il popolo fin dal giorno del suo martirio –, potrebbe invece dare impulso alla ricerca di verità e giustizia sul suo assassinio come sulle innumerevoli violazioni dei diritti umani commesse durante il conflitto armato interno dal 1981 al 1992.
È da quel 24 marzo del 1980 in cui Romero venne ucciso sull'altare – 24 ore dopo il suo celebre appello ai militari a porre fine alla repressione – che il popolo salvadoregno chiede, ininterrottamente, che sia fatta giustizia. E lo ha rivendicato ancora il 10 ottobre scorso, quando, con una grande marcia dalla piazza del Divino Salvador del Mundo al Palazzo di Giustizia a San Salvador, le organizzazioni dei diritti umani, guidate da Tutela Legal e dalla Concertación Romero, sono tornate a chiedere indagini esaustive, un processo equo, il giusto castigo dei responsabili dell'omicidio dell'arcivescovo: mandanti, esecutori e complici.
Della canonizzazione di Romero, del significato che riveste la sua figura e della lunga lotta all'impunità da parte delle vittime e dei loro familiari abbiamo parlato con i membri del Comitato Salvadoregno per la Giustizia e la Verità giunti a Roma per partecipare alla cerimonia vaticana: il prete salvadoregno Fredis Sandoval, coordinatore della Concertación Romero, l'avvocato di Tutela Legal Alejandro Díaz, Sofía Hernández dell’associazione Codefam (un comitato che riunisce i familiari delle vittime) e Claudia Martínez della Fondazione Share. Di seguito l'intervista.
E ora si spezzi il ciclo dell'impunità: intervista a Fredis Sandoval, Alejandro Díaz, Sofía Hernández e Claudia Martínez
La cerimonia di canonizzazione vaticana è stata all'altezza delle aspettative?
F. Sandoval: Nella sua breve omelia papa Francesco si è riferito in maniera speciale a Paolo VI e a mons. Romero, esempi di una santità non solo personale, ma legata alla missione cristiana nel mondo moderno, post-conciliare. Ancora più breve è stata la formula della proclamazione della loro santità. Una brevità che contrasta con la lunghezza dei processi di canonizzazione, soprattutto di quello di mons. Romero, che tanti ostacoli e attacchi meschini ha ricevuto dentro e fuori El Salvador, dentro e fuori il Vaticano, e anzi più all'interno della Chiesa che all'esterno. In ogni caso, rispetto alla cerimonia vaticana, per assistere alla quale decine e decine di salvadoregni si sono mobilitati da molti Paesi, la veglia che ha avuto luogo nello stesso momento in El Salvador è stata più festosa, con applausi, canti, abbracci e persino fuochi di artificio. Ci ha anche molto rallegrato il fatto che la gerarchia cattolica salvadoregna abbia accettato come slogan di tutte le attività quello proposto dalle organizzazioni: El pueblo te hizo santo. Ci è sembrato un segno di apertura dell'istituzione nei confronti di quanti, come noi, sono stati accusati di strumentalizzare politicamente la figura di mons. Romero. E ci è sembrato significativo che questa scritta sia stata posta sulla facciata del Palazzo Nazionale, di fronte alla Cattedrale, proprio da dove partirono gli spari il giorno del funerale dell'arcivescovo.
Non sarebbe stato meglio celebrare la canonizzazione a San Salvador, per consentire ai poveri di prendervi parte?
F. Sandoval: Romero è pienamente identificato con il suo popolo e la consapevolezza di questo binomio inscindibile è diffusa in tutto il mondo. Celebrare la canonizzazione in El Salvador avrebbe comportato un riconoscimento di questa realtà. Di certo il popolo sperava che così fosse. Il fatto però che si sia svolta a Roma presenta anche aspetti positivi. In Vaticano c'è stato molto accanimento contro Romero, sono circolate molte menzogne, chili di lettere che chiedevano di fermare il processo di canonizzazione. E il fatto che ora la gerarchia, al livello più alto, riconosca l'autenticità della santità di Romero, presentandolo come un modello per il mondo, significa che c'è stata una rettifica, un cambiamento nella riflessione e nell'atteggiamento nei riguardi di Romero e del suo popolo, tanto più importante in quanto l'arcivescovo rappresenta una rottura dei modelli tradizionali di santità. Inoltre, il fatto che Romero sia canonizzato insieme a Paolo VI riveste un grande significato simbolico. Perché Paolo VI è stato il papa che lo nominò vescovo e lo sostenne, gli dimostrò comprensione e lo orientò. E che, dinanzi agli intrighi dei vescovi e della nunziatura, dinanzi alle accuse dei ricchi che lo dipingevano come un comunista e un sovversivo, gli disse: «Coraggio, è lei che comanda». Io penso addirittura che se Paolo VI fosse vissuto ancora, Romero non sarebbe stato ucciso, perché sarebbe apparso meno isolato. E mi spingo anche a dire che, se Romero fosse vissuto qualche anno in più, forse, chissà, non ci sarebbe stata neppure la guerra.
A. Díaz: La canonizzazione è appena una formalità realizzata dalla gerarchia a Roma, perché Romero è santo già da tanto. È una ratifica che accettiamo contenti. Ma ora la sua canonizzazione deve concretizzare l'esigenza di giustizia sul caso del suo assassinio, per riscattarne la memoria e procedere in maniera più decisa sulla via della lotta all'impunità. Il lavoro che ci attende ora è grande, perché molte cose sono rimaste in sospeso rispetto alle misure di riparazione, come la diffusione del messaggio di Romero nei programmi di studio, in maniera che anche i giovani possano conoscerlo.
A che punto è ora il caso Romero? Qualcosa è cambiato dopo l'annullamento da parte della Corte Suprema di Giustizia, nel 2016, della Legge sull'Amnistia promulgata nel 1993?
A. Díaz: Già nel 2000 la Corte Costituzionale aveva stabilito che la legge di Amnistia non avrebbe potuto essere applicata nei casi di lesa umanità e nei crimini di guerra, come il caso Romero, le scomparse forzate, i massacri legati al terrorismo di Stato. Ma per tutti questi anni il ciclo di impunità non è stato spezzato. Poi, il 13 luglio del 2016, la Corte ha riconosciuto l'incostituzionalità della legge di amnistia, evidenziando la necessità di perseguire i crimini commessi, a partire da quelli stabiliti nel rapporto della Commissione della Verità del 1993. È dovuto però passare ancora un altro anno prima che il Quarto Tribunale di istruzione di San Salvador, il 12 maggio del 2007, riaprisse ufficialmente il caso Romero. E neppure allora, in realtà, si sono mossi significativi passi avanti. Per questo il 10 ottobre abbiamo marciato fino al Palazzo di Giustizia sollecitando una decisa svolta nel caso. Quello che chiediamo sono indagini esaustive, un processo equo, il giusto castigo dei responsabili dell'omicidio dell'arcivescovo: mandanti, esecutori e complici. E adeguate misure di riparazione, che, in un'ottica di giustizia transizionale, non necessariamente devono prevedere il carcere. In El Salvador non c'è mai stata giustizia e ora è arrivato il momento che il sistema giudiziario inizi a funzionare.
Cosa si sa oggi dell'assassinio?
A. Díaz: Dopo il Rapporto della Commissione della Verità del 1993, e poi, ancora, dopo quello della Commissione Interamericana dei Diritti Umani del 2000 e dopo il processo civile svoltosi a Fresno, in California, nel 2004 (in cui uno dei responsabili, l'ex capitano Álvaro Rafael Saravia, è stato condannato a versare ai familiari di Romero 10 milioni di dollari), sappiamo che l'omicidio, ordinato dal maggiore Roberto d’Aubuisson, padre degli squadroni della morte e fondatore del partito di estrema destra Arena, era stato pianificato da Saravia insieme al capitano Eduardo Ávila. Sappiamo anche che a condurre il killer fino alla cappella della Divina Provvidenza in cui Romero stava celebrando la messa è stato l’autista di Saravia, Amado Garay Reyes, secondo la testimonianza rilasciata proprio da quest'ultimo, che oggi vive negli Stati Uniti sotto il programma di protezione dei testimoni. E, stando alle rivelazioni del quotidiano Co Latino, nel 2011, sarebbe noto anche il nome del killer: Marino Samayoa Acosta, membro dello staff di sicurezza dell’allora presidente della Repubblica Arturo Armando Molina. Dopo la riapertura nel 2017 del processo giudiziario a carico di Saravia, abbiamo chiesto al giudice istruttore che oggi segue il caso di emettere un’allerta rossa dell’Interpol affinché l'ex militare, che oggi vive nascosto non si sa dove, sia localizzato e deportato. Ma tutto procede troppo a rilento.
Perché è tanto importante che si faccia giustizia nel caso di Monsignore?
A. Díaz: Il caso di mons. Romero è fortemente simbolico. Se non si ottiene giustizia nel caso di una figura come Romero, conosciuta e amata in tutto il mondo, come si può sperare di risolvere i casi dei massacri, delle scomparse forzate, delle violazioni dei diritti di tanti uomini, donne, bambini e anziani anonimi? Vogliamo che le prossime generazioni conoscano cosa è successo realmente, perché senza giustizia e senza verità non potrà esserci mai una vera riconciliazione.
S. Hernández: Durante il conflitto ho perso un marito, una figlia, due fratelli e due nipoti. Noi familiari delle vittime siamo stati abbandonati dallo Stato. Del resto, al Congresso siedono persone che risultano responsabili di massacri e torture. Ma se nel caso di Romero si farà giustizia, tutte le altre vittime potranno sperare di ottenerla. Da parte mia, lotterò contro l'impunità finché avrò fiato.
C. Martínez: In gioco, qui, non c'è una sola persona, ma tutte le vittime del conflitto armato in El Salvador. E l'esigenza di un riscatto della memoria storica del Paese, perché vi sono molti giovani che conoscono appena il nome di Romero, ma non sanno cosa sia avvenuto nella realtà.
La cerimonia di beatificazione del 2015 ha evidenziato un forte tentativo di addomesticamento della figura dell'arcivescovo. E lo ha fatto fin dalla scelta dello slogan: “Romero, martire per amore”, espressione tanto generica quanto evidentemente funzionale alla volontà di superare ogni aspetto conflittuale della sua vita e del suo messaggio. Esiste ancora questo pericolo?
F. Sandoval: La cerimonia di beatificazione non ha espresso in alcun modo lo spirito profetico e liberatore di mons. Romero. Del profeta martire non c'era nulla, a nessun livello. Basti pensare che le suore che lo hanno accolto all'hospitalito (come è chiamato l'ospedale della Divina Provvidenza dove Romero aveva scelto di abitare) non sono state neppure invitate alla cerimonia, a fronte di una nutrita presenza dei prìncipi della Chiesa e del mondo, tra cui ha trovato posto persino Roberto D'Aubuisson, figlio dell'omonimo mandante dell'assassinio di Romero. Il rischio di trasformare Romero in un santo dell'istituzione è reale, ma solo all'interno della gerarchia. Quella che, alla sua morte, lo ha tenuto nascosto e lo ha coperto sotto una coltre di silenzio. Per il popolo è diverso. Per il popolo, Romero è sempre stato un santo della strada. E anche se ora è stato elevato agli altari, resterà comunque presente nel suo popolo, nella lotta per la liberazione e per la dignità delle vittime.
S. Hernández: Non permetteremo che chiudano Romero in una cappella tra incensi e candele. È con il suo popolo che deve stare.
Nel 2009, El Salvador si era trovato a festeggiare, colmo di speranza, la vittoria del primo presidente di sinistra nella storia del Paese, Mauricio Funes, deciso a ispirare la propria condotta di governo al messaggio profetico di mons. Romero. Ma poi né lui, né il suo successore e attuale presidente, l'ex comandante guerrigliero Salvador Sánchez Cerén, sono stati in grado di muovere anche solo qualche passo in direzione del superamento del modello neoliberista e della subalternità agli Stati Uniti, fino alla disfatta del Fronte alle elezioni legislative e municipali del marzo scorso. Cos'è che non ha funzionato?
A. Díaz: Il primo governo di sinistra aveva creato grandi aspettative, ma sono andate deluse. Non si è fatto quello che era stato promesso, neppure a livello di giustizia e di verità e di recupero della memoria storica. Passi avanti ve ne sono stati, in realtà, anche se non tanti come si sperava, ma la guerra mediatica li ha completamente nascosti. Il costo politico è stato altissimo.
F. Sandoval: Romero diceva: se non affonda le sue radici nel popolo, nessun progetto politico potrà avere successo. Una frase che indica in maniera chiara come debba essere il popolo e quali autorità debba avere. Uno dei grandi errori del Fronte è stato proprio quello di non dialogare con i settori sociali, di non raccogliere le loro critiche, di allontanarsi dalla propria base. In più, il popolo non ha perdonato il fatto che molti rappresentanti della sinistra, una volta entrati in Parlamento, abbiano goduto di tutti i privilegi come se nulla fosse. Per la base questo è un oltraggio. Poi, è chiaro, la destra è stata abile a nascondere o screditare ogni successo del governo, grazie soprattutto al pieno controllo sui mezzi di comunicazione. E la sinistra non è stata in grado di trovare mezzi alternativi per smontare o denunciare le falsità diffuse dalla destra nella sua campagna mediatica.
È cambiato qualcosa dopo la grave sconfitta elettorale?
F. Sandoval: Il Fronte ha ricevuto un chiaro avvertimento, ma non ha voluto coglierlo. Io sono sicuro che nel 2019 perderà le elezioni. E che le perderà anche nel 2024. Perché dalla lezione che gli è stata data non ha tratto alcun insegnamento. Non è cambiato lo stile verticista, né il modo di relazionarsi con il popolo. Romero diceva che la sinistra rappresentava gli interessi del popolo, era espressione delle sue necessità, era una luce e una speranza. Ma se, una volta che conquista il potere, si allontana dalla base, il popolo si sente tradito e dice no. Si è persa una grande occasione. Dopo 20 anni di governo di Arena, la vittoria della sinistra esprimeva una profonda esigenza di cambiamento sociale. E il Fronte non ha saputo approfittarne, scegliendo, al contrario, di flirtare con la destra, con i poteri economici, con gli Stati Uniti. Così, la gente che si riconosceva nel Fronte, pur non dando il proprio voto alla destra, semplicemente non è andata a votare o ha annullato la scheda.
* Mons. Óscar Arnulfo Romero y Galdámez in una foto [ritagliata] del 1978 dell'Arzobispado de San Salvador, Congregatio de Causis Sanctorum - tratta da Wikimedia Commons, immagine originale e licenza
fonte: http://www-bcf.usc.edu/~erickjh/images/Mons.%20Romero.jpg;
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!