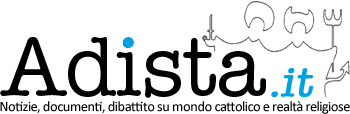Un caso emblematico
Tratto da: Adista Documenti n° 2 del 17/01/2015
(…) Il caso di Frei Tito de Alencar è esemplare dello sforzo sistematico di eliminazione fisica e, principalmente, di annientamento interiore di coloro che erano considerati dai militari nemici della patria. Arrestato il 4 novembre del 1969 in un’operazione realizzata dalla polizia di São Paulo contro i religiosi domenicani accusati di sostenere Carlos Marighella, Tito fu condotto al DOPS-SP, dove sarebbe rimasto circa 40 giorni. Torturato personalmente dal delegato Sérgio Fleury, fu inviato al carcere Tiradentes nei primi 15 giorni di dicembre. In seguito, il 17 febbraio 1970, venne condotto alla sede della Oban (Operación Bandeirantes, principale centro clandestino di tortura e morte di São Paulo, ndt) (…), dove affrontò il periodo più duro delle torture, sotto il comando del capitano Maurício Lopes Lima. In una lettera-denuncia scritta in carcere, Tito espose dettagliatamente le barbare torture fisiche a cui fu sottoposto (…). Ma più che i giorni di violenti interrogatori, denunciò il processo di decostruzione della sua soggettività, come si evince dalle parole del suo principale torturatore: «Volevano lasciarmi appeso tutta la notte al “pau-de-arara” (strumento costituito da una barra di ferro su cui viene appeso il prigioniero, in modo che il palo resti bloccato tra l'incavo delle braccia e l'incavo delle gambe, finché il sangue non circola più, il corpo si gonfia e cessa il respiro, ndt). Ma il capitano Albernaz obiettò: “Non è necessario, resteremo qui con lui altri giorni. Se non parlerà, sarà spezzato dentro, poiché sappiamo fare le cose senza lasciare segni visibili. Se sopravviverà, non dimenticherà mai il prezzo della sua audacia”».
I suoi torturatori gridavano contro la Chiesa cattolica e l’accusavano di aver abbandonato gli insegnamenti del Vangelo. Dicevano che la colpa di Tito era confermata dalla sua resistenza a rivelare qualunque informazione ai torturatori. Affermavano che Tito sarebbe stato espulso dalla Chiesa come “terrorista”: «A un certo punto il capitano Albernaz mi ordinò di aprire la bocca “per ricevere la santa ostia”. Introdusse un filo elettrico. Mi si gonfiò tutta la bocca, tanto da non poter parlare correttamente. Lanciavano insulti contro la Chiesa, dicevano che i preti sono omosessuali perché non si sposano». (…).
Dopo tre giorni di interrogatori e torture, Tito si svegliò il 20 febbraio del 1970 tormentato dalla prospettiva che i suoi confratelli potessero soffrire il suo stesso destino: «Il detenuto al mio lato colse la mia decisione e mi disse di calmarmi. Aveva sofferto più di me (gli avevano schiacciato i testicoli) e non era arrivato alla disperazione. Ma, nel mio caso, si trattava di impedire che altri venissero torturati e di denunciare all’opinione pubblica e alla Chiesa la situazione delle carceri brasiliane. Solo con il sacrificio della mia vita questo sarebbe stato possibile, pensai. Poiché c’era un Nuovo Testamento in cella, lessi la Passione secondo San Matteo. Il Padre aveva richiesto il sacrificio del Figlio come prova d’amore nei confronti degli esseri umani. Svenni per il dolore e la febbre».
Quando si riprese, Tito si servì di una lametta da barba per compiere il suo atto di coraggio. Privo di sensi a causa di tutto il sangue perso, fu condotto alla clinica e poi all’ospedale centrale dell’esercito, dove sentì il capitano Maurício gridare che Tito non doveva assolutamente morire. Rimase sotto la sorveglianza di sei soldati della Oban e, dal momento in cui si riprese, subì la dura pressione psicologica dei suoi torturatori, che presero a definirlo “prete terrorista e suicida”. Ebbe la sensazione che i militari volessero condurlo alla pazzia, per sfuggire alla responsabilità di una sua eventuale morte. In ospedale, ricevette la visita del giudice Nelson da Silva Machado Guimarães, accompagnato da un prete e dal vescovo ausiliare di São Paulo, ottenendo la promessa che si sarebbe indagato sulle sue torture e che non sarebbe più tornato alla Oban (…).
Il 27 febbraio 1970, fu invece condotto, ancora una volta, alla Oban. Successivamente, ritornò al carcere Tiradentes, dove scrisse la sua lettera di denuncia, e lì rimase fin quando non venne scambiato con l’ambasciatore svizzero, Giovanni Enrico Bucker, per emigrare in Cile e, poi, in Italia e in Francia.
Il frate domenicano Xavier Plassat, che convisse con Tito in Francia, ricorda le frequenti accuse di tradimento lanciate contro i religiosi che si erano impegnati in difesa dei diritti umani e nella resistenza all’autoritarismo. Secondo Plassat, «durante il processo contro i frati nell’ottobre del 1970, il pubblico ministero li accusò di essere doppiamente colpevoli: contro la loro Chiesa, a cui avevano disobbedito passando al comunismo, e contro la legge brasiliana di Sicurezza Nazionale, in quanto avevano appoggiato l’Ação Libertadora Nacional. I frati smentirono la loro appartenenza a questa organizzazione e riconobbero solo di aver aiutato alcune persone a fuggire dalla polizia “in nome del Vangelo e in nome dei diritti umani, diritti negati nel Brasile della dittatura” (Fernando Brito e Ives Lesbaupin). Tito venne brutalmente sottoposto a una tortura che inscrive nel suo corpo e nel suo cuore tali accuse, questa doppia negazione degli impegni fondamentali della sua esistenza: il Vangelo per l’essere umano. Dopo le sofferenze, egli temeva di aver parlato troppo e di aver consegnato nuove vittime ai torturatori».
Durante la sua permanenza in Francia, mentre era a Parigi, Tito iniziò a ricevere assistenza psichiatrica. Ma interruppe il trattamento e, nel giugno del 1973, decise di trasferirsi a Lione, in cerca di un ambiente più tranquillo. Fece programmi per riprendere a vivere, integrandosi alle attività della comunità religiosa in cui risiedeva, ma incontrò difficoltà. Il golpe cileno, nel settembre del 1973, scatenò in lui una serie di paure, fino a sentire la voce di Fleury ordinargli di non entrare più nel convento. Internato nell’ospedale psichiatrico Grange Blanche, iniziò un trattamento con i dottori Jean-Claude Rolland e Michel Gillet. Dopo tre settimane, fece ritorno al convento, senza deliri, ma ancora molto angosciato e isolato. Durante l’inverno tra il 1973 e il 1974 tornò due volte in ospedale (…). Nell’agosto del 1974, non resistette più alle lacerazioni spirituali e psichiatriche che la tortura gli aveva provocato. Secondo Plassat, «espatriato (…), ferito nella carne, annientato dinanzi a se stesso nel suo delirio, Tito porrà fine allo shock causato dai suoi torturatori: “Meglio morire che perdere la vita”». (…)
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!