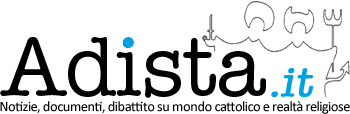IL RISCHIO DI CORTOCIRCUITI
- Intervista ad Antonio Tricarico
Tratto da: Adista Documenti n° 4 del 04/02/2012
Le politiche di austerità portate avanti dal governo Monti serviranno a condurre l’Italia fuori dalla crisi?
Ritengo di no, perché, al di là del fatto che alcune ricette siano palesemente ingiuste, tali politiche permettono solo di vivacchiare un altro po’. Non credo che l’Italia sia in grado di dare un colpo di reni tale da compensare gli impatti delle misure di austerità e reinvertire l’attuale ciclo economico. E penso che prima o poi - se non è il 2012 sarà il 2013, o il 2015 - il debito italiano dovrà subire una ristrutturazione. La domanda è “come”, non è “se”. A livello europeo, lo scenario che stiamo vivendo adesso è caratterizzato dalle cosiddette politiche deflattive, che consistono nel mantenimento di un euro forte e per tutti, nell’applicazione di pesantissime misure di austerità con riduzione della spesa pubblica e nella compressione dei salari, scommettendo sul contenimento del costo del lavoro per aumentare la produttività nei Paesi periferici. Tali politiche, fortemente sostenute dalla Germania e attuate un po’ da tutti in Europa, sono a mio giudizio insostenibili. E per due motivi. Il primo è che l’economia deve comunque essere finanziata, se non dallo Stato almeno dalle banche. Ma le banche sono disposte a fare prestiti per l’economia reale? La risposta è no, perché l’economia reale assicura al massimo, e solo nel caso dei Paesi emergenti, un profitto del 10-12%, mentre l’economia finanziaria garantisce un profitto del 25%. Dunque chi è disposto ad investire nell’economia povera della periferia europea? Il secondo motivo è dato dal fatto che, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, i capitali se ne stanno andando via. E non parlo di Marchionne, ma delle grandi famiglie che hanno spostato i soldi in Lussemburgo e che, se pure fanno economia reale, di certo non la fanno in Italia. Vale la pena ricordare che nel nostro Paese esiste una ricchezza privata che è cinque volte il debito pubblico: se il 20% di questa ricchezza venisse espropriato, avremmo ripagato il debito. Dunque, se il capitale se ne va e le banche non prestano, chi li mette i soldi? Qualsiasi discorso sulla “crescita”, al di là del fatto che il termine possa o meno piacerci, risulta perciò vanificato. E lo dicono gli stessi capitalisti vecchio stampo. Pertanto, il tipo di politica espresso dal governo Monti non funzionerà. Potrebbe funzionare solo in presenza di un sistema bancario in grado di rendere in pochissimo tempo l’economia italiana iper-competitiva in una logica di export globale (una logica che io contesto), tanto da superare anche la concorrenza dei tedeschi e dominare i mercati emergenti. Ma l’Italia non è in grado di farlo. Può vendere le Ferrari, le borse di Furla, ma non può garantire reddito a 22 milioni di lavoratori.
E come si presenta la situazione nell’Unione Europea?
La Germania, l’unico Paese che conta davvero in Europa, sta cercando di imporre le politiche deflattive a tutti i Paesi della periferia e progressivamente anche alla Francia, opponendosi all’idea di restringere pesantemente il sistema finanziario, di affrontare la questione di come ristrutturare le banche europee, di introdurre il controllo di capitali, nella speranza che la politica di austerità basti a rassicurare i mercati. Il fatto è che i governanti tecnocratici europei, accecati dall’ideologia, non sono in grado di concepire nemmeno un piano B.
L’emissione di eurobond potrebbe rappresentare una ricetta utile per la crisi?
La logica degli eurobond (obbligazioni, ovvero titoli di debito, emessi da un ente paneuropeo che provvede poi ad impiegare i fondi raccolti per finanziare i singoli Paesi, ndr) rientra in una prospettiva di socializzazione europea del debito - che tuttavia incontra l’opposizione tedesca - riconducibile a un secondo scenario, quello di politiche keynesiane o neokeynesiane, cioè di politiche espansive sia monetarie (per stimolare, attraverso la riduzione dei tassi di interesse, l'offerta di moneta delle banche alle imprese, e quindi gli investimenti e la produzione di beni e servizi, ndr) che di finanza pubblica (tramite un aumento della spesa pubblica, ndr). Per quanto riguarda le politiche espansive monetarie, però, il tasso di interesse è già molto basso e, per quanto riguarda quelle di finanza pubblica, sono incompatibili con le attuali misure di austerità. In ogni caso, penso che un approccio neokeynesiano non sia sufficiente. E per una ragione molto chiara espressa dallo stesso Keynes, secondo cui si può liberalizzare questo o quel settore, ma non la finanza, che deve rimanere nazionale. Perché una tigre, una volta lasciata libera, non la riprendi più. Le politiche keynesiane possono funzionare, insomma, se la finanza è nazionale. Si dovrebbe, cioè, reintrodurre il controllo dei capitali. Ma questo Draghi non lo farà mai. Non è politicamente possibile, esattamente come non sarebbe stato possibile far accettare ai comunisti il crollo del comunismo. Le forze dei mercati finanziari sono devastanti: non lo permetterebbero.
Quali misure potrebbero risultare più efficaci?
Io penso che il passaggio centrale, che tu sia liberista, keynesiano o marxista, sia quello di nazionalizzare le banche. In realtà, se l’Unicredit dovesse subire un crollo, secondo me verrebbe nazionalizzata. Il problema è che ciò si verificherebbe per interesse non pubblico ma privato, come avvenuto con le banche americane e inglesi, che i governi hanno nazionalizzato per evitare loro la bancarotta, nella speranza che riprenda il ciclo economico per poi rivendere le quote. Metà del sistema bancario americano è controllato direttamente da Obama, cioè dal Tesoro, che però non esercita alcun potere. Gli stessi che gestivano prima le banche continuano a farlo anche ora con la medesima logica di megaprofitto finanziario. Al contrario, io parlo di nazionalizzazione nel senso della creazione di banche pubbliche, banche, cioè, che seguano non una logica di mercato, ma una logica di trasformazione dell’economia fuori dal mercato, per produrre cambiamento nel ciclo economico.
Cosa pensi succederà nel breve e medio termine?
Penso che la ristrutturazione del debito della Grecia non funzionerà, e che ciò sarà evidente già entro la primavera, destabilizzando il mercato dei titoli di Stato e alcune aste di lungo termine, come quella dei Bpt (buoni del tesoro poliennali, ndr). Potrebbe allora porsi il problema di come collocare sui mercati europei più di mille miliardi di debito dei Paesi dell’area euro e più di 800-900 miliardi di obbligazioni di debito delle grandi società europee. Alla fine Draghi potrebbe decidersi per interventi cosiddetti eterodossi allo scopo di arginare il disastro, stampando moneta a beneficio degli Stati, ma saremo sempre sull’orlo del baratro. A quel punto si verificherebbe un’enorme fuga di capitali dall’eurozona, l’euro perderebbe enormemente valore, e i governi potrebbero decidere di riprendere le redini della politica monetaria uscendo dall’euro per svalutare e tentare altre strade.
Tornare alle monete nazionali potrebbe essere una soluzione?
La questione è il “come”. Si esce dall’euro per svalutare e la svalutazione offre un aiuto transitorio. I greci ne avrebbero sicuramente bisogno. Ma sul lungo termine, una volta riacquistata produttività, su cosa scommette la Grecia, su quale politica industriale? Non è che la svalutazione aiuti a ripensare l’economia in maniera sostenibile. Le leve monetarie sono gli strumenti più potenti che ci sono per controllare l’economia e la finanza, ma sono strumenti che, una volta azionati, richiedono tutta un’altra serie di politiche da mettere in campo. Quanto al caso italiano, un’ipotetica uscita dall’euro dell’Italia comporterebbe probabilmente il collasso dell’area euro, trattandosi del terzo Paese più importante, a meno che il piano B della Germania non sia proprio quello di un’eurozona più ristretta, da costruire nel modo meno traumatico possibile per gli investitori e per i mercati.
E per l’Italia l’uscita dall’euro cosa comporterebbe?
Ripercussioni drammatiche possono registrarsi in qualsiasi scenario, anche in quelli che non prevedono default o uscita dall’euro. Se un’asta salta, il giorno dopo Monti fa una manovra che taglia istantaneamente il 20% degli stipendi del settore pubblico… Io sostengo che vi sia un rifiuto ideologico anche solo a menzionare le parole default e ristrutturazione. Eppure, se una persona vittima di un incidente ha una gamba che rischia di andare in cancrena, il medico deve avere la possibilità di decidere se amputarla: è chiaro che sarebbe drammatico, ma sarebbe anche un modo per salvare la vita di quella persona. Sarebbe da irresponsabili escludere l’amputazione a priori. Ciò detto, auspicare l’uscita dall’euro senza valutarne tutte le implicazioni è parimenti da irresponsabili. In tutti gli scenari possibili, il problema principale che potrebbe verificarsi in caso di eventi devastanti sarebbe quello della circolazione della moneta: in poche parole, che non ci sono più soldi al bancomat. Per questo dico che, cautelativamente, nazionalizzare le banche, nazionalizzarle davvero, sarebbe la decisione giusta da adottare. Riguardo al default (si intende per default il fatto che il debitore, o perché non può o perché non vuole, non rispetta gli obblighi contrattuali che ha con il creditore, generando perdite per quest’ultimo), esso può essere guidato o dai creditori o dai debitori. La Grecia sta subendo il primo e sta peggio (c’è gente che non ha più l’elettricità, e parliamo di classe media). Nel caso del default guidato dai debitori, il debitore si arroga il diritto di mettere in sospensione il pagamento di una parte del debito e apre un negoziato. Negli ultimi 150 anni, l’Italia ha operato quattro ristrutturazioni del debito, unilaterali, l’ultima delle quali dopo la guerra. Ma allora i mercati erano nazionali e c’era il controllo dei capitali. Se sei ricco e non hai possibilità di portare fuori i capitali, quando lo Stato ti propone di rinegoziare e riscadenzare il debito, tu non puoi che accettare. Oggi, invece, trasferisci istantaneamente i tuoi capitali a Singapore e tanti saluti. Questa è la differenza: si chiama globalizzazione! Il problema, dunque, è politico: occorre valutare come realizzare il default in maniera da modificare i rapporti di forza a favore dei lavoratori e degli strati più poveri, anziché delle persone più ricche pronte a spostare i propri capitali all’estero. In questo quadro, il punto discriminante è il controllo dei capitali. Nessun default guidato dai debitori può avvenire senza controllo dei capitali.
Ma, come abbiamo visto, questo non sembra politicamente possibile…
Il problema è che il controllo dei capitali è stato abolito già dal Trattato costitutivo della Comunità Politica Europea, a Roma, nel 1953, quando c’era ancora l’Europa a sei. Ripristinare il controllo dei capitali comporterebbe, da parte di uno Stato, una disobbedienza fortissima. Il ricatto principale, si dice, è quello esercitato dei mercati finanziari. Per un certo periodo di tempo nessuno sarebbe più disposto a darti soldi, perché non saresti più affidabile. Proprio per questo bisognerebbe bloccare i capitali, facendo in modo che la ricchezza privata circoli secondo una logica nazionale di interesse pubblico, nazionalizzando le banche, facendo circolare moneta, sostenendo il credito. E c’è chi evidenzia come, a questo punto, l’uscita dall’euro sarebbe d’obbligo, a causa dell’inevitabile ostilità degli altri Paesi europei. Se si esce dall’euro, si procede ovviamente a una svalutazione per acquistare competitività. Se si resta nell’euro, non è possibile svalutare ma si evitano altri problemi, a cominciare da quello dell’inflazione. E poi c’è il problema degli asset produttivi: se un Paese dispone di energia, di materie prime, di cibo, sarà in grado di sostenere la svalutazione, ma se deve importare tutto, e la sua moneta è svalutata, allora gli costerà tutto tre volte di più. Ma quali sono gli asset produttivi italiani? Su cosa l’Italia può strutturalmente fondare la propria economia tramite una politica industriale integrata? Penso che l’Italia abbia sofferto una pesantissima deindustrializzazione, che l’agricoltura italiana, a differenza di quella francese, sia in difficoltà, che tutta l’area dei servizi, che è il settore principale della nostra economia, sia gestita da avventurieri, da soggetti come Telecom che non promuovono in alcun modo politiche di interesse nazionale e da soggetti, come quelli energetici, che vengono gradualmente acquistati da altri. La spina dorsale dell’economia italiana è piuttosto debole e io sono stanco di sentir parlare sempre di Fiat anziché di sistema industriale in generale. Chi aveva i capitali in Italia già è andato via, o con la testa o fisicamente. Chi investe allora nel sistema Italia? Francamente non lo so. Un tale sistema non è economicamente sostenibile e per questo si indebita sempre di più. E di conseguenza per uscirne ha bisogno di una ristrutturazione.
Come si può invertire questo processo?
Per prima cosa, il settore produttivo ha un problema di accesso al credito. Anche le imprese sono indebitate: se non vengono aiutate nessuno può più produrre, creare posti di lavoro o fare qualcosa di diverso dal punto di vista dell’uscita da questo modello di crescita. Quindi torniamo al problema delle banche. In secondo luogo, bisogna avere delle politiche industriali. E se il termine non ci piace, chiamiamole pure politiche di decrescita pubblica. In ogni caso, c’è bisogno di una pianificazione complessiva. Poi ognuno farà la sua parte. Anche in una situazione come quella attuale, tutta in evoluzione, alcune domande, però, si possono già porre. Perché, per esempio, i Paesi della periferia europea non creano politicamente un fronte comune in sede europea? I polacchi hanno puntato i piedi sull’agricoltura e su altre questioni e l’hanno sempre spuntata, anche nei confronti dei tedeschi. Perché l’Italia non si unisce agli altri Paesi periferici per mettere in difficoltà Francia e Germania?
E perché non avviene?
Perché qui assistiamo al fallimento della politica di fronte a sfide che richiedono invece un’enorme capacità di organizzazione di politiche pubbliche. Il vero discrimine tra sinistra o destra sta proprio nell’interventismo in economia, dove interventismo può significare anche banche comunitarie, cooperative… C’è poi anche il problema dell’esistenza di un europeismo naïf che è particolarmente evidente nella sinistra italiana. E dico questo pur considerandomi un europeista, pur essendo disposto, cioè, in nome di un’Europa sociale (ma non in nome di un’Europa delle banche), a rinunciare a pezzi di sovranità nazionale. Il fatto è che non c’è una classe politica all’altezza, non ci sono statisti capaci di battere i pugni sul tavolo. Che poi è quello che fa, con successo, la Merkel. La seconda domanda da porre, anche in un’ottica non necessariamente radicale, è come mai, nel momento in cui le principali banche italiane valgono 35 miliardi di euro e la Cassa depositi e prestiti (la banca pubblica di investimenti di cui nessuno parla, malgrado sia una delle più grandi banche pubbliche al mondo) ha un patrimonio di 252 miliardi di euro, non si proceda a nazionalizzare le banche allo scopo di offrire credito per cinque anni per promuovere attività economiche e creare lavoro. Se il problema è la crescita, al di là del fatto di condividere o meno il concetto di crescita, è singolare che nessuno parli di questo. Che succederà? Che fra un po’ saranno J. P. Morgan o la Deutsche Bank a comprarsele.
Cosa succederebbe se l’Italia procedesse a nazionalizzare?
La Commissione Europea farebbe la voce grossa. Un Paese impegnato a seguire una politica finanziaria di sinistra scatenerebbe l’opposizione spietata delle forze di destra e dei poteri finanziari, magari fino alla stessa eliminazione fisica di un primo ministro. Ma sarebbe una questione politica. Il giorno dopo, cioè, non si fermerebbe l’economia.
Sarebbe, insomma, una strada percorribile…
Vorrebbe dire fare politica radicale di sinistra in un alveo democratico.
E si può dire lo stesso anche per il controllo dei capitali?
Qui si tratta di un problema di politiche europee, nel senso che il controllo dei capitali è vietato all’interno dell’Unione Europea ed è vietato da alcuni accordi internazionali, da clausole del Wto, ecc. Quindi bisognerebbe disobbedire a queste regole, il che significa poi dover pagare sanzioni pecuniarie. E l’Italia, lo sappiamo, è specializzata nel violare le regole europee e nel pagare sanzioni. Nel caso della nazionalizzazione delle banche, invece, questa può avvenire anche senza infrangere alcuna regola.
Come si inserisce in questo quadro la campagna per il congelamento del debito?
Noi sosteniamo tale campagna prima di tutto per la sua valenza culturale e politica: bisogna far partire una discussione su come possa avvenire una ristrutturazione del debito, che è, appunto, una questione politica. In secondo luogo, perché si tratta di un segnale di discontinuità rispetto a quanto sta succedendo oggi. Le politiche di austerità passano infatti in maniera bipartisan e non è rimasto più nessuno a farsi interprete di una rabbia che sta progressivamente montando. È quindi necessario aprire un terreno politico di scontro. Pensiamo che ciò possa avvenire attraverso un processo di audit sul debito pubblico, il che vuol dire verificare chi siano i responsabili di questa situazione e in tal modo capire perché non sia stata fatta una riforma fiscale, quali siano gli interessi che impediscono una ridistribuzione della ricchezza, per quale ragione non si proceda alla nazionalizzazione delle banche e via dicendo. E si fornirebbero così anche i nomi e i cognomi dei responsabili di quanto sta avvenendo. Perché altrimenti rischia di passare l’idea che tutti quanti abbiamo vissuto sopra i nostri mezzi. Ma quando mai!
Il fatto è che lì dove si è avuta un’iniziativa di audit, per esempio in Ecuador, si è potuto contare sul sostegno del governo…
Nel caso del governo Correa, il quale poi ha registrato una decisa svolta a destra, si trattava di un’intelligente misura di pressione prima di negoziare la ristrutturazione del debito. Senza una qualche minaccia precedente al negoziato, infatti, che cosa avrebbe potuto ottenere? Perlomeno l’Ecuador per un certo periodo non ha pagato alcuni interessi e su una parte del debito privato ha strappato un riscadenzamento. La campagna di congelamento del debito, che rimanda un po’ a un discorso di moratoria del pagamento degli interessi, è appunto funzionale a una rinegoziazione. La questione è politica e occorre sollevarla per avere almeno un minimo di voce in capitolo nelle relazioni europee e nelle relazioni con i creditori.
Rimane il fatto che in Italia nessuno a livello governativo appoggerebbe un audit sul debito. E come iniziativa della società civile può avere comunque efficacia?
Per prima cosa si tratta di preparare il terreno iniziando per esempio a creare comitati territoriali. L’idea è che il processo dell’audit, in un momento in cui si registra una crisi fortissima anche a sinistra, serva proprio ad aggregare le forze interessate ad opporsi alle politiche di austerità, fino ad acquisire forza sufficiente per porre la questione nell’agenda politica, con la consapevolezza che prima o poi si procederà a una ristrutturazione del debito e che tale ristrutturazione potrebbe andare ancora più a vantaggio di chi i soldi ce l’ha. Non si tratta di dire: “Non paghiamo e usciamo dall’euro”. È semplicistico. Ci vuole una convergenza sul fatto che sia necessario sdoganare alcuni concetti economici nel loro significato politico per permettere alle persone di capire e per permettere l’avvio di una vera discussione politica.
Non è difficile far convergere forze su questioni tanto complesse, da sempre materia esclusiva degli addetti ai lavori?
Il fatto è che le forze che stanno dietro Monti vogliono completare l’opera iniziata da Draghi (allora direttore generale del Ministero del Tesoro, ndr) nel ’93 (con la privatizzazione del gruppo Sme, azienda pubblica controllata dall'IRI con una quota del 64%, ndr): le privatizzazioni in Italia. L’Italia è un Paese in cui c’è ancora molta ricchezza da privatizzare e, di fronte alla crisi generale di accumulazione del capitale, si punta a svendere ciò che è pubblico creando nuovi mercati. Di questo ha bisogno il capitalismo nell’attuale fase storica. Quello che si chiama capitalismo finanziario. In Italia la vera strategia è quella di privatizzare sistematicamente tutti gli enti pubblici locali, fino ad arrivare, ma se ne parlerà fra 7-8 anni, alla privatizzazione dell’Inps. Intorno a questa agenda, che lentamente si renderà sempre più visibile, si possono aggregare, a partire magari dal movimento per l’acqua, resistenze e controproposte. Questa crisi, per il suo carattere sistemico, può generare cortocircuiti incredibili, cosicché anche una questione come quella del default greco è in grado di innescare dinamiche che oggi non prevediamo, ma a cui si potrebbero dare risposte radicali, nel bene e nel male. Questi sono i contesti in cui nascono i fascismi, ma sono anche quelli in cui nascono le rivoluzioni d’ottobre. Perché sono talmente ingestibili che non si sa dove andranno a finire. Ed è la prima volta che ciò avviene. Per questo credo che abbia senso investire in questo processo: per disporre di forze sufficienti qualora avvengano cortocircuiti improvvisi, qualora la situazione diventi drammatica e la gente non trovi più i soldi al bancomat.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!