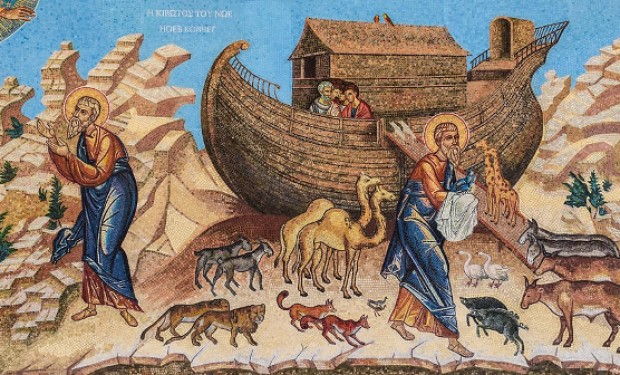
Economia nonviolenta: educhiamoci!
Tratto da: Adista Documenti n° 44 del 23/12/2017
Per l'introduzione a questo articolo, clicca qui
Ho visto un’insegna di macelleria arrugginita sopra una serranda da tempo chiusa. Ho visto una gabbia per polli riconvertita a protezione di piantine in crescita e una gabbietta da canarini diventata lanterna. Ho visto un allevatore da carne passato cuore e bagagli alla produzione di ortaggi. Ho visto progetti per la coltivazione di alghe al posto della pesca. Ho visto un frutteto là dove uccidevano gli agnelli. Ho visto un gruppo d’acquisto di prodotti solidali senza componenti animali. Sono piccoli segnali di riconversione produttiva verso un’economia di liberazione per tutti gli esseri (nei limiti del possibile). Occorrerà una vera rivoluzione, per arrivare a un sistema di produzione e consumi mondiali che risparmino sofferenze e sfruttamento a umani e animali. Un sistema di beni comuni anziché di mali individuali. Ma ne vale la pena. Un’economia nonviolenta non salva solo animali, salva umani, salva la salute, nutre tutti, difende l’ambiente.
Luoghi e numeri pesanti
Ci guardiamo intorno nel piccolo e vediamo sempre più consumatori etici, e relativi produttori. Quasi una moda! Ma se allarghiamo lo sguardo, il trend a livello mondiale sembra essere l’opposto.
Tre trilioni di pesci sono estratti annualmente dalle acque della Terra. Per metà estratti da mari quasi desertificati, per metà allevati in impianti di acquacoltura.
Sulla terraferma, stalle, macelli, concerie, gabbie. Sessanta miliardi gli animali di terra allevati ogni anno nel mondo. Sappiamo fino alla nausea che gli animali sono una fabbrica inefficiente di proteine e calorie. E che le stalle sono energivore, idrovore, inquinanti. C’è una concorrenza fra 5 usi dei suoli, e dell’acqua: cibo per gli umani, cibo per gli animali, combustibili per i motori, foreste, altre produzioni agricole. Mentre siamo in piena crisi climatica, idrica, alimentare, il 78% delle terre agricole del pianeta è destinato al bestiame, sotto forma di pascoli o di colture mangimistiche.
C’è un giro forsennato di mangimi o animali o loro parti, in un mondo che produce 300 milioni di tonnellate di carne (dai 100 del 1970). Dall’America Latina parte la soia per gli allevamenti in Cina. Dall’Australia partono ogni anno 4 milioni di pecore verso i macelli dei petromonarchi. Dall’Africa partono mangimi per le stalle europee. Da Asia e America Latina parte il cuoio conciato al cromo per le eleganti pelletterie europee.
Sulla pelle degli animali i lavori delle “5 P”
Molti dei lavori detti “delle 5 P” (pesanti, pericolosi, precari, penalizzati socialmente, pagati male) si concentrano nella complessa filiera zootecnica e ittica, epicentro della sofferenza animale.
I lavori zootecnici lato sensu sono così spiacevoli che quasi nessun consumatore li assumerebbe su di sé. Si delega a qualcun altro il lavoro sporco. Sono attività spesso scaricate su categorie deboli. Si pensi agli intoccabili in India o ai migranti in Italia (i sikh indiani negli allevamenti da latte, i bengalesi e senegalesi nelle concerie e nei macelli).
Nel suo intramontabile libro The Jungle scritto nel 1906, Upton Sinclair fu il primo a occuparsi dell’intreccio fra lo sfruttamento dei lavoratori e le sofferenze degli animali da essi “lavorati”, nella fabbrica di smontaggio di viventi chiamata macello, che a Isaac B. Singer ricordava i campi di sterminio. Nei macelli, più o meno meccanizzati, sangue, urla, gesti difficili da compiere, sono allontanati dalla vista e spesso coperti solo da stranieri, soggetti oltretutto a fenomeni di caporalato, ritmi pesanti e malattie professionali in agguato.
Nei processi post-mattatoio gli animali non soffrono più, i lavoratori sì. Soprattutto nel sud del mondo i poli conciari sono fra i posti peggiori dove vivere e lavorare. Gli addetti sono esposti a sostanze chimiche altamente tossiche come cromo, formaldeide, sbiancanti; si ritrovano con malattie respiratorie e della pelle, rischiano di mutilarsi. I contadini delle aree circostanti sono rovinati dai veleni. Ma anche in Italia le concerie hanno un’elevata densità di migranti, più disponibili a sopportare lavori spiacevoli e usuranti.
Cibo per il futuro di tutti. Un’economia della liberazione passa anche dall’abbattimento, certo graduale, dei consumi alimentari di prodotti animali e dal relativo sistema produttivo.
Anche il lavoro agrozootenico e ittico – che pure coinvolge centinaia di milioni di persone nel mondo, a tempo parziale o totale può essere riconvertito, come ogni altro. Nelle produzioni vegetali è anche più facile sviluppare meccanismi come la vendita diretta e il ciclo corto (pochi passaggi fra produttori e consumatori), affrancando chi lavora la terra.
Come ci si arriverà? Combinando scelte di consumo etico da parte delle masse e decisioni politiche a tutti i livelli: stop alle sovvenzioni agli allevamenti intensivi e incentivo alle produzioni vegetali.
Rivoluzione sott’acqua. Le alghe non sono solo i capelli delle sirene, ma un antichissimo cibo acquatico da valorizzare. Alcuni esempi. Sulle coste dell’Eritrea si stanno coltivando piantagioni di salicornia, alga iperproteica e saporita, una sorta di asparago di mare, che oltre ad assorbire anidride carbonica (il clima ringrazia) si mangia da giovane come verdura fresca, e più in là dà farina e olio da cucina, e perfino sostanze cosmetiche. Come nel caso della cattonii, che sulle coste del Mozambico dà reddito sostitutivo della pesca. Al freddo, in Bretagna, prospera la raccolta di alghe fra le quali la deliziosa dulce. In Burkina Faso come a Cuba, la spirulina, alga d’acqua dolce coltivata, è un prezioso integratore alimentare (ci arriva con il commercio equo). A quando la raccolta delle alghe in Italia? Certo occorre tener puliti i mari. Ma questo vale anche per i pesci!
Pelli assurde. I mali più impresentabili, puro orrore, sono quelli a base di pellicce – di animali selvatici o allevati – e di pelli di animali esotici. Perché i loro proprietari legittimi sono straziati apposta per essere scorticati. Gli allevamenti da pelliccia sono vietati in Olanda, Gran Bretagna, Austria e Croazia. Il traffico di esotici è vietato quasi ovunque.
Quanto al cuoio, pesante sottoprodotto degli allevamenti, sfatiamo un mito: la metà di quanto conciato nel mondo non serve per le calzature. Ma per oggetti sostituibilissimi.
Le borse di pelle? Possiamo comprare o autoprodurre assortimenti sconfinati di accessori in tela resistentissimi, multicolori, lavabili. Bene anche il caucciù prodotto dai seringueiros amazzonici, o da recupero di pneumatici.
E mettiamo fra le pelli assurde anche gli stivali. Tanto cuoio per niente! E se vogliamo andare nel fango e nell’acqua, meglio quelli di gomma.
Per i piedi del futuro.
Diverse case usano ormai il cosiddetto “cuoio vegan”. Vegan, non vegetale, perché si tratta di materiali di sintesi. Chissà se è la soluzione... Magari scandalizzando qualcuno, vi diciamo la nostra, di soluzione: spezziamo una lancia a favore dell’usato. Mercatini solidali come quelli di Mani tese ed Emmaus offrono scarpe praticamente nuove. Ce n’è un giacimento… e in questo caso, possiamo anche dir di sì al cuoio, finché il giacimento non si esaurirà!
Abbigliarsi eco. No alle pellicce (anche quanto sono "travestite" da inserti di pelo su polsini e collo dei giubbotti): è ancora necessario dirlo?
No ai cow boy in pelle e cuoio. No alla seta, con i bachi bolliti vivi (anche se continuiamo a sperare che almeno gli insetti non soffrano…).
Sì agli abiti di fibre vegetali: canapa, lino, cotone (nelle diverse lavorazioni compresi velluto e ciniglia). Se nuovi, facciamo lo sforzo di trovarli bio, equi e con colori naturali (nelle botteghe del commercio equo). Il cotone a buon mercato nasconde sfruttamento umano e ambientale. Evviva la canapa, fibra del passato e del futuro (http://www.sativabags. com). Sì alla viscosa, dal cascame dei pioppi.
Sì agli abiti usati: le loro eventuali colpe ricadono sui primi fruitori!
Sì al cosiddetto “pile”! Uno dei modi più simpatici di riciclare la plastica. Non dà allergie, ed è così caldo e avvolgente.
Sconfiniamo nel piumino per il letto. Evitiamo come la peste le piume strappate alle oche e preferiamo imbottiture vegetali magari in fibra di mais.
Salute, cosmesi, igiene. Dirà qualcuno: “Finché BigPharma (i colossi multinazionali del farmaco) sperimenterà le nuove medicine sugli animali, dovrei evitare di curarmi?”. Il sottointeso è che l’unica cura seria sia quella allopatica. Però, senza volerci pronunciare sui casi gravi, di risposte per il resto ne abbiamo: 1) la prevenzione è quasi tutto (e come farla, lo spiegano diversi libri delle edizioni Sonda); 2) l’omeopatia e altre discipline cosiddette “alternative” non sperimentano su animali ma su umani sani; 3) l’Italia è affetta da un grande consumismo farmaceutico: salvo eccezioni, bisognerebbe tenere un po’ più vuoto l’armadietto dei medicinali; 4) in ambito allopatico, meglio scegliere i farmaci generici (la vivisezione riguarda i brevettati). Cosmetici. Dall’11 marzo 2013, in Europa è entrato in vigore il divieto totale per i test su animali degli ingredienti realizzati per i prodotti cosmetici. Rimane comunque valido lo Standard Internazionale crueltyfree e il relativo elenco delle ditte da preferire, perché vi sono alcuni casi non coperti e comunque il divieto non vale per i detersivi. L’elenco si trova qui: http://www.consumoconsapevole. org/cosmetici_cruelty_free/lis ta_cruelty-free.html
Se poi la nostra cosmesi, i nostri prodotti d’igiene, i detersivi e detergenti che usiamo ogni giorno li vogliamo ecologici da cima a fondo, allora scegliamo prodotti semplici, poco imballati, fatti da piccoli produttori o da noi stessi a partire da semplici materie prime: oli e oli essenziali per la cosmesi, aceto, sapone e bicarbonato per l’igiene.
Cruelty free-usciamo dalle merci violente
A studiare il ciclo dei prodotti e dei processi produttivi diventa evidente che hanno innocue apparenze anche merci violente la cui produzione, uso e smaltimento danneggia piante, acqua, terra, aria, lavoratori. E alla fine animali.
Il troppo consumo di una civiltà estrattivista uccide, con l’inquinamento e la distruzione degli ecosistemi, innumerevoli creature di terra e d’acqua: dunque la semplicità di vita è nonviolenta. Lo spreco di combustibili fossili porta tragedie come la guerra e il caos climatico (e relativa siccità mortale) oltre a inquinare i mari: dunque uscire dalla civiltà del petrolio è economia di pace. L’agricoltura industriale è violenta: dunque i prodotti bio (se possibile senza letame) sono da preferire. Molte sostanze chimiche – presenti in tante merci e imballaggi – sono una iattura per la natura: evviva le alternative ecologiche. L’eccesso di tecnologia “di consumo” e la relativa fame di coltan aiutano una guerra in Congo che uccide milioni di esseri umani e migliaia di gorilla: sì ai vecchi modelli, e al riuso.
Last but not least: è evidente che l’economia rispettosa non prevede gabbie. Nemmeno quelle degli uccelletti o criceti “da compagnia”.
I cinque sensi aiutano
Una delle tattiche più utili per convincersi e convincere al cambiamento in direzione ecologista e sociale è presentarlo come piacevole. Il contrario di un sacrificio. Un più, non un meno. Scegli buone pratiche; l’abitudine te le renderà piacevoli.
Un’economia nonviolenta è senza dubbio più gradevole per i cinque sensi.
Ora, ammettiamo che a diverse persone il gusto dei prodotti animali risulti gradevole al senso del palato. Rimangono gli altri quattro sensi. Che certo si ribellerebbero al consumo di carne, pesce, derivati animali, cuoio e lana se la filiera produttiva, dall’animale vivo al piatto o alla scarpa, dovesse essere autogestita dal consumatore finale. Solo la delega dell’orrore a qualcun altro permette certi consumi. Se dovessimo fare da noi… Se nessuno accettasse più di delegare ad altri il lavoro sporco cesserebbero di colpo molte violenze sulla "comunità di chi vive": umani, animali, alberi, ambiente. Pochissimi inietterebbero veleno a un condannato o bombarderebbero una città; relativamente in pochi macellerebbero un maiale, asfissierebbero un tonno tirandolo fuori dall’acqua, scuoierebbero castori; non molti abbatterebbero foreste o getterebbero secchiate di veleni nei fiumi. Ma, delegando, tutti contribuiscono a torture e uccisioni.
Il tatto proverebbe ribrezzo nel toccare carni morte, sangue, squame, cuoio con carniccio, lana con parassiti. La vista inorridirebbe, negli allevamenti come nei macelli, sulle navi da pesca come nei laboratori di concia. L’udito non reggerebbe ai lamenti. L’odorato soffrirebbe al sentore della carne e del pesce crudo di macello o pescheria, al mal odore delle stalle e delle pelli.
Non nuocere, prevenire, lenire
Per costruire l’economia delle liberazioni, il consumo etico è certamente il primo gradino – per citare Lev Tolstoi –. Ma la scala continua. Intanto bisogna promuovere il consumo etico organizzato (con i gruppi di acquisto). E magari lanciarsi in un lavoro nelle produzioni etiche: cibo e scarpe, libri e vestiti, mense e cosmesi.
Inoltre occorre militare. Ci vogliono eco-attivisti impegnati in azioni “politiche” mirate al cambiamento delle leggi, delle tecniche produttive, dei comportamenti e modelli di consumo. Tutto per accelerare i tempi… anziché aspettare che sette miliardi di umani si convertano da sé.
Impossibile elencare le attività possibili. Ci permettiamo dunque di segnalare il libro Diventare come balsami, stessa autrice di questo articolo. La stella polare, ambiziosa e modesta, del libro è ridurre la sofferenza nel mondo, avendone chiaro il panorama. Questo è essere balsamici. Le ricette sono divise in tre parti. Prima di tutto, non nuocere (alimentazione, consumi rispettosi, comportamenti cruelty-free, educazione). Secondo, prevenire (economia non violenta contro le guerre, impegno contro la pena di morte e altre violazioni dei diritti, antispecismo teorico e – soprattutto! – pratico). Terzo, lenire (soccorrere con interventi umanitari grandi e piccoli, internazionali e locali; e liberare dal dolore della prigionia, umana e animale – basta con le gabbie!).
* Marinella Correggia è ecopacifista, giornalista e autrice, da decenni si occupa di giustizia ambientale e climatica, restituzione internazionale, lotta contro la fame e modelli alimentari, rispetto dei viventi, stili di vita ecoequi, prevenzione dei conflitti, temi su cui ha scritto numerosi libri. Collabora con la rivista Altreconomia, il quotidiano il manifesto, vari siti. Si dedica al progetto “Verità contro le guerre”.
Arca di Noè, mosaico russo fotografato da dimitrisvetsikas1969, tratto da Pixabay, immagine originale e licenza
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


