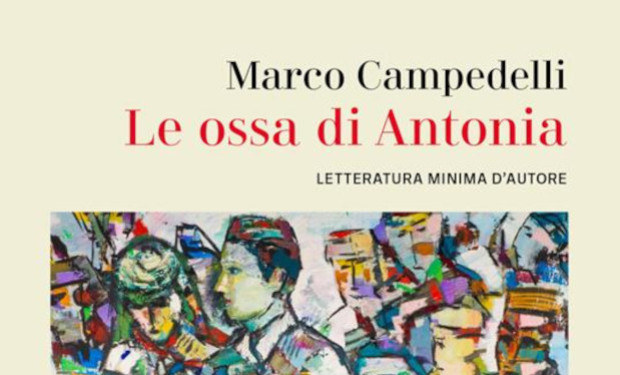
"Le ossa di Antonia": le storie che riscrivono la Storia. L'ultimo libro di Marco Campedelli
(con Valda Lippa Campedelli)
In principio era il corpo. Non certo quello astratto dei dogmi, tanto meno quello idealizzato ed etereo delle statue dei santi, ma il corpo semplice e resistente di Antonia, bisnonna contadina dell'Altopiano di Asiago, donna di terra e di fede, intessuta nella trama profonda della memoria familiare. Le ossa di Antonia – titolo dell’ultimo libro di Marco Campedelli (Marietti1820, 2025, pp. 192, 17,50€) – non sono reliquie da venerare, ma un patrimonio di radici da ascoltare. Davanti a questo altare domestico alla carne e alla parola, alla genealogia femminile che ha custodito nel silenzio la dignità del vivere e del credere, la teologia si fa narrazione (e viceversa), la poesia (che è in primo luogo azione, come sottolinea Vito Mancuso nella prefazione) si fa liturgia laica, e la Storia – quella mai scritta, di chi le guerre le ha subite – riemerge da sotto i piedi, dalle ossa appunto, che reggono la postura di un’intera umanità dimenticata.
È proprio sull’asse portante del corpo e della voce di una donna, Antonia, la sua bisnonna, che Marco Campedelli, teologo veronese, narratore, scrittore, burattinaio (tra i suoi libri, il Vangelo secondo Alda Merini, Il Vangelo secondo Dario Fo, le suggestive rubriche su Adista Segni Nuovi “Parole a margine” - confluita nel volume Lessico disobbediente - e “Più forte ti scriverò”) disegna qui una galassia di riferimenti vitali grazie a un racconto che riesce a tenere insieme dimensioni diverse ma tutte ugualmente e strettamente necessarie: poesia, carne e politica nel senso più alto.
Ma questo libro, che raccoglie una serie di scritti pubblicati sulla rivista Rocca negli ultimi due anni e si presenta come un insieme coerente di meditazioni all’incrocio tra narrativa, poesia e riflessione teologica e politica, è più che un semplice racconto: è un’evocazione. Una sorta di midrash contemporaneo. Un’alleanza fra la Scrittura e le vite di uomini e donne non necessariamente illustri, non necessariamente credenti, in una scrittura che è insieme denuncia e carezza, invettiva e canto di speranza. Nasce così la costellazione di icone sacre di Campedelli, un pantheon terreno che prende corpo e vita in 27 ritratti. Figure appartenenti al mondo letterario, teologico, della pedagogia, della politica, dell’arte, che hanno incarnato i valori davvero “non negoziabili”: non certo quelli sbandierati dal card. Ruini come vessillo identitario del cattolicesimo, ma quelli che hanno nel Vangelo, nella Costituzione, nella “bellezza morale”, nella cura per l'individuo e la società il loro radicamento. Quelli che «servono il mistero», che scavano, nella profondità del silenzio, parole e azioni al servizio della bellezza, della sapienza. Dell'amore. Una “letteratura minima”, come recita il sottotitolo del libro, «che costituisce il nostro immaginario collettivo ed è diventata parte di noi, delle nostre vite», arrivando spesso a salvarle, scrive Campedelli, perché «ci hanno aiutato a tenere la bussola delle libertà, il sale della democrazia, l’inquietudine della ricerca» e sono diventati «pane per tutti». Questa “letteratura minima” – che spesso è anche grande letteratura – è generata da quell’«immaginazione» che potrebbe diventare «prassi di liberazione», perché ci racconta contro-storie che possono «raddrizzare il piano inclinato nel quale rischia di scivolare il mondo». Da Mario Rigoni Stern a Luigi Meneghello, da Aldo Moro a Ignazio Silone, da David Maria Turoldo ad Alda Merini, da José Maria Castillo a Marcelo Barros, a Pasolini, a Dostoevskij, a Ermanno Olmi, audacia, libertà e immaginazione sono il minimo comune denominatore di una postura che incarna quella “laicità del Vangelo” espressa dal rifiuto di Gesù di diventare prigioniero di una religione centrata sul giudizio morale e da un’idea di trascendenza attraversata dalla solidarietà profonda con tutti i crocifissi del mondo.
Antonia, la radice e il senso
Antonia, fulcro simbolico del libro, è una figura femminile potente, ma non idealizzata. È fatta di carne, di dolore, di maternità, di parole inghiottite. E di lotta, resistenza femminile, “bellezza morale”, visionarietà. È un “anello forte” della stessa catena di cui parla, nel suo libro sulle donne del Cuneese tra ‘800 e ‘900, Nuto Revelli («Credevo di raccontare l’anello debole, invece ho trovato l’anello forte della catena», scriveva nella prefazione). Antonia non è Maria, né Marta, né Maddalena, ma le contiene tutte. È una donna «che non parla ma che ha molto da dire». È una donna che ha fatto la stessa guerra delle cuneesi di Revelli, una guerra mai registrata nei libri di storia, mai dichiarata ufficialmente, «coi figli da crescere e il pane da trovare», come disse una di loro. Sopravvissuta a una storia di abbandoni e di silenzi, Antonia è la voce di tutte le donne alle quali la religione, la politica, la cultura hanno chiesto solo di sparire e tacere in una vita invisibile, spesa nel servizio e nel sacrificio. Le sue ossa, però, come nella visione del capitolo 37 del profeta Ezechiele, non sono resti inerti: parlano, cantano, annunciano, gridano. Diventano strumenti e soggetti di memoria e di resurrezione. In questo senso il libro di Campedelli è profondamente femminista. Una definizione che non incasella, ma apre possibilità e sguardi nuovi, non temendo di mettere in discussione il linguaggio, l’autorità, le incrostazioni dottrinali che sfigurano il Vangelo, nella prospettiva di una teologia incarnata, che deve liberare e non opprimere.
L’universo di Antonia è nei luoghi terreni e sacri (ma non sacralizzati) della vita: la cucina, la casa, la chiesa di paese, il cimitero. La vita accade in uno spazio teologico, ogni gesto quotidiano diventa sacramento. È una teologia della terra, in cui il corpo femminile non è più un simbolo da controllare, ma un luogo di rivelazione. Anche la maternità, mai idealizzata, tanto meno assunta a perimetro del “genio femminile” di wojtyliana memoria, si ribella a qualsiasi retorica ed è rappresentata in modo quasi tattile, sensoriale: la fatica, il dolore (un travaglio lungo una vita, come quello della nonna di Marco, Albina, che non smise di aspettare il figlio disperso in guerra), ma anche la speranza ostinata, la creazione continua. Antonia ha generato nella carne e nello spirito, ha sofferto per tutti, eppure il suo eroismo quotidiano non è di quelli che normalmente ricevano onori o incensazioni. È la madre che resta, che “sta” (Stabat mater… iuxta crucem) anche quando il figlio si fa lontano; è la radice nascosta e attiva che “tiene” la terra per quelli che verranno.
È qui che emerge uno degli aspetti più forti del libro, l’humus nel quale si forma l’alfabeto affettivo, culturale e ideale di Marco Campedelli, addestrato fin da bambino a vedere l'invisibile nel visibile, la parte più profonda del reale. C'è qui una radicale messa in discussione di un modello religioso che dimentica il corpo e la voce degli ultimi, delle donne, che le spiritualizza per renderle innocue, che spegne la creatività e la forza della loro fede, destabilizzante per il potere. È l’aspetto “sovversivo” del libro, nel senso etimologico di sub-vertere, “capovolgere dal basso”, rovesciare, come la Maria del Magnificat che sa vedere la forza sovversiva di Dio che deposuit potentes de sede, καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων, ma che è stata schiacciata, minimizzata, persino caricaturizzata da una secolare teologia clericale, funzionale agli interessi di una istituzione androcentrica. Ma questa è un’altra storia, anche se le premesse sono tutte in questo libro, dal quale scaturisce l’idea di un’ecclesiologia diversa per una Chiesa “altra”, plurale, relazionale. Un’ecclesiologia che valorizza il margine, la tenerezza, il fuoco tenuto vivo dalle “Antonie” di ogni tempo. Marco Campedelli ci dice che senza la voce dei dimenticati e delle donne – e delle donne ferite – nessuna Chiesa può davvero risorgere. In un’epoca come questa, in cui ogni giorno una scioccante litania presenta nomi e volti di persone offese e marginalizzate o uccise dal clericalismo – in buona parte responsabile degli abusi e delle varie forme di violenza sistemica nella Chiesa – e in cui sta crescendo da tempo la richiesta di giustizia di genere e di un maggiore spazio per i laici, Le ossa di Antonia restituisce alle donne, e a tutti i dolenti e gli esclusi, nella Chiesa e fuori, la dignità di essere portatori e portatrici della Parola e delle parole di liberazione, un atto di resistenza civile e culturale. È un gesto liberante e liturgico: rimettere la Scrittura sulla bocca dei dimenticati, anche se sono ormai ridotti a ossa. Perché proprio lì, nel secco del dolore senza più lacrime e della dimenticanza, nelle storie di chi fa veramente la Storia, può tornare il soffio dello Spirito.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


