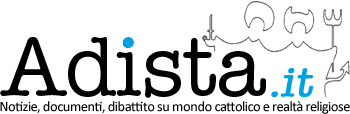Un mondo da disfare
Tratto da: Adista Documenti n° 12 del 28/03/2015
Clicca qui per leggere l'introduzione di Adista al documento.
Gli esseri umani sono cantastorie. Siamo plasmati dalle storie, che vengono sempre fabbricate e che solo qualche volta sono vere. Nella narrazione, conta l’inquadratura che si sceglie: dobbiamo decidere da dove cominciare a raccontare la storia, da quale prospettiva, quali dettagli includere e quali omettere. Il modo in cui scegliamo di raccontare una storia ne modella il senso. Mondi interi sorgono e crollano dietro alle storie.
La supremazia bianca sopravvive in parte grazie alle storie. I bianchi declamano una serie di storie condivise ponendo l’accento su metafore comuni, interpretate dallo stesso cast di personaggi. I bianchi non hanno bisogno di conoscersi per conoscere le rispettive storie. Conosciamo i bianchi dalle storie che raccontano.
Nelle ultime settimane molti bianchi hanno fatto affidamento su queste storie per dare un senso e per difendersi dagli eventi di Ferguson e New York. In particolare, queste storie di supremazia bianca permettono ai bianchi di restarsene indisturbati e impassibili, sia fisicamente che spiritualmente. Non vogliono rinunciare ai quartieri divisi su base razziale e al potere razziale che questi spazi danno loro; non vogliono mettere in discussione la loro fede nella fondamentale bontà e innocenza della razza cui appartengono e nella nazione cui hanno promesso fedeltà. Sanno di essere buoni; le loro storie dicono questo.
Anche l’arcivescovo di St. Louis, mons. Robert Carlson, ha risposto agli eventi seguiti all’omicidio di Michael Brown raccontando una storia. Ma, anziché ribaltare il mito su cui si basa la supremazia bianca, l’arcivescovo l’ha fatto suo. Non è l’unico: racconta storie che molti bianchi raccontano. Come Bryan Massingale (prete e teologo, autore di Racial Justice and the Catholic Church, ndt) e altri studiosi ci hanno segnalato, la sua prospettiva non rappresenta l’eccezione, ma la regola.
L’arcivescovo inquadra la sua narrazione pastorale attraverso le lenti date dall’appartenenza alla razza bianca. In una serie di tre documenti su Ferguson, l’arcivescovo condanna la violenza con fervente risolutezza. Dando l’impressione di sposare un pacifismo che non ammette eccezioni, mons. Carlson esorta i fedeli a «rigettare ogni falsa e vuota speranza che la violenza possa risolvere i problemi». «La violenza – prosegue – crea solo altra violenza». Citando Giovanni Paolo II, proclama: «La violenza è inaccettabile come soluzione ai problemi». Sotto quest’ombrello, l’arcivescovo denuncia la messa a fuoco degli edifici e il lancio di pietre. Anziché distinguere tra un uso giusto e uno ingiusto della violenza, mons. Carlson afferma di opporsi alla violenza in sé e per sé.
Ma l’arcivescovo crede davvero in quel che dice?
Nel momento in cui rifiuta l’uso della violenza da parte dei manifestanti, non respinge quello da parte dello Stato. Le forze di polizia senza dubbio usano la violenza a sostegno della legge e dell’ordine. Le incarcerazioni stesse sono intrinsecamente violente, anche se necessarie. Tuttavia non sono riuscita a trovare una sola dichiarazione di mons. Carlson che condanni i poliziotti di St. Louis per il possesso di una pistola, di un manganello o di un dissuasore elettrico. Né ho rinvenuto alcuna dichiarazione in cui l’arcivescovo esorti i membri cattolici dell’esercito a «rigettare ogni falsa e vuota speranza che la violenza possa risolvere i problemi».
L’arcivescovo Carlson insiste sul pacifismo per gli uomini e le donne neri che protestano contro la violenza della supremazia bianca, ma permette la violenza di molti altri.
Come molte persone bianche, invita a fare memoria di Martin Luther King non tanto per difendere una giustizia razziale o un pacifismo di principio, ma per tutelare gli interessi razziali dei bianchi. L’arcivescovo schiera il reverendo King per condannare i manifestanti neri e non per mettere in discussione i suoi parrocchiani bianchi o lo status quo della supremazia bianca.
E tuttavia, come lo stesso Martin Luther King disse in un discorso nel quale annunciava la sua opposizione alla guerra in Vietnam, non si può dire alle «persone disperate, rifiutate e arrabbiate» chiuse nei ghetti degli Stati Uniti che «le molotov e i fucili non risolvono i loro problemi» mentre il Paese continua a «usare massicce dosi di violenza per risolvere i suoi problemi e per realizzare i cambiamenti cui anela». Proprio perché all’arcivescovo la violenza dello Stato non sembra violenza, il suo impegno pacifista risulta selettivo.
Forse faremmo meglio a chiedere all’arcivescovo cosa intende per pace. Pace, per lui, non sembra essere l’opposto della violenza ma ciò che disturba lo status quo. Nella sua dichiarazione del 18 agosto, l’arcivescovo parla del «tumulto e della tragedia nella comunità di St. Louis» e cerca di confortare coloro che «stanno lottando per trovare la pace nel caos». E ancora, nel suo comunicato del 10 ottobre, esorta i fedeli a «essere strumento di pace in mezzo al caos» e a «lavorare per la calma nel subbuglio». Il disordine di corpi neri che protestano contro l’ordine della supremazia bianca sembra subbuglio e caos; l’ordinaria violenza della supremazia bianca appare come una tranquillità che non richiede commenti.
Capiamo ancora meglio cosa intende l’arcivescovo con il termine “pace” leggendo la sua dichiarazione del 24 novembre, rilasciata dopo la decisione del grand jury di non incriminare l’assassino di Michael Brown. Questa lettera suggerisce che l’arcivescovo condanni non solo la violenza dei manifestanti ma anche la disobbedienza civile. Dopo aver ripetuto il suo invito «alla preghiera, alla pace, alla calma» l’arcivescovo dice: «Da quando, in agosto, il grand jury ha ricevuto il caso, abbiamo assistito a esplosioni aggressive e violente e ad atti di disobbedienza civile da parte dei manifestanti. Nonostante i nostri inviti alla pace, cui si è unita la famiglia di Michael Brown, continuiamo a vedere che questi segmenti della nostra comunità non hanno rinunciato completamente alla tendenza ad adottare un comportamento antagonistico e a esercitare la violenza».
Qui mons. Carlson sembra etichettare la disobbedienza civile come «antagonista», cioè non pacifica. Rifiutando lo spirito del movimento per i diritti civili, confonde la pace con l’assenza di conflitto. Più che la giustizia, l’arcivescovo vuole il ripristino del tranquillo – o meglio, basato sulla supremazia bianca – ordine sociale.
Chiede non solo che i cittadini di St. Louis protestino in maniera non violenta ma che accettino la decisione di non incriminare l’assassino di Michael Brown «come corretto funzionamento del nostro sistema di giustizia».
Scambiando l’ordinaria violenza della supremazia bianca per pace, l’arcivescovo presenta il conflitto al centro della storia che sta raccontando come un caso di unità razziale incrinata dalla turbolenza dei manifestanti neri. Per lui, il razzismo non è prima di tutto strutturale, ma personale. Non ritiene responsabile la supremazia bianca, ma il cuore umano. Il razzismo si dispiega come una specie di faida familiare, come un battibecco. Così facendo, non lamenta che St. Louis presenti uno dei più alti tassi di segregazione razziale degli Stati Uniti, ma che «non abbiamo [ancora] integrato il cuore di tutti».
QUESTIONE DI STRUTTURE
Questo è un luogo comune dei cantastorie bianchi. I bianchi sono a loro agio nel descrivere il razzismo come un problema di pregiudizi personali e di odio. Raccontare questa storia permette loro di sentirsi dal lato della giustizia: il razzismo riguarda solo coloro che indossano cappucci bianchi e che bruciano le croci; oppure si tratta della maleducazione di chi è incolto. In questa storia, un’azione si qualifica come razzista solo se chi la mette in pratica è visto come tale. I bianchi sono razzisti solo se dicono di esserlo. E possono autoassolversi, se vogliono: non devono essere sottoposti al giudizio dei neri. La loro realtà rimane, come sempre, quella da loro plasmata.
Ma il razzismo non è solo, o in primo luogo, odio. Come ha detto lo scrittore nero James Baldwin: «Non mi interessa se piaccio al senatore Eastland o a Barry Goldwater… Ciò che mi interessa è che loro hanno il potere di buttarmi fuori di casa, di farmi licenziare, e di porre i miei figli in stato di bisogno… non mi interessa cosa pensano o cosa provano, ma quel potere». Più di qualsiasi altra cosa, il razzismo è potere e supremazia bianca. E il potere bianco, come nota Bryan Massingale, è mediato e sostenuto da strutture e istituzioni e non solo da azioni interpersonali. Per questo egli esorta i funzionari ecclesiali ad andare oltre il mero ambito “personale” e a includere ciò che egli chiama «la dimensione strutturale della questione razziale».
Ma quando l’arcivescovo volge la sua attenzione alle sottostrutture culturali o, con le sue parole, alle «questioni più profonde», lo fa in maniera tale che bianchi e neri risultano ugualmente meritevoli di biasimo. Alla supremazia bianca si fa allusione solo quando la si può giustificare, controbilanciare, o quanto meno farla sembrare ragionevole.
Ciò che con una mano dà, con l’altra toglie. Mentre il «white flight» (la fuga dei bianchi verso zone in cui c’è una minore mescolanza razziale, ndt) e il «racial profiling» (espressione con cui si indica il peso decisivo di fattori razziali o etnici nel determinare l'azione delle forze dell'ordine nei confronti di un individuo, ndt) sarebbero da deplorare, la storia raccontata dall’arcivescovo li rende inevitabili. Due luoghi comuni della supremazia bianca – la «violenza dei neri sui neri» e la «disgregazione della famiglia» – ci dicono dove puntare il dito. E mentre menziona «gli abusi dell’autorità» lamenta anche la «mancanza di fiducia nell’autorità». Non gli viene in mente che «gli abusi» da parte delle forze dell’ordine, che abitualmente fanno uso di racial profiling, potrebbe rendere la «mancanza di fiducia nell’autorità» sia legittima che legata a una questione di sopravvivenza.
Per l’arcivescovo il problema non è il razzismo ma i difetti di carattere universalmente condivisi. In questo senso, dice: «Dobbiamo tenere a mente che le questioni in ballo vanno al di là di Ferguson. Sono profonde tanto quanto la presa del peccato sul cuore degli esseri umani e tanto ampie quanto la solidarietà dell’intera razza umana». Anziché indicare i bianchi come gli unici colpevoli della - e privilegiati dalla - supremazia bianca, mons. Carlson definisce la situazione come qualcosa di cui i bianchi non hanno particolari responsabilità.
Dando più importanza alle componenti interpersonali del razzismo, l’arcivescovo riconosce solo quei problemi le cui soluzioni lasciano intatti il potere bianco e l’apparato strutturale di fondo che lo sostiene: una vaga formula impegna l’arcidiocesi ad «assistere le chiese di Ferguson e dell’area circostante nella sfida alla povertà e al razzismo»; nonché a mettere in piedi «una commissione sui diritti umani presso l’arcidiocesi»; ad aumentare la presenza dei bambini poveri nelle scuole primarie e secondarie cattoliche; e ad offrire una messa per la pace e la giustizia in ogni parrocchia.
Come molti bianchi, mons. Carlson considera il “razzismo” un problema da risolvere anziché un mondo da disfare. Per questa ragione, crede che si possa lottare contro il razzismo senza scivolare nel caos. Lo schema detta il finale; come in tutte le favole, la storia che i bianchi raccontano sulla razza non può che concludersi in un modo: con un lieto fine.
Oltre a placare le coscienze dei bianchi, questa narrazione esonera anche i corpi sociali, come la Chiesa. Nella storia raccontata dall’arcivescovo, lui e la sua arcidiocesi sono attrezzate per essere parte della soluzione: l’arcivescovo si staglia al di sopra della mischia, come un elemento esterno che viene a giudicare una spiacevole disputa. Presentando se stesso come una voce della ragione, l’arcivescovo agisce come un consigliere comunale «invitando chiunque senta il desiderio di scatenarsi violentemente contro qualcuno a prendersi una pausa e a considerare le potenziali conseguenze delle sue azioni». In questa stessa ottica, posiziona se stesso come leader degli altri leader, sfidando «i leader religiosi, politici, sociali e delle forze dell’ordine a unirsi a lui nel chiedere a Dio di farci strumento di pace» e di fornirci «il coraggio per combattere la frattura che abbiamo di fronte».
Ma la Chiesa non è al di fuori della storia – tuttora in corso – della supremazia bianca. Come ha notato Bryan Massingale, i narratori ecclesiastici devono riconoscere la complicità della Chiesa in ciò che egli chiama «razzismo ecclesiale». Anziché moderare le dispute, la Chiesa deve confessare le proprie colpe. Se conosciamo la Chiesa cattolica dalle storie che racconta sul mondo e sul posto che vi occupa, allora ciò che ha detto nel 1968 il Black Catholic Clergy Caucus (organizzazione promossa dal clero afro-americano della Chiesa cattolica Usa, ndt) è ancora tristemente vero: «La Chiesa cattolica negli Stati Uniti è prima di tutto un’istituzione bianca razzista». L’arcivescovo di St. Louis dovrebbe iniziare qualsiasi discussione sulla razza parlando sia del modo in cui la supremazia bianca ha plasmato la sua arcidiocesi, sia del modo in cui la sua arcidiocesi ha plasmato la supremazia bianca.
LE COLPE DELLA CHIESA
I narratori della Chiesa dovrebbero partire dall’inizio: St. Louis è cresciuta in dimensioni e status principalmente perché è stata una delle maggiori città portuali del commercio di schiavi interno agli Stati Uniti. La Chiesa piazzò qui la sede di quella che allora era una diocesi occidentale per lo stesso motivo. La tratta degli schiavi ha contribuito a rendere l’arcidiocesi quel che è.
Questa collocazione spaziale rende prevedibile la partecipazione dell’arcidiocesi nella proprietà degli schiavi. Il primo vescovo di St. Louis, Joseph Rosati, rifornì di schiavi il Seminario di St. Mary. Il suo successore, Peter Richard Kenrick, pretese diverse donne e uomini neri come schiavi. Altre donne e altri uomini presumibilmente santi ne hanno seguito l’esempio. Giusto a sud di St. Louis, nella Contea di Perry, ancora nel 1830, l’ordine vincenziano possedeva più schiavi di qualsiasi altro proprietario schiavista dell’area circostante.
Anche dopo la fine dello schiavismo, i cattolici bianchi di St. Louis, sia immigrati che nativi, continuarono a essere profondamente intrisi di supremazia bianca. La loro violenza segregazionista era permessa e a volte persino sancita dai funzionari dell’arcidiocesi. Nel 1916 la Catholic Polish-American Association ha selvaggiamente promosso un’ordinanza segregazionista per la città di St. Louis, convertita in legge con voti favorevoli che si attestarono su una proporzione di 3 a 1.
Anche dopo che questa ordinanza fu rovesciata, i cattolici bianchi dell’arcidiocesi hanno continuato a preservare lo status quo segregazionista che avevano contribuito a creare. L’area circostante St. Louis ha al suo interno decine di cosiddette “Sundown Towns” (città, zone o quartieri degli Stati Uniti abitati solo da bianchi, ndt) da cui i bianchi si sono sforzati di tenere fuori i neri con ogni mezzo, dalle politiche di ghettizzazione alla violenza di massa. E, nella città di St. Louis, la maggioranza bianca, quando non ha più potuto evitare l’integrazione dei neri, è fuggita essa stessa.
Ma la suburbanizzazione non ha reso i bianchi più propensi all’integrazione. Proprio come quando vivevano all’interno dei confini della città, i bianchi di St. Louis si sono sforzati di tenere i neri fuori dai loro sobborghi. Per esempio, nel 1970, l’interamente bianco sobborgo di Black Jack a St. Louis ha votato la propria dissoluzione in modo da poter elaborare un nuovo diritto cittadino in grado di bloccare la costruzione di appartamenti aperti ad affittuari neri. Come risultato di queste coordinate strategie di segregazione della supremazia bianca, l’arcidiocesi di St. Louis comprende una delle aree più segregate e ineguali del Paese.
La divisione razziale, allora, non è un «divorzio amaro» come è stato scritto sul giornale dell’arcidiocesi; non è un litigio; non è qualcosa di cui sia neri che bianchi sono colpevoli; non è un malinteso. Bianchi e neri vivono in quartieri diversi perché così i bianchi vogliono che sia e perché i bianchi hanno il potere di rendere i loro desideri realtà. La segregazione razziale continua perché va a braccetto col potere e coi privilegi dei bianchi.
Ma i bianchi non vogliono che i neri siano separati da loro al punto da non poterli sottoporre alla stretta sorveglianza delle forze di polizia in maggioranza bianche. I bianchi desiderano che i neri vivano a distanza ma che rimangano sotto il loro controllo. Quando l’arcivescovo presenta il problema razziale degli Usa come un problema di divisione, fa opera di offuscamento e di ultrasemplificazione. Se prendiamo per esempio il modo in cui la guerra alla droga viene messa in atto con una serie di regole nei quartieri prevalentemente neri e con una serie di regole completamente diversa in quelli prevalentemente bianchi, se ne deduce che per i neri sarebbe molto meglio se i bianchi semplicemente li lasciassero soli per davvero.
Mons. Carlson esorta il popolo della sua arcidiocesi a «trovare la volontà di sedersi insieme e dialogare, di avere l’umiltà di ammettere i propri errori e di chiedere scusa». Ma la storia dimostra che i bianchi sono praticamente incapaci di scuse razziali. Vien da chiedersi quando i bianchi hanno chiesto scusa o fatto ammenda ai neri per qualcosa.
Di più, quando guardiamo ai lunghi secoli di schiavismo; ai cento anni di ghettizzazione urbana del nord; alle decine, se non centinaia, di rivolte razziali bianche perpetrate contro le proprietà dei neri e contro i loro corpi; alla quasi quarantennale guerra della supremazia bianca alla droga, solo per citare alcuni fatti, vien da chiedersi: per cosa i neri devono chiedere scusa ai bianchi?
Il racconto della razza negli Stati Uniti non coinvolge due parti, ugualmente fallaci e ugualmente lese. La mitologia bianca oscura la realtà razziale: la disuguaglianza razziale persiste perché i bianchi vogliono che sia così. Questa è la nostra storia nazionale più vera.
La Chiesa non può aspirare alla neutralità. Anziché mediare tra due parti, dovrebbe stare dalla parte di quanti lottano con più coraggio contro la supremazia bianca. Ma la Chiesa non potrà farlo fino a quando non imparerà a preferire il caos razziale che sembra violenza alla violenza della supremazia bianca che passa per pace.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!