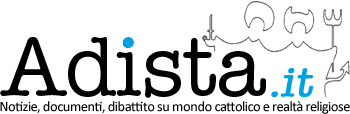Buen vivir, un concetto in costruzione
Tratto da: Adista Documenti n° 24 del 01/07/2017
«La grande barca sta attraversando una tormenta perfetta, la peggiore di tutte. Nella sala macchine sono riuniti tutti i leader: politici, scienziati, finanzieri, intellettuali, attivisti… [...] Discutono animatamente sulle decisioni da prendere e sulla strada da seguire. Sono così indaffarati a discutere tra loro che non si accorgono che la barca sta affondando. Anche sopra, in coperta, dove sta la gente, si discute. Non si trova il timone; [...] alcuni pensano che ancora esista e lottano tra di loro per appropriarsene. Altri, abituati alle iniziative individuali e fiduciosi nelle proprie forze, si buttano in acqua e affogano» (Esteva G., Antistasis. L’insurrezione in corso, Asterios, Trieste 2012). Sì, la grande barca può affondare. È bene esserne coscienti senza però diventare apocalittici. Il “progresso”, ironia della storia, lo ha reso possibile: l’atomica, il cambiamento climatico … e ora anche il genedrive (una tecnica recentemente messa a punto che consente l’ereditarietà di un particolare gene per accrescere la sua prevalenza in una popolazione la cui riproduzione sia di tipo sessuale, come pure di estinguerlo. Una tecnica semplice, veloce ed economica che può essere messa alla portata di tutti). Cresce il numero di coloro che se ne rendono conto e stanno reagendo. Esteva, l’autore di questo brano, ci racconta, sulla base di esperienze concrete, le forme di questa ribellione. Ce la faremo? Per decifrare il presente dobbiamo guardare nello specchio del passato: come, quando, perché è accaduto? La grande illusione Iniziamo a guardare dal 20 gennaio 1949. Il presidente Truman, nella più intrigante delle sue “conversazioni al caminetto”, lancia la metafora dello “sviluppo”: «Le nostre risorse in conoscenze tecniche, che fisicamente non pesano nulla, crescono continuamente e sono inesauribili. Dobbiamo compiere uno sforzo mondiale per garantire la pace e la libertà […] Ciò che proponiamo è un programma di sviluppo basato sull’idea di un negoziato giusto e democratico». Mai prima di allora la parola “sviluppo” era stata usata fuori dalla biologia. Da quel momento diventerà un mantra economico e politico. Cancellerà il senso del limite, farà affidamento cieco sulla nuova religione, la tecnoscienza, darà fiducia ai lupi travestiti da agnelli: ecco la vera implicazione della promessa. L’American way of life, promesso a tutti i popoli della terra, sarà il suo volto ammiccante. Ricordo che, giovinetto, la vidi arrivare in Italia annunciata dai film di Tyron Power e Rita Hayworth, la coca cola, le “cingomme”. L’impresa venne affidata alla Banca Mondiale che, per realizzarla, ingaggiò un “perdente”, Robert McNamara, segretario alla Difesa nella guerra del Vietnanm, che iniziò così la “guerra” alla povertà (1968). L’inizio della “nuova era” fu promettente: dal 1946 al 1975 il mondo visse i “trenta gloriosi” anni (dal titolo fortunato di un libro di Jean Fourastié). Guadagnarono tutti? Come avvertì Wassili Leontief, economista russo naturalizzato statunitense e Premio Nobel per l'economia nel 1973, con l’aiuto di un suo modello matematico, per raggiungere il tenore di vita dei Paesi occidentali «il Messico e il Brasile avrebbero necessitato solamente di 25 anni. Ma negli anni Ottanta la Banca Mondiale dichiarò che la Mauritania avrebbe avuto bisogno di 2.223 anni per svilupparsi, mentre i Paesi come il Messico e il Brasile solo di 400 o 500 anni, quindi già all'inizio degli anni '80 sapevamo che mai avremmo raggiunto i Paesi sviluppati» (citato così da Esteva nel testo già menzionato). Ma il mito continuò a brillare, perché, come scrisse Gilbert Rist nel 1996, «lo sviluppo è simile a una stella morta di cui si vede ancora la luce, anche se essa si è spenta da tempo e per sempre» (Rist G., Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Bollati e Boringhieri, Torino 1997). E questa luce è tuttora viva nella retorica politica e nelle aule accademiche con il volto della “crescita”, anche questa illimitata, malgrado l’annunzio del Nobel per l’economia Paul Samuelson alla fine degli anni Novanta: la guerra alla povertà è terminata e i poveri, per loro sfortuna, hanno perso. McNamara non aveva portato fortuna! A metà degli anni Settanta erano arrivate le “vacche magre” e la macchina dello sviluppo si era inceppata: il “rapporto Bruntlandt” (“Our common future”, 1986), elaborato su incarico dell’ONU, segnalò che fra sviluppo e tutela dell’ambiente qualcosa strideva. Ad esempio ci si rese conto che le piogge rese acide dai fumi delle fabbriche delle regioni industrializzate, altrove distruggevano foreste e coltivazioni. Il mantra necessitava di messe a punto e così per la prima volta gli si aggiunse un aggettivo. Doveva diventare “sostenibile”. Non funzionò, e volta a volta si disse che doveva essere “integrale”, “umano”, “durevole”, “endogeno”, “ecocompatibile”, “etnocentrico” e così via. La grande estrazione Scrive David Harwey (L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, Feltrinelli, Milano 2011) che il capitalismo, per restare in buona salute, esige un tasso di incremento del capitale di almeno il 15% annuo. Ma l’economia manifatturiera, dopo i “trenta gloriosi” anni, non fu più in grado di assicurare questo trend. Il rimedio fu trovato da un lato in quella che lo stesso Harwey definì accumulazione per espropriazione e dall’altro nella finanziarizzazione dell’economia. In realtà, come si sarebbe capito poi, entrambe avevano una filosofia comune: l’estrattivismo inteso in senso allargato. La globalizzazione e il mercato diventarono il nuovo terreno di gioco. La trasformazione non era stata programmata a tavolino ma si fece di necessità virtù, anche se non tutti sono d’accordo su ciò. Il pensiero di sinistra si è sempre considerato come pensiero “progressista”, innovatore, e ha sempre giudicato “conservatore” il pensiero della destra. In realtà, come scrive Jean Claude Michéa (Il vicolo cieco dell'economia. Sull'impossibilità di sorpassare a sinistra il capitalismo, Eleuthera, Milano, 2012), è impossibile sorpassare il capitalismo a sinistra, sempre pronto com’è a volgere tutte le occasioni di cambiamento a proprio favore. Estrattivismo è parola tuttora quasi sconosciuta in Italia ma tristemente nota in America Latina, tradizionale banco di prova per le politiche da applicare successivamente al resto del mondo. Essa fu dapprima impiegata per significare l’estrazione delle risorse naturali dei territori, previamente desovranizzati, cioè tolti al controllo degli Stati nazionali e passati al controllo delle multinazionali, dotate nel frattempo di soggettività giuridica dalle grandi Istituzioni internazionali (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e satelliti vari, grandi OnG incluse). Ma è poi venuta assumendo a poco a poco un significato più ampio, in quanto applicata alle monocoltivazioni, che ripetute negli anni sui medesimi terreni ne “estraggono” gli elementi della fertilità; all’estensione, con disboscamenti intensivi, della cosiddetta “frontiera agricola”; alla “gentrificazione” di aree urbane (dalla parola inglese gentrification, derivante da gentry, ossia la piccola nobiltà inglese e in seguito la borghesia, che indica l'insieme dei cambiamenti urbanistici e socio-culturali di aree urbane, tradizionalmente popolari o abitate dalla classe operaia, risultanti dall'acquisto di immobili da parte di popolazione benestante); e infine al land grabbing di estesi territori coltivabili (l’accaparramento di territori agricoli pregiati delle regioni del sud del mondo per destinarli allo sviluppo di monocolture da parte di altri Stati, di grandi corporation o di privati). Un successivo ampliamento di significato è avvenuto con l’economia finanziaria e il suo “spossessamento” di beni immateriali tramite la moltiplicazione di ambigui strumenti finanziari (prodotti derivati, cartolarizzazioni, ecc. e alle politiche del debito), che hanno operato estrazione di valore da una varietà di soggetti (Stati e cittadini) trasferendolo a un’élite sempre più ristretta, il famoso 1% (in realtà vincolato a un nutrito schieramento di sostegno – 20%? – costituito da banchieri, grandi funzionari, alti gradi militari, politici, accademici, e opinionisti al suo servizio). Raúl Zibechi, nel libro La nuova corsa all’oro. Società estrattiviste e rapina (Mutus Liber, a cura di Camminar domandando, Riola, Bologna, 2016, scaricabile da www.camminardomandando.wordpress.com), scrive: «L’estrattivismo sta generando una completa ristrutturazione delle società e degli Stati in America Latina. Non siamo di fronte a “riforme”, ma a cambiamenti che, come il processo regressivo nella distribuzione della terra, mettono in discussione alcune realtà delle società (…). Negli spazi dell’estrattivismo, la democrazia si indebolisce e cessa di esistere; gli Stati vengono subordinati alle grandi imprese, al punto che la gente non può contare sulle istituzioni per proteggersi dalle multinazionali». Ristrutturazione così ampia e profonda da indurre Zibechi a definire l’attuale società come società estrattivista, termine usato anche dalla sociologa olandese Saskia Sassen. Entrambi gli autori nelle loro analisi scorgono con profondo malessere l’esito finale del processo: l’espulsione di masse di popolazione (popoli indigeni, contadini, migranti… che la Sassen cifra in un 50% della popolazione mondiale) dalla zona dell’essere verso la zona del non essere, i senza patria, i senza diritti. «Siamo scarti. Saremo scartati o, per lo meno, ci proveranno», denuncia Zibechi. Fa eco la Sassen: «Siamo di fronte a una serie – imponente e diversificata – di espulsioni, una serie che segnala una più profonda trasformazione sistemica, che viene documentata a pezzi, in modo parziale, in studi specialistici diversi, ma che non viene narrata come una dinamica onnicomprensiva che ci sta conducendo in una nuova fase del capitalismo globale, e della distruzione globale». Pessimismo totale, quindi? I due autori, significativamente, si sono chiesti: saranno i “dannati della terra” (Fanon F., I dannati della terra, Einaudi, Torino, 2007) ad assumersi questo compito? Interrogativo già posto da Giulio Girardi nei lontani anni Novanta (Gli esclusi costruiranno la nuova storia? Il movimento indigeno, negro e popolare, Borla ed. Roma, 1994). Possiamo ora completare il brano iniziale di Esteva: «I più, in piccoli gruppi, in comunità, provano o fabbricano scialuppe e zattere e iniziano a navigare e, accorgendosi di trovarsi in mezzo a un arcipelago, si dirigono verso le sue spiagge per trasformare ogni isola in un ponte che permetta loro d'incontrarsi con gli altri. Da lì, dopo aver visto con dolore la grande barca che affonda con tutti i suoi leader, iniziano a costruire un nuovo mondo in cui siano compresi tutte e tutti». Il Buen vivir, alternativa epistemica Scrive ancora Esteva nel libro citato: «Se ci fosse un'espressione in grado di racchiudere il senso dei movimenti sociali che si stanno diffondendo in America Latina, questa sarebbe il Buen vivir, la vita buona, solitamente completata dal concetto di mutuo appoggio (o “cura reciproca”) […] La definizione di buona vita, una sfera d'immaginazione e d'azione che è appartenuta tradizionalmente alla società civile, nel moderno Stato-nazione è stata assegnata al governo, che abitualmente l'ha condivisa con le corporazioni private e pubbliche, consegnandola al capitale». La concezione indigena tradotta con l’espressione spagnola Buen vivir, ovvero Buon vivere, nelle lingue originarie si chiama sumak kawsay in quechua, sumak qamaña in aymara e così via. Tale traduzione è imperfetta perché alcuni concetti forti di una cultura non sempre sono traducibili in un’altra se non ricorrendo a “equivalenti omeomorfici”, cioè espressioni che si approssimano al significato originario senza centrarlo. Esistono però altre approssimazioni, meno usate ma che ci appaiono più adeguate, quali vita in pienezza o vita in armonia (con la natura). Nelle stesse etnie indigene il concetto assume “colorazioni” differenti, conservando però sempre due idee centrali: vivere in armonia con la natura e vivere in reciprocità all’interno della comunità. Come indica, in modo che può sembrare banale ma che esprime l’odierno rifiuto indigeno dello sviluppo, la frase: “Noi non vogliamo vivere bene (domani), vogliamo vivere bene (oggi)”. Secondo l’indigeno Xavier Lajo, esiste una differenza sostanziale al centro della cultura occidentale e di quella indigena, rendendo difficile l’esatta comprensione dell’espressione. La prima infatti mette il “pensare” al di sopra del “sentire”, subordinando la scienza e la tecnologia alla ragione o logos, cosa che induce alla separazione e al dominio del soggetto sopra l’oggetto e dell’essere umano sulla natura. La seconda privilegia invece il “sentire” (Lajo X., “El Sumaq kawsayninchik o nuestro vivir bien”). Questa concezione è presente da sempre come sottofondo della vita sociale indigena ma essa oggi è divenuta oggetto di nuova riflessione proprio in opposizione alle risultanze negative della proposta occidentale dello “sviluppo”. Se il mondo indigeno è il luogo dove, al fine di esorcizzare la minaccia dell’espulsione dalla storia, questa forte riflessione, legata a tale visione ancestrale, è iniziata, essa ha aperto una finestra anche in pensatori non indigeni alla ricerca di nuovi orizzonti cui si sono trovati di fronte in questa oscura transizione epocale. Eduardo Gudynas rileva che il Buen vivir «ingloba un complesso di idee che si stanno forgiando come reazione e alternativa ai concetti convenzionali dello sviluppo. Sotto l’espressione Buen vivir si stanno accumulando diverse riflessioni che con molta forza esplorano nuove prospettive creative sia sul piano delle idee come in quello delle pratiche. [...] è un concetto in costruzione che necessariamente deve aggiustarsi ad ogni situazione sociale e ambientale». Per l’ecuadoriano Pablo Davalos, molto vicino al mondo indigeno, «la nozione di Buen vivir (sumak kawsay), in quanto nuova condizione di contrattualità politica, giuridica e naturale, ha iniziato il suo percorso nell'orizzonte delle possibilità umane per mano (soprattutto ma non solo, come egli riconosce in altri scritti, nda) dei popoli indigeni di Bolivia ed Ecuador». Un pensiero ancestrale indigeno in evoluzione quindi, come possibile alternativa epistemologica già in atto al pensiero dominante, da assumere con spirito critico in ogni realtà specifica, alla ricerca del particolare Buen vivir di ciascuno di quei mondi evocati nel lemma dei maya zapatisti del Chiapas: “Un mondo capace di contenere molti mondi diversi”.
*Aldo Zanchetta è tra i massimi esperti dei movimenti indigeni e sociali dell’America Latina, già presidente della Fondazione Neno Zanchetta, è coordinatore della nuova collana “Ripensare il mondo” della casa editrice Hermatena, collaboratore del gruppo Camminar domandando e di Re:Common, autore del Mininotiziario America Latina dal basso e di diverse altre pubblicazioni, tra cui i libri America Latina, l’arretramento de los de arriba e America Latina, l’avanzata de los de abajo
* immagine per gentile concessione dell'autore
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!