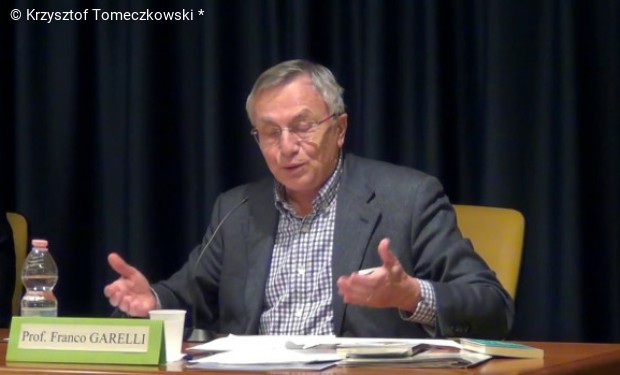
Chiesa italiana, pandemia, papa Francesco: intervista al sociologo Franco Garelli
Tratto da: Adista Notizie n° 19 del 16/05/2020
40256 ROMA-ADISTA. In questi giorni, si è risolta (v. Adista online del 7/5) la clamorosa polemica tra la Conferenza episcopale italiana e il governo, seguita alle disposizioni contenute nel dpcm in vigore dal 4 maggio, che escludevano la possibilità di celebrare messe in presenza del popolo ed aprono ai funerali con un massimo di 15 persone. Nel bel mezzo della controversia, papa Francesco ha richiamato la CEI all’«obbedienza» delle disposizioni governative e alla «prudenza», sollevando l’indignazione della destra cattolica fieramente attestata su posizioni antigovernative. Una vicenda che riflette le divisioni e la complessità della realtà cattolica italiana.
Nel tentativo di far luce su questa complessità, ci siamo rivolti a Franco Garelli, uno dei massimi osservatori dello scenario religioso italiano. Nei suoi numerosi lavori, quasi tutti pubblicati con Il Mulino, ha scandagliato la vita della fede cattolica e i suoi urti di rimando sulla collettività: I giovani, il sesso, l’amore (2000), L’Italia cattolica nell’epoca del pluralismo (2006), Piccoli atei crescono (Davvero una generazione senza Dio?) (2016). Sempre per Il Mulino il suo ultimo studio, Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio, in cui esplora sentimenti, attese e contraddizioni del credente italiano, insieme alla sua idea sempre più ondivaga e plurale della verità. Dalla sua analisi emerge un Paese indeciso nelle valutazioni morali, ma non del tutto stanco del sentimento religioso.
Professor Garelli, abbiamo assistito a un curioso disaccordo: la Cei che accusava il governo di non rispettare l’autonomia della Chiesa (contrasto rientrato il 7 maggio con un protocollo di intesa) e il papa invitava alla prudenza. Cosa ne pensa?
Credo che la Cei chiedesse di essere maggiormente considerata, ma anche di avere le risorse per rispettare le norme di distanziamento, per far fronte a tutta una serie di problemi, che ci sono, è fuori di dubbio. Però, e questo è un fatto un po’ singolare, c’è stata ad un certo punto la frenata del papa. È come se Francesco avesse voluto evitare scontri frontali con lo Stato, con il governo. Dico singolare perché fa parte della politica ecclesiastica di questo papa incoraggiare una maggiore capacità propositiva delle singole Conferenze episcopali. In un caso in cui questo avviene da parte della Conferenza episcopale italiana, che è sempre stata un po’ timida nei confronti del papa, le viene subito suggerito un approccio più morbido. C’è stato un gioco delle parti un po’ contraddittorio, se vogliamo.
Perché lo considera un fatto singolare?
Perché fa parte della politica ecclesiastica di questo papa incoraggiare una maggiore capacità propositiva delle singole Conferenze episcopali. In un caso in cui questo avviene da parte della Conferenza episcopale italiana, che è sempre stata un po’ timida nei confronti del papa, le viene subito suggerito un approccio più morbido. C’è stato un gioco delle parti un po’ contraddittorio, se vogliamo.
Ecco, questo papa sembra avere un’identità complessa sotto molti aspetti. È molto più imprevedibile rispetto ai suoi predecessori. Lei non crede?
La cifra dell’imprevedibilità l’ho sottolineata anch’io più volte. Il primo articolo che avevo fatto, nei primi mesi di pontificato, evidenziava proprio questo aspetto: «è stato un papa imprevisto, ma sarà anche imprevedibile».
Per quali ragioni?
Per varie ragioni: non è europeo, quindi porta una visione meno eurocentrica; tende a vedere la realtà della Chiesa più dalla periferia, che dal centro. Un altro aspetto singolare: rispetto ai predecessori, in particolar modo rispetto a Benedetto, fa meno leva sulla necessità di legittimare il ruolo della religione nella società secolarizzata. Considera meno la fede cristiana come un tratto della cultura. Per lui la fede è una risorsa per la vita. Benedetto considerava la fede cristiana una risorsa culturale e, perciò, affermava la necessità di sottolineare le radici cristiane dell’Europa. Da cui il discorso del «Cortile dei Gentili», cioè il dialogo col mondo laico, con i laici e gli agnostici. Proprio per far emergere il valore culturale della fede. Questo pontefice, invece, da questo punto di vista opera minori mediazioni, ritiene che la fede cristiana sia una risorsa di senso in cui anche il mondo laico può trovare intuizioni interessanti.
Quali sono le più grandi intuizioni di questo papa, invece?
Non c’è più una fede soltanto di stampo ellenistico e occidentale, ma si incoraggia un radicamento in tutte le culture. Ciò impone una grossa riflessione teologica, anche da parte delle varie Chiese nazionali, per fare delle proposte che tengano presenti le condizioni culturali e di vita dei vari popoli. È un tratto molto rilevante. Ha rovesciato, come già accennavo, il rapporto tra centro e periferia: pensiamo all’idea della sinodalità...
Riaffermando però, a volte chiaramente, il centralismo romano, e penso alla polemica Cei-governo, ma anche al Sinodo per l’Amazzonia. Molti si aspettavano che le conclusioni sinodali trovassero un più concreto accoglimento nel documento finale del pontefice. Insomma, le veicolo la critica più comune, emersa anche tra le pagine di Adista: questo papa incoraggia la sinodalità, ma non sfrutta fino in fondo l’opportunità sinodale. Intuisce, ma non va fino in fondo nella realizzazione delle sue intuizioni. Lei cosa pensa di questa critica?
Probabilmente il suo pontificato ha la funzione di innescare un movimento, innescare dei processi, poi però forse deve fare i conti con la realtà complessa che è la Chiesa. Forse non se la sente di fare scelte dirompenti. Attende che ci siano dei processi di maturazione. La situazione dell’Amazzonia è abbastanza complessa, perché probabilmente c’era chi lo aspettava al varco. Molti si aspettavano che la «soluzione amazzonica» potesse poi aprire un processo più ampio, che riguardasse la Chiesa nella sua totalità. Credo vi siano delle dinamiche difficili da comprendere anche per l’osservatore più attento.
In una recente intervista, rilasciata ad Adista, Timothy Radcliffe ha dichiarato che Francesco ha meno certezze rispetto ai papi precedenti. Ha detto che è «un pastore che cerca». Lei condivide questa riflessione e la trova funzionale a spiegare la complessità intellettuale di questo papa? Chiarisco che Radcliffe intendeva fare un complimento al papa…
Sì, sì, questo è chiaro. Credo, però, che occorra contestualizzare questa bella immagine di Radcliffe. Secondo me è un papa che ha le sue certezze. È un pastore che ha i suoi punti fermi, però vuole una «Chiesa in uscita » e lui stesso è un pastore che guarda non soltanto a chi sta dentro il recinto, ma anche a chi sta ai margini o è fuori dal recinto. Pensiamo alla sua insistenza sul concetto per cui sono più le persone cosiddette «irregolari» nel rapporto con la religiosità o con le norme della Chiesa ad avere una ricerca di fede autentica. Questo aspetto è molto significativo. La sua idea è: se, come Chiesa, noi non prestiamo attenzione a queste persone, esse saranno escluse dall’annuncio cristiano. Perché oggi sono poche le persone radicate sulla Verità in senso stretto, mentre i molti vivono una condizione più flessibile, più aperta. Anche questi ultimi fanno parte della Chiesa, pur essendo ai margini. La «Chiesa in uscita» è anche questo e significa anche farsi carico delle attese e delle angosce di chi non ha più certezze, perché vive il riferimento di fede in una società plurale, una società in cui si vive più nell’incertezza che nella sicurezza. Lui è attento a questa realtà diversa. Lui non è incerto, ma vuole dialogare con chi lo è o con chi ha certezze differenti, gli atei o i fedeli di altre religioni. È un papa interessante, non trova?
Insomma, provo a sintetizzare: è un papa attento a come molti soggetti vivono la coscienza moderna nelle attuali condizioni di vita e nella società globale, pur rimanendo certo del valore fondamentale della via cristiana.
Esattamente.
In una recente intervista a Jesus, però - ed ora Le faccio fare proprio il suo mestiere - ha evidenziato un fenomeno che sembra derivare più dal pontificato di Ratzinger che non dall’attuale: l’emersione di un cristianesimo culturale, identitario… È una reazione della destra cattolica e, per riflesso, della destra politica, alla Chiesa di Francesco o è un fenomeno spontaneo e indipendente?
Credo sia un fenomeno indipendente, cresciuto molto negli ultimi decenni. Noi eravamo abituati a dire: c’è la secolarizzazione, la scristianizzazione, da un lato, e dall’altro le fedi aggressive, fondamentaliste che, in qualche modo, sbarcano in Occidente col loro carico di vitalismo, rispetto al quale la fede cristiana sembra sbiadita, con particolare riferimento all’Islam… A parte che quest’ultima ipotesi è tutta da dimostrare, penso che comunque anche dentro la realtà islamica vi siano frange differenziate e che l’Islam non sia un blocco granitico e omogeneo, ma non mi dilungo su questo. Sta emergendo un’altra variante: è vero che c’è la secolarizzazione della società, che si manifesta nel venir meno della pratica religiosa e in un certo analfabetismo religioso, però emerge una variante molto interessante dal punto di vista sociologico: la secolarizzazione non coincide, nei fatti, con un boom di non credenti.
Non c’è un travaso?
No, almeno per quanto riguarda l’Italia, non c’è un travaso da un’appartenenza cristiana maggioritaria a un’appartenenza di segno opposto; per intenderci, questi soggetti non sono diventati atei, agnostici e indifferenti. C’è la crescita di queste fila, ma è relativamente contenuta, siamo intorno al 25% della popolazione, molti più di venti, trent’anni fa, ma non c’è stato il boom che molti potevano aspettarsi. Molti non si sentono di fare il salto verso l’ateismo o l’agnosticismo, ma abbracciano un cristianesimo più etnicoculturale, che religioso e spirituale. Cioè mantengono il legame con l’identità cristiana, ritenendo che essa sia comunque parte dei propri riferimenti. Un legame sottile, ambivalente, discontinuo, ma pur sempre un legame: è curioso che nella società plurale in cui tutti sono gelosi difensori della validità delle proprie scelte, delle proprie opzioni, rimanga ancora questo legame alla tradizione. No? Credo sia molto interessante! La maggioranza degli italiani si identifica con questo cattolicesimo culturale, identitario. Un cattolicesimo più delle intenzioni che del vissuto. Il fatto di dire: io appartengo a quel ceppo, tutto sommato, quindi…
Cosa ha fatto scattare questo senso di appartenenza etnico-culturale col cattolicesimo? L’immigrazione, la globalizzazione?
Sicuramente la presenza di altre fedi sul territorio nazionale ha influito molto. La società è diventata plurale. Il ragionamento che fa «il tipo» cui ci stiamo riferendo è: c’è l’Islam. Va bene, c’è l’Islam, ma io ho radici cristiane! Posso anche non sapere esattamente cosa significhi, ma io sono cristiano! C’è il fascino delle religioni orientali, va bene, ma rimango comunque di ceppo cristiano, perché altrimenti viene meno un tassello della mia identità. Nei momenti topici ,come questo del coronavirus, io mi identifico nel papa, nei riti, perché sono celebrazioni che mi ricordano la mia identità originaria. Però, vivo questo senso di appartenenza in modo più libero rispetto al passato. Ciò non significa che mi identifichi completamente nelle norme della mia Chiesa. Ecco, questo modo di ragionare è in espansione.
Francesco, secondo Lei, come vive questa identificazione etnica col cristianesimo?
Secondo me non pensa bene di questo aspetto. A Santa Marta pochi giorni fa, parlava di «cristiani anonimi», non a caso. Certo, però, è attento a questa fascia di cristiani. Pensa a queste persone che, pur avendo, di fatto, staccato la spina dalla casa madre, rimangono attaccate ai margini, senza volersene separare davvero. Insomma, oggi non ha più senso dire: c’è la secolarizzazioni e c’è l’Islam. I credenti convinti, attivi, sono una minoranza, qualificata, ma pur sempre una minoranza, mentre la maggioranza dei credenti sono di questo tipo.
Diciamo: anagrafici, culturali…
Ma, se ci fa caso, noi un tempo dividevamo gli ebrei in “ebrei impegnati”, ortodossi, ed ebrei di famiglia. Sta succedendo lo stesso anche col cattolicesimo. Ci sono cattolici impegnati e cattolici di famiglia. Questi ultimi sono spesso molto ossequiosi verso la fede cristiana e i suoi rappresentanti, però poi conducono un orientamento di vita autonomo, soggettivo.
Nel frattempo, la fascia degli indifferenti, che pare spesso “fuori dai radar” del sociologo della religione, che fa? Quali sono le risorse di senso di questi soggetti, quando sono stanchi, quando hanno paura? In cosa “credono”? In quali riferimenti si identificano?
I meno interessati a tutto questo discorso sono proprio gli indifferenti. Per loro i valori spirituali non rappresentano un particolare coinvolgimento. Magari hanno un orientamento materiale, che si gioca più sulla concretezza della vita. Se devo dire, dalle mie indagini, sia in Piccoli atei crescono che quest’ultima, Gente di poca fede, non mi sembra prevalente un ateismo granitico, ideologico. È un fatto curiosissimo. La maggior parte di chi oggi si dichiara non credente, i 2/3, ammette oggi che sia plausibile credere in Dio. Non giudicano la realtà a partire dalla loro posizione. Il loro ragionamento è: ammetto che vi siano delle condizioni di riflessività che possono portare a credere, io non ci riesco, ma è affar mio, riconosco comunque che sia possibile. Allo stesso tempo, abbiamo una buona quota di credenti convinti, attivi che fanno il percorso inverso: credono, ma sanno benissimo quante difficoltà oggi incontri un credente, per cui ritengono anche legittimo fare scelte di non credenza. È quello che io chiamo, nel mio libro Piccoli atei crescono: «L’accettazione della biodiversità religiosa». Vengono meno gli steccati di due mondi che noi abbiamo sempre considerato come antagonisti. Per carità, una quota di popolazione rimane sulle barricate, da una parte e dall’altra. Però, molti altri vivono una coscienza moderna più attenta alla diversità.
Non per nulla una figura lungimirante come il cardinal Martini…
...aveva capito tutto, aveva già costituito la “Cattedra dei non credenti”. Abbiamo sempre più spesso esempi nella pubblicistica di questi scambi, al di là degli steccati: pensiamo al dialogo tra il papa e Scalfari. C’è, quindi, una ricerca, un interrogarsi, che coinvolge molti, la maggioranza direi. Tornando al discorso di prima: non è che il papa non abbia più certezze, partecipa di questa umanità in cammino, di questo clima di arricchimento reciproco.
Professore, in Italia, i fenomeni sociali in che misura sono ancora spiegabili attraverso il fattore religioso?
Eh, questa è una domanda enorme. Possiamo capire il senso della comunità, il bisogno di punti di riferimento. Il nostro è un cristianesimo fortemente comunitario… Ecco, però mi pare di notare come nessuno abbia messo in discussione il fatto che la Rai trasmetta la messa del papa, ogni giorno! È curioso. In qualche modo, è stato accettato. In altri Paesi, sarebbe stato tutto più problematico. L’immagine del pontefice in una piazza deserta è stata accettata senza proteste anche dagli atei più spinti. Il discorso è: ci si identifica nei gesti e nei messaggi delle grandi figure religiose, pur non abbracciandone la fede… Non dobbiamo più ragionare secondo compartimenti stagni.
Prima citavamo Carlo Maria Martini, ma l’elenco sarebbe lungo. Il cattolicesimo italiano, diciamolo pure, ha avuto molte di queste figure di mediazione… Possiamo dire che il nostro cattolicesimo è ricco di sfumature e ricco in senso generale?
Sì, questo è molto rilevante, ma non parliamo soltanto di teologia: c’è una presenza nel tessuto sociale italiano di moltissime figure, moltissime non conosciute, che scavalcano gli steccati e impegnano trasversalmente la loro vitalità in campo civile: pensiamo alla lotta alla mafia, al volontariato… Questo però ha anche dei limiti, perché, forse, se in Italia abbiamo una corruzione così diffusa è perché il cattolicesimo influisce solo in parte sulle coscienze, non emerge in molti casi una cittadinanza responsabile. Proprio perché tutta una parte della popolazione vive in modo soggettivo l’appartenenza al cristianesimo. Questo è un dato.
È il rovescio della medaglia, insomma. Professore, rientra nella complessità di questo papa anche il ricorso a crocifissi taumaturgici, alle indulgenze... Le veicolo un’altra critica abbastanza comune.
Questo fa parte della sua idea della fede popolare. È un tratto tipico dei latinoamericani. Non mi sembra, però, che questo aspetto sia così accentuato da mettere in discussione altre cose. Ho sentito le sue messe, a santa Marta, e sono molto più spirituali di quanto mi aspettassi. Lui parla con un coraggio di non poco conto, parla a braccio, eppure fa delle osservazioni non marginali, molto interessanti. Uno dice: ma come fa a prepararsi ogni giorno? Stupisce. Vuol dire che fa parte del suo habitus. Ha concetti chiari in mente. Non ha una religiosità molto sviluppata in chiave popolare. Ha piuttosto una spiritualità solida. Non è un papa dal cattolicesimo sociale, come alcuni avevano rilevato. In questo suo esporsi, in questa sua riflessione quotidiana, mi sembra attento al lato spirituale molto più di quanto sembrerebbe.
A proposito del format «messa in tv», che compare prestissimo, in Francia quasi in contemporanea con la nascita del mezzo, in Italia poco dopo ma comunque molto presto, oggi la Chiesa ha dovuto affidarsi in maniera quasi esclusiva a questo e ad altri mezzi di divulgazione di massa. Secondo Lei rimarrà qualcosa di tutto questo? L’etere sarà ancora così affollato di riti cristiani?
Anzitutto, c’è stata un’esplosione. Un grande attivismo delle realtà sociali. Moltissimi si sono attivati, non tutti. I dati sono rilevanti: in una delle parrocchie più piccole di Torino hanno registrato quasi 500 connessioni ogni volta che trasmettevano una messa in streaming tramite facebook. Sono numeri importanti.
Quasi da emittente privata…
C’è la possibilità anche di fare il commento durante il rito. Ha visto? È una cosa curiosa. Questo fenomeno, però, ha riguardato e raggiunto soprattutto i fedeli già attivi. Il bisogno di partecipazione si ritrova anche nei gruppi whatsapp, con scambi di meditazioni, condivisione di spunti, impressioni. C’è molto fermento. C’è stata la clausura, ma questa clausura ha spinto i credenti già impegnati a dialogare, confrontarsi, accompagnarsi nelle vicende umane e spirituali di questo tempo. Senz’altro, questa esplorazione, questa sperimentazione fa sì che si rinforzi la crescita di quelle che io chiamo «parrocchie di elezione», «comunità di elezione». La gente, connettendosi, dopo un po’, ha idea del quadro dell’offerta ed eleggerà per sé la realtà che più si addice al suo essere.
Mi permetta di banalizzare: i credenti stanno imparando a fare «zapping» tra le diverse realtà ecclesiali…
Certo. E questo avrà conseguenze per l’avvenire.
Si è aperto il mercato…
Esatto! Si andrà alla ricerca non tanto di quello che è più conforme al nostro palato, ma della realtà da cui trarre maggior conforto, maggior arricchimento spirituale, umano.
* Fotogramma di Franco Garelli tratto dal video Non-credenza oggi: questioni e prospettive, Seminario di studio tenutosi presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma il 23 novembre 2017 © Krzysztof Tomeczkowski; fonte: YouTube
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


