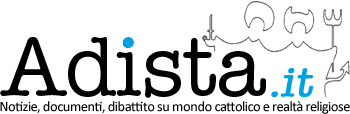Vecchio e nuovo a sessant’anni dal Concilio
Tratto da: Adista Documenti n° 31 del 17/09/2022
Il Concilio Vaticano II è un evento che si allontana nel tempo. Rari protagonisti, come il vescovo Bettazzi o il Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI, risultano ancora in vita e molti di quelli che ne conservano almeno un vago ricordo hanno ormai superato i sessant’anni; come me, la cui prima infanzia fu segnata dai cambiamenti che vedevo attuarsi nelle realtà ecclesiali in cui vivevo: via il latino dalla messa, giù le balaustre dalle chiese, e la comunione che passò così dal prete che la distribuiva ai fedeli inginocchiati, al prete che la distribuiva ai fedeli in fila, in piedi. E poi la Bibbia delle Paoline a casa mia, come certi libretti dai titoli strani: Gaudium et spes, Lumen gentium; nuovi ingressi nella libreria di famiglia. Troppo piccola per capirci qualcosa, ma sufficientemente contemporanea al Concilio per poterlo avvertire “dentro” la mia biografia e rientrare nel novero dei testimoni. Testimone, certamente, sono stata già del primo post Concilio: a vent’anni dal Vaticano II ero ormai, come si usa dire, una “giovane adulta”. Dunque le stagioni successive al Vaticano II le ho vissute tutte e il mio approccio di storica si lega indissolubilmente alla mia vicenda di testimone, in una forma di égo-histoire che deve, per onestà di riflessione e di scrittura, necessariamente essere esplicitata; ma ciò non mi appare soltanto come un limite – in quanto lo storico contemporaneo agli eventi è una sorta di ossimoro vivente –, piuttosto provo a farlo valere anche come un punto di osservazione privilegiato perché permette di avvertire la differenza semantica, culturale e politica che si realizza con la distanza, quella distanza che avverto ormai del tutto consumata quando parlo con i miei studenti della facoltà teologica. Per le generazioni più recenti l’evento appartiene esclusivamente alla storia collettiva e non a quella personale, ma non solo il Concilio: con esso anche gli eventi che produsse e le ermeneutiche che si generarono nei decenni a venire. Tuttavia, come nel caso della Costituzione della Repubblica Italiana, il Vaticano II è alle spalle e, come per la Costituzione, è anche avanti. Alla luce di questa dicotomia svilupperò quindi la mia riflessione. La storia a cui mi riferisco, però, non necessariamente è conosciuta, troppo spesso si riduce a un coacervo di luoghi comuni e di cose date per scontate o a cui si attribuiscono significati a posteriori, dunque decisamente antistorici.
Accade al Concilio ciò che si è verificato per tutte le grandi “lezioni” del Novecento, non solo per quanto riguarda la Costituzione e lo straordinario processo elaborativo collettivo che la partorì, ma anche per ciò che concerne, ad esempio, il femminismo e il duro e doloroso impegno che accompagnò le conquiste delle donne o, ancora a proposito delle lotte dei lavoratori, degli spazi che questi riuscirono a conquistarsi e delle sofferenze e dei lutti che le loro battaglie comportarono. Dissolta la memoria biografica degli eventi, risultano ormai dei fenomeni quasi del tutto sconosciuti e la loro eredità scambiata per cosa scontata, essendosi scollegato il nesso che porta da essi fino a noi. Prevale, dunque, un atteggiamento sconoscente, nel doppio senso di non conoscere o conoscere in maniera sbagliata e di non essere riconoscenti. Non c’è gratitudine quando non si è in grado di apprezzare. Si tratta di un passato digerito, ma non assimilato, al più “consumato”. Un fenomeno che caratterizza il poco e distorto sapere storico, travasato attraverso le generazioni in forma di clichés, da usa e getta.
Il Vaticano II costituì la rivoluzione copernicana della Chiesa non perché volle rompere con la tradizione e inventarsi un nuovo cattolicesimo – cosa che, del tutto evidentemente, non avvenne –, ma perché riconobbe (più di quanto non produsse in autonomia) la fine di una elefantiaca costruzione culturale e politica basata sul connubio tra costantinismo e intransigenza, cioè sull’imperativo del trionfo della verità. Ora, che questo sancisca il non ritorno di un cattolicesimo integralista e fondamentalista, non mi pare largamente compreso nel presente. Un Concilio di altre epoche forse ne avrebbe fatto un dogma, ma il Vaticano II non avrebbe mai potuto, pena contraddire se stesso. Eppure, una delle cose più difficili da comprendere oggi è proprio la novità del Vaticano II e questo non è solo l’effetto di interpretazioni storiografiche o pseudo tali che hanno fatto dell’ermeneutica della continuità la loro bandiera, ma perché questa novità oggi non appare più evidentemente percepibile e il vecchio può apparire come nuovo e il nuovo come antico.
In altri termini, ciò che prevale adesso non è né l’ermeneutica della rottura, né l’ermeneutica della continuità piuttosto l’ermeneutica dell’ambiguità.
Un esempio, all’apparenza spicciolo, di questa ambiguità è rintracciabile nello stile clericale, negli atteggiamenti e nel modo di proporsi dei preti. Il Concilio di Trento e ancora di più la sua interpretazione-applicazione dei secoli successivi, disegnò un nuovo modello di prete improntato alla separatezza, un chierico chiaramente distinto dai laici e riconoscibile nell’abito, nella cultura, nella spiritualità, nel modo di rapportarsi ai comuni fedeli e che trovava nei seminari i luoghi in cui forgiarsi. Un modello di prete che con il trascorrere dei secoli andò sempre più definendosi ma anche sclerotizzandosi, finendo con l’apparire sempre più lontano e diverso dagli umani comuni, incapace di provare le emozioni di tutti, teso a praticare l’amore universale, quel prete che Lorenzo Milani, nella lettera a Luciano Ichino dell’11 maggio 1959, definiva con ironia pericoloso per l’umanità e a cui contrapponeva la sua identità di prete con «cuore carnale e singolare». Un prete spesso impacciato, costretto da risibili limitazioni, come il divieto di andare in bicicletta, mezzo «poco conforme alla dignità del sacerdote e del sacro ministero, e perché facile ad abusi» (Il Buon Pastore. Periodico religioso di Lodi, VII [1894] 546), velocipede di cui anche il cardinale Sarto, futuro papa Pio X, aveva proibito l’uso al clero mantovano. Per questo tipo di prete il Vaticano II sancì un vero e proprio processo di liberazione e di emancipazione umana, che la mia sensibilità infantile percepiva comunque attraverso il clergyman che il mio parroco, anche senza cambiare la sua mentalità, prontamente sostituì alla talare. E così i preti tornarono ad assomigliare agli altri esseri umani che, a loro volta, cominciarono a sentirli come compagni di strada, più consoni al mistero dell’incarnazione per il quale Gesù si sedeva a tavola e mangiava e beveva con gente comune e anche malfamata. Al passare dei decenni, però, ha corrisposto un ulteriore cambiamento che non può essere definito di ritorno alla conservazione tout-court, ma l’affermarsi di un nuovo stile clericale in cui vecchio e nuovo si mescolano, e soprattutto, perdono il collegamento con gli antichi significati. Qualcosa di simile a quel processo avvenuto in ambito civile e che portava Giorgio Gaber, nella sua nota canzone, sia a chiedersi: «Che cos’è la destra? Che cos’è la sinistra?» sia, soprattutto, a dare risposte a queste domande che riflettevano grande confusione, superficialità di attribuzioni e stereotipi a man bassa. Il tutto in linea con quello svuotamento di significati che solo l’assenza di autentica conoscenza storica poteva partorire. Di questi tempi, non è raro imbattersi – soprattutto se si trascorre qualche ora a gironzolare a Roma, Oltretevere particolarmente – in giovani appartenenti a famiglie religiose, anche di recente fondazione, che sfoggiano abiti clericali improntati alla tradizione e di straordinaria eleganza e raffinata fattura, occhiali da sole ultimo grido e taglio di capelli impeccabilmente alla moda. Quanti preti portano ormai i paramenti e la talare, l’abito da cerimonia e il costume da bagno – puntualmente immortalati su Facebook e Instagram (followers, likes e emoticons ad abundantiam) – con lo stesso stile spesso da passerella, spia di nuove forme di protagonismo clericale, ma indice, soprattutto, di grande confusione di significati, sentendosi nuovi e moderni senza sapere, invece, da quale storia emergono? Si è diffuso uno stile clericale che contrasta con i modi da uomo comune, che spiazzano alcuni e scandalizzano altri, le scarpe grosse, l’abito di stoffa dozzinale e la croce di metallo che caratterizzano il portamento di Francesco, il quale per ragioni biografiche, teologiche e culturali affonda invece le sue radici nel Vaticano II.
Ammetto di non aver compreso subito che la serie firmata da Paolo Sorrentino, “The Young Pope”, era da vedere: ma poi l’ho vista. E Lenny Belardo mi ha colpita come uno schiaffo in pieno volto. Con la sua Coca-Cola e la sedia gestatoria, la teologia tridentina e la palestra quotidiana, l’ambiguità costitutiva della sua figura. Prego e scongiuro che non sia metafora di tempi a venire.
Anna Carfora è saggista, docente di Storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!