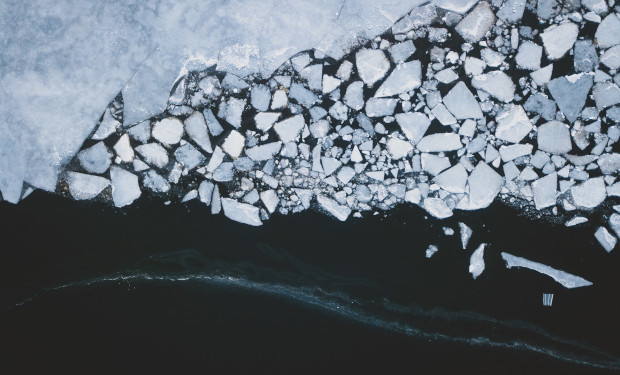
Crisi ambientale. Insistere, insistere, insistere
Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 9 del 11/03/2023
Ferdinando Cotugno scrive attualmente per il quotidiano Domani fondato nel 2020 e diretto da Stefano Feltri. Di origine napoletana, si occupa di temi ambientali, di cui tratta nella newsletter “Areale” pubblicata sempre da Domani. Molto sensibile alle crisi climatica e ambientale che stiamo attraversando, nel 2022 per la Casa Editrice Il Margine ha dato alle stampe Primavera ambientale, in cui esprime la speranza per una nuova rotta, legata anche ai movimenti giovanili, verso una soluzione positiva delle problematiche ambientali. In tale appassionato volumetto parla di una chiamata alle armi contro il cambiamento che può portare alla fine del mondo. L’intervista prende spunto dal libro per andare oltre, in uno sguardo più ampio.
Considerando i risultati della Cop27, tenutasi in Egitto a Sharm El-Sheikh nel novembre 2022, riscriveresti alcune parti di Primavera ambientale?
Sicuramente aggiungerei dei contenuti. La Cop27 [acronimo per Conferenza delle parti] è stato un momento trasformativo e ha reso evidente quanto trattare i cambiamenti climatici possa diventare una piattaforma politica. Gli attivisti, sfruttando la conferenza, hanno posto in primo piano il problema dei prigionieri politici in Egitto e della loro liberazione dimostrando quanto i problemi si intersechino l’uno con l’altro. Da sottolineare come inizialmente gli stessi attivisti non volessero partecipare alla conferenza per poi decidere di prendervi parte dall’interno. Infatti a differenza della Cop26 di Glasgow, dove le grandi proteste si sono svolte all’esterno del palazzo, a Sharm ElSheikh le contestazioni sono avvenute all’interno evidenziando due cose: quanto resti indispensabile lo strumento democratico, pur nei suoi limiti, per dirimere ogni questione; l’importanza delle Cop, anch’esse imperfette e lente, perché in Egitto si sono rivelate l’unico spazio entro il quale sia stata concessa una libera discussione.
Cosa pensi della decisione di far gestire da un lobbista dei fossili la Cop28 che si terrà a Dubai negli Emirati Arabi?
Tutto il male possibile. Questo avviene perché le Cop sono processi inclusivi e quindi devono accettare i lobbisti delle industrie dei fossili, che già hanno rappresentato il 25% dei partecipanti alla Cop26, ma che sono ulteriormente aumentati nella conferenza egiziana. Ne segue che la Cop28 deve risultare un momento fortemente politicizzato, perché se è vero che in Egitto sono stati ottenuti dei successi sulla questione “perdite e danni” [Loss and damage è il risarcimento dei Paesi, spesso del Terzo Mondo, più colpiti dai cambiamenti climatici causati da quelli maggiormente industrializzati], a Dubai bisognerà molto insistere sul capitolo mitigazione per ottenere progressi superiori, nella consapevolezza di andare a parlare di questi temi nella tana del lupo. Ma ciò deve costituire uno sprone a insistere e a non abbandonare uno strumento come quello della Cop, anzi a far diventare la prossima edizione la madre di tutte le battaglie.
Come è possibile sensibilizzare il grande pubblico, che vive nella grande bolla dell’illusione della crescita infinita alle spese del pianeta del Capitalocene, a questi temi?
Questa è la grande domanda. Probabilmente molte persone che vivono ancora all’interno della bolla hanno interiorizzato in modo inconsapevole le storture del sistema. La crisi climatica è esplosa e il negazionismo totale è più raro e minoritario. È necessario comprendere come questa non sia una crisi ecologica bensì una crisi sociale, dove il punto è trovare un raccordo che possa collegare tutti gli elementi di una storia che non è solo narrazione di un collasso ecologico ma anche di disuguaglianze. L'ultimo rapporto del World Inequality Lab dice qualcosa di interessante: le differenze di emissioni all’interno dei Paesi sono più marcate di quelle fra Paesi, quindi la crisi climatica più che una questione di geografia è una questione di classi sociali. Ciò implica che un regime fiscale più aggressivo, che distribuisca le risorse in modo più efficace, nonché andare a intaccare quei poteri assoluti, i cui numeri sono raddoppiati, sono anche misure ecologiche. Quindi il grande tema è collegare i problemi della povertà e del reddito a quelli del clima. È questa narrazione che bisogna che la politica impari a raccontare e a costruire.
Pensi che in Italia l’attuale governo possa occuparsene?
No, naturalmente no. D’altra parte è un momento delicato e sofferto per tutta l’opposizione, ma è anche il momento, dopo aver perso molto tempo, per costruire l’alternativa. È il momento dell’ora o mai più per costruire qualcosa di diverso, specie per un Paese come l’Italia che si ritrova nel picco della crisi climatica con un governo che si disinteressa totalmente a queste problematiche, e che di fatto non partecipa nemmeno alle Cop: non avendo nessuna preparazione, nessuna competenza e nessuna consapevolezza. Il periodo storico è drammatico, ma proprio perché tale va costruito un discorso politico più incisivo la cui scadenza non può essere questa legislatura ma la fine del decennio e la prossima legislatura. L’orizzonte non va costruito nel 2027 ma oggi. Nel 2024 ci saranno le elezioni europee che rappresenteranno un momento molto importante, ricordando come il Great New Deal europeo sia importante, costituendo il più grande piano di decarbonizzazione. Perciò per le prossime Europee sarà necessario vedere qualcosa di nuovo in termini di elaborazione, di persone e di liste.
Il Congresso PD può rappresentare un fatto propositivo dal punto di vista ambientale?
Sulla carta sì. In realtà molto poco, C’è poco di interessante sotto il profilo dell’ecologia, dei contenuti ambientali sul piano politico nei programmi dei vari candidati del PD.
Quindi la politica chi la dovrebbe fare, i movimenti giovanili che nel libro dimostri di apprezzare molto?
La politica la deve fare il PD, la devono fare i movimenti giovanili che sicuramente hanno tanto potenziale d’azione. Ma in generale la devono fare tutti, tutta la società civile. L’Italia ha un grande vantaggio nei suoi svantaggi, è un Paese in cui le cose procedono molto velocemente: la storia del Movimento Cinque Stelle ce lo insegna, come quella di Forza Italia o di Fratelli d'Italia. Per cui nel 2024 o nel 2027 potranno succedere cose impensabili, al pari di quanto accaduto nel 2013. Questo è ciò che auspico, basti pensare come il Movimento Cinque Stelle si stia riposizionando in Europa sui temi ambientali, perché capisce che è su di essi che può accadere qualcosa. Nella società si muovono molte cose, purtroppo le elezioni anticipate di sei mesi hanno bloccato diversi processi. Per esempio il percorso intrapreso dall’Alleanza per la Transizione Ecologica (ATE) con il programma di Edo Ronchi, che doveva tenere il congresso a Firenze. Un programma incompleto ma che andava saldato con altri pezzi della società. Oggi le regionali e il Congresso Pd costituiscono un momento di sospensione cui deve far seguito qualcosa di costruttivo.
Rispetto alla crisi ambientale ti senti ottimista o pessimista?
Esistono ragioni per essere ottimisti e altre per essere pessimisti. Si tratta di una scelta politica. Il pessimismo è anche un privilegio, la crisi climatica non è un interruttore che si può accendere o spegnere ma è un continuum, e il punto su cui posizionarsi dipende da tante piccole cose che non concedono il lusso di essere pessimisti o apocalittici. Non è una finale di Champions in cui si vince o si perde. Ogni punto in cui ci si posiziona è importante per la vita umana. Il pessimismo e l’ansia sono un diritto ma bisogna conservare la speranza, perché se ci trovassimo nella situazione del 2013 saremmo sull’orlo dell’apocalisse, però nel frattempo ci sono state la Conferenza di Parigi, Greta Thunberg e l’enciclica papale e le prospettive sono migliorate. Tutto dipende da ciò che facciamo oggi, economicamente, socialmente, culturalmente.
Sempre nel libro esalti il ruolo dell’Europa come promotrice del cambiamento nella crisi climatica, rimani sempre di questa opinione dopo la Cop27?
Anche in questo caso ci sono motivi per essere ottimisti e motivi per essere pessimisti, comunque alla Cop27 l’Europa è stata il baluardo della mitigazione. Non sta facendo abbastanza, ma è l’area del mondo che sta facendo di più e anche l’ultimo piano industriale presentato dalla Commissione europea per la transizione verde nell’industria è interessante, inoltre c’è molto fermento. L'Europa è ciò che noi ne facciamo, e può diventare un’altra cosa. Non è un’entità astratta ma è frutto di una serie di processi politici e sociali. Se non avessimo avuto l’attuale commissione saremmo messi molto peggio, come umanità, come Europa, come mondo con tutti i limiti. Per esempio la regola sulla deforestazione importata o la messa al bando della plastica monouso potevano essere migliorate, però è già un bene averle fatte, e l’Europa è stata l’unica. Come europei siamo in partita ed è importante rimanerci. Ripeto le elezioni europee del 2024 sono di estrema importanza anche perché capitano a metà del decennio decisivo per le sorti dell’umanità. L’Europa sembrerà irrilevante dal punto di vista geopolitico, ma in realtà tutti guardano a come agisce.
Un’ultima domanda di attualità ambientale: la morte dell’orso marsicano Juan Carrito (M20) in Abruzzo di cosa è specchio rispetto alla nostra società?
È specchio del fatto che noi uomini continuiamo a guardare alla Natura come un qualcosa d’altro posto oltre una frattura. Un che di estraneo in cui andiamo, e a cui non guardiamo con la giusta distanza. Imparare a percepire anche noi come Natura significa raggiungere un giusto equilibrio con elementi più fragili: una popolazione di 50 membri di orsi in un territorio così piccolo e antropizzato come l’Abruzzo è un elemento fragile della biodiversità, e non abbiamo ancora capito come posizionarci per cui abbiamo trattato quell’orso, tutti gli orsi, come una risorsa, come un feticcio, come un gioco. I video dell’orso li abbiamo visti tutti, e poi è morto investito. Questo significa che era circondato dagli esseri umani, e alla fine è morto dall’essere circondato. Noi abbiamo preso tanto da quell’orso: divertimento, simbologia. Ma va ricordato che un solo esemplare che si perde rappresenta una catastrofe. L’Abruzzo giustamente capitalizza la presenza degli orsi, ma a questa capitalizzazione deve seguire una restituzione. È necessario acquisire un rapporto di reciproca responsabilità con gli ecosistemi: prendiamo e prendiamo, ma se si tratta di costruire corridoi ecologici (costruire barriere, rispettare i limiti di velocità, mettere in sicurezza le strade) non si fa nulla. La storia di Juan Carrito ci insegna che sapevamo che l’avremmo perso, è stata la cronaca di una morte annunciata. Purtroppo l’estrattivismo come concetto è qualcosa che abbiamo applicato anche agli orsi marsicani: ma l’estrattivismo uccide.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


