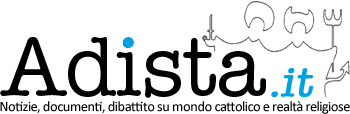«...E abusarono di lei tutta la notte»
Tratto da: Adista Documenti n° 32 del 22/09/2018
Per l'introduzione a questo articolo, clicca qui
1. «Mi racconta Enana Damlash, una rifugiata etiope in Italia – leggo su Famiglia cristiana del 29 agosto ("Migranti,Il racconto straziante delle donne che hanno subito violenza 29/08/2018" di Katia Fitermann – che la sera prima che la imbarcassero su un gommone malandato, a Tripoli (era stata incarcerata in Libia con la figlia neonata per tre lunghi anni), i libici erano entrati nel magazzino dove i prigionieri erano stati stipati come animali e avevano deciso di portare via con loro una bambina di sei anni, strappandola alla madre che implorava pietà, supplicando che non gliela portassero via. Per tutta la notte la piccola era stata violentata dai carcerieri e quando è stata restituita alla madre era ormai irriconoscibile: «Aveva gli occhi bianchi, senza colore, era priva di coscienza, piena di lividi, ferita e sanguinante»[…]. «La bambina sembrava morta, ma respirava piano. Sua madre era ormai completamente impazzita e dalla disperazione si graffiava il proprio volto e il corpo, piangeva e si strappava i capelli. Provavamo tanta pietà per lei, che era riuscita quasi fino alla fine di quell’inferno a proteggere la bimba dalle violenze sessuali in Libia, subendole lei al suo posto. Durante il viaggio la madre della piccola si è lasciata cadere in mare ed è scomparsa tra le onde. La bambina l’avevamo adagiata sul gommone. Abbiamo custodito noi il suo corpo esanime per tutto il viaggio e quando siamo stati salvati in mare da una nave italia na, dopo tre giorni alla deriva, ci hanno portato a Lampedusa e lei è stata soccorsa per prima. Ci hanno soltanto detto che era ancora viva e ho pianto di gioia».
Dal momento in cui mi sono imbattuta in queste parole, le custodisco in me; mi riprometto di dare loro dimora nel tempo, per quanto posso. Quel male che Etty Hillesum incontrava nei campi si ripresenta crudeltà indicibile. Eppure gli accenti leggeri di questa rifugiata restituiscono con stremata gentilezza un sentimento alto, una misericordia ferita ma resistente. Ripete due volte che le donne, nell’inferno dei campi di concentramento libici, vivono un ‘afflizione ancor più tremenda (“Gli orrori della Libia si moltiplicano in maniera esponenziale quando la vittima è una ragazza oppure un bambino”). Il suo cuore è capace della larghe ali della pietà. Ed io? Mi sono risposta: non dimenticare; non lasciare che lo strazio di questa madre e della bambina del racconto – prese come icona per tutte le vittime – vengano seppellite nell’oblio.
2. Sento dunque il dovere di restituire loro dignità; di custodire la loro storia e sedimentarla là dove posso. Non so quanto ne sarò in grado.
Un enunciato si erge sul resto del brano: è entrato in risonanza con un frammento di un testo antico: la Bibbia.
«Per tutta la notte la piccola era stata violentata dai carcerieri…», sussurra la testimone migrante; «Essi la presero e abusarono di lei tutta la notte fino al mattino», recita in controcanto il versetto 25 del cap. 19 del libro dei Giudici.
“La moglie (o la concubina, a seconda delle traduzioni) del levita”, è il titolo di questo passo, l’ultimo episodio del libro. Un levita che abita sulle montagne di Efraim prende come concubina-moglie una donna di Betlemme e la porta con sé. In un primo momento, l’anonima donna – il cui vuoto di parole, lungo tutto il brano, sgomenta – si oppone, ma poi è costretta a cedere ed è obbligata a seguirlo, a divenire “sua proprietà”. È una stagione in cui la terra di Israele è divorata dall’anarchia. «In quel tempo non c’era re in Israele, ognuno faceva quanto era bene ai suoi occhi» (Gdc 21,25) sono le ultime parole del libro. I due, spostandosi, sono costretti a pernottare a Gabàa, città schierata con una tribù rivale (Beniamiti). Trovano ospitalità presso un vecchio; irrompono però alcuni abitanti del posto che, trasgredendo il sacro dovere della ospitalità, pretendono, in nome del loro appartenenza identitaria, di esercitare il “diritto” di riscuotere il “tributo” dell’abuso sessuale. Proprio lui è indicato come oggetto del pervertimento, ma egli lo devia su di lei; spinta fuori dalla casa per mano dello stesso levita, a lei spetterà la crudele sorte di essere “data in pasto” ai predatori. Le violenze, protratte per tutta la notte, la straziano indicibilmente. «La mattina, la si vede giacere con le mani sulla soglia» (Gdc 19,27), un gesto altamente simbolico. «Alzati, dobbiamo partire»!» (19,28) le ingiunge lui. Ma lei è morta. Segue la scena truculenta in cui egli prende un coltello e fa a pezzi il suo cadavere, in dodici parti che manda ad ogni tribù di Israele, con l’intento, vile, meschino, strumentale, di denunciare la violenza commessa da “nemici”. L’infamia dello stupro di gruppo si moltiplica dunque nell’orrore inenarrabile della mutilazione e dello scempio del corpo della donna. La storia termina riportando i risvolti sul piano politico. Sepolto nella insignificanza simbolica, il martirio della donna esce di scena e dall’orizzonte di senso.
Il registro discorsivo del narratore è di assoluta imperturbabilità, assai diverso da quello della rifugiata etiope: è un’anima disidratata, un cuore di pietra (Ez 36,26-27).
Se è vero che le finalità del testo erano quelle di argomentare sui guasti rovinosi dell’anomia politica e sociale, sull’infrazione di quel principio che sono le sacre leggi dell’ospitalità, ciò non basta a comprendere come la descrizione di tanta efferatezza possa inverarsi in una forma così cruda, così asettica. Nessun giudizio di valore sull’abiezione del levita, che si autoassolve peraltro da ogni responsabilità; nessun palpito umano, venato di compassione; nessun riscatto, nessun sussulto incrina il tono distaccato del discorso, nessuna crepa o cedimento. Nulla restituisce dignità alla donna di Betlemme.
3. «E abusarono di lei tutta la notte». Quante volte tali crimini si saranno ripetuti nella storia patriarcale? Come abbiamo appena letto, tuttora le atrocità si accaniscono sul corpo femminile. E, come in un abisso infinito di sevizie inflitte a donne e bambin*, le immagini di esse, non raramente, piuttosto che ingenerare disgusto od orrore, sono riprodotte nei canali mediatici, o commercializzate perché eccitanti. Non mi interessa la stigmatizzazione morale della pornografia. Mi interessa piuttosto osservare che la sollecitazione lubrica è possibile solo in virtù del fatto che si assume una prospettiva che è quella del “carnefice”, un punto di vista che cancella dal suo orizzonte la immedesimazione con la vittima; lei è stata resa cosa o strumento di un godimento che non la riguarda, anzi, che per lei è tortura.
Tale assenza di empatia e immedesimazione per il dolore della vittima di stupro attecchisce con grande baldanza nelle culture patriarcali; cresce potentemente in quella contemporanea, animata com’è da narcisismi e seduzioni di volontà di potenza maschili. Gli stereotipi sedimentati nel tempo del naturale istinto sessuale maschile, della naturale pulsione predatoria del maschio si sposano magnificamente con quello del naturale destino femminile ad essere preda. In base a questi assunti, che la preda abbia solo sei anni, che sia in stato di bisogno e sia stata strappata alla madre (che poi si è lasciata morire) non scuote il granitico fondamento che una “legge di natura” avrebbe decretato. Secondo i paradigmi patriarcali, essa è immutabile: la struttura genetica del maschio lo indirizza al dominio e alla guida della donna, inclinazione che gli permette di usare la donna a restituirgli, come in uno specchio, la sua immagine di essere superiore, e di “sfogarsi” al bisogno. Nei racconti citati sopra, si è arrivati – come nelle stagioni dei conflitti armati e delle guerre – alla radicalità estrema di tale “vocazione” ma schile al dominio. In queste manifestazioni crudeli, erompe uno sconfinato delirio di onnipotenza, radicato nella irrefrenabile voluttà distruttiva e autodistruttiva, che con Freudchiamiamo “istinto di morte”. Sesso e morte, sadismo e sacrificio esemplarmente intrecciati in queste parole non a caso di un militare: «Io credo che quasi tutti gli uomini che sono stati in guerra dovranno ammettere, se sono onesti, che da qualche parte, dentro di loro, ne hanno anche goduto (…). Era così bello, avevo il potere di vita e di morte (…) è la droga migliore che esista, la scopata migliore mai fatta (…)». È un ex marine che scrive (In Joanna Bourk, Le seduzioni della guerra. Miti e storie di soldati in battaglia, Carocci 2003) . L’immaginario sessuale, filtrato con lo sguardo di lui, rifugge con orrore da tale consapevolezza. Preferisce credersi animato dallo slancio vitale della giovinezza, – l’età delle trasgressioni – con la complicità di una cultura accondiscendente che sempre ammicca alla spensieratezza piuttosto che alla presa di coscienza, che del maschio titilla il cullarsi nell’oppio di un narcisismo egoista, di una fissazione a fasi infantili della vita.
Lo stupro è dunque sì deplorato, ma una riprovazione che dovrebbe essere incondizionata è invece tiepida, modesta, costellata da crepe morali; e, da parte di non pochi uomini, accompagnata da ammiccamenti libidinosi. L’impunità sociale e simbolica – non percepita come vero scandalo – e la banalizzazione del male inflitto moltiplicano il torto, la pena e, per quel che mi riguarda, la collera. Avvolto in un cono d’ombra rimane quanto le donne possano patire: per l’aggressione in sé, sempre feroce, dove la morte si annuncia (o è) prossima, per i traumi devastanti che ne conseguono, per i sospetti sulla sua complicità e le riserve di inattendibilità delle denunce, per i capovolgimenti di colpa operati dall’opinione pubblica e non solo, per l’ irrilevanza con cui i crimini sessuali vengono recepiti, per l’inospitalità delle persone a farsi carico del male che le donne testimoniano (quando il veleno del silenzio si dilegua).
4. La storia della madre e della figlia di sei anni torturata a Tripoli, e quella della donna di Betlemme, così distanti tra loro per mille ragioni, racchiudono la comunione di quella frase incandescente. E insieme sollevano una domanda: dov’era Dio in quella notte?
Il racconto di Giudici 19, infatti, non solo è intollerabile per i tratti sopra esposti, ma lo è anche per l’eclisse di Dio. Non un cenno a un Dio che, come in tante altri momenti e paesaggi biblici, geme e piange per le sventure del suo popolo. E se è con Elie Wiesel che s’affaccia la domanda, è da lui che viene suggerita la risposta: Dio è in quel corpo straziato, in quegli occhi bianchi, senza colore, privi di coscienza, in quel corpo pieno di lividi, ferito e sanguinante della bambina torturata in Libia ed ora sbarcata a Lampedusa. Come cristiana, aggiungo: al fianco del corpo abusato, seviziato, massacrato, spezzato – come quello della donna di Betlemme – si distende l’icona della Croce. La statua di Christa (Scultura di Edwina Sandys, installazione messa in mostra nel 1984 nella cattedrale di St. John the Divine a New York) è stata teologicamente oggetto di anatema. Vorrei qui convocarla, poiché essa è emblema del mistero di una Croce che si fa sostanza, icona di un “impronunciabile” nelle dottrine e nei simboli delle Chiese: le torture perpetrate sul corpo femminile. La donna è “insacrificabile”: questo è l’annuncio della Christa. L’icona rifugge dalla “mistica” del sacrificio (dalla logica della sopportazione della sofferenza, pegno di un risarcimento futuro); essa è piuttosto sigillo di “cattiva coscienza” patriarcale, anche nelle Chiese. Sollecita l’effondersi di desideri trasformativi, in nome per compimento dei talenti da Dio donati e della vocazione alla libertà che il Vangelo ha dischiuso. Consapevoli che Dio-Sapienza «…ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore/ha rovesciato i potenti dai troni,/ha innalzato gli [e le] umili;/ha ricolmato di beni gli [e le] affamate». Le donne di fede terranno accesa la memoria delle donne massacrate allora e ora, smascherando l’inganno della cultura patriarcale e annunciando la forza divina che ne sigilla il tramonto.
Christa, opera bronzea di Edwina Sandys (1975), esposta dal 1984 nella cattedrale di St. John The Divine (NYC) e definitivamente donata alla Chiesa dall'artista nel 2015; foto [ritagliata] tratta da A-Rivista Anarchica, sito web
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!