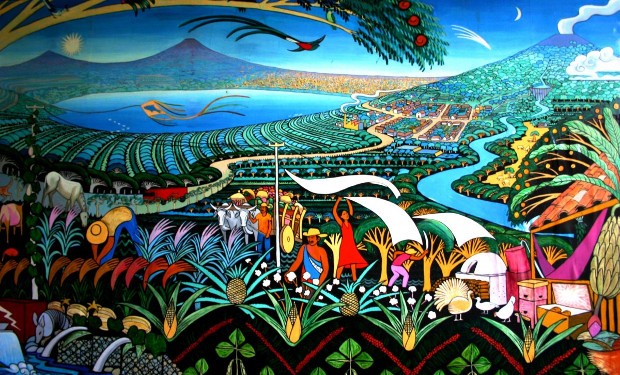
Le colpe di tutti i poteri, le ragioni del popolo. Intervista a Marco Cantarelli
Tratto da: Adista Documenti n° 38 del 03/11/2018
Per l'introduzione a questo articolo, clicca qui
Quale clima si respira in questo momento in Nicaragua? Un clima di permanente tensione, paura, a tratti di terrore, comunque di costante preoccupazione per il futuro. Dal 18 aprile scorso, cioè da quando è scoppiata l'“insurrezione civica”, ai primi di ottobre, si contano centinaia di morti: fra 325 e 512, a seconda delle organizzazioni di difesa dei diritti umani, in soverchiante maggioranza oppositori del regime; circa 200, secondo quest'ultimo, per il quale i caduti sarebbero, invece, quasi tutti suoi sostenitori, il che appare alquanto surreale; cui si aggiungono migliaia di feriti, arrestati – di cui circa 350 processati per direttissima, spesso senza badare troppo al rispetto delle garanzie giuridiche proprie della difesa –, un numero imprecisato di desaparecidos, circa 25 mila persone riparate all'estero, soprattutto in Costa Rica, per sfuggire alla repressione. E, purtroppo, in questo contesto già drammatico, si vanno moltiplicando le denunce di vari fermati di aver subito violenze e torture; testimonianze inquietanti in questo senso sono disponibili sui social network.
Come si è potuta sviluppare una situazione tanto violenta?
Secondo la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, dall'aprile scorso, la repressione delle proteste antigovernative ha visto tre fasi: la prima, di uso smisurato ed indiscriminato della forza; la seconda, di terrorismo di Stato; quindi, di repressione selettiva e criminalizzazione della protesta, che suppone un sofisticato sistema di controllo a tutti i livelli. Oggi, una quarta fase sembra aprirsi con misure repressive nei confronti di giornalisti, anche stranieri. Ciò porta la Commissione a denunciare uno «stato d'eccezione»: vale a dire, una sospensione dello stato di diritto paradossalmente legalizzata.
Qual è stato il costo economico di questo conflitto?
Sul piano socio-economico, circa 350 mila posti di lavoro sono andati persi, soprattutto nel settore “informale” (piccolo commercio, servizi, artigianato); ma anche “grandi” imprese ed esercizi commerciali hanno chiuso, sospeso o ridotto le attività; settori come il turismo (alberghi, ristoranti) o l'edilizia sono al collasso; in generale, tutta la produzione agricola e zootecnica risente della caduta dei consumi interni e della mancanza di credito, mentre è venuto meno il mercato venezuelano per quanto riguarda le esportazioni. Persino l'attività mineraria pare in difficoltà. In breve, dal 1° ottobre, il Paese è formalmente in recessione. Gli aiuti venezuelani sono un ricordo. La gente fa la fila in banca per ritirare i propri risparmi in dollari, nel timore di non poterlo fare nel prossimo futuro. Le università sono chiuse – qualcuna sta riaprendo in questi giorni, pur tra le proteste giovanili – ma per molti studenti l'anno accademico sembra compromesso. Circa 300, fra medici e infermieri, sono stati licenziati dagli ospedali pubblici per aver soccorso manifestanti dell'opposizione feriti nelle proteste. Insomma, il Paese pare ben lungi dall'essere “normalizzato” come proclama il regime.
Di quanto consenso gode la coppia presidenziale? Le manifestazioni pro-governative sembrano riunire ancora molta gente...
Secondo un sondaggio della CID-Gallup compiuto fra il 6 e il 18 Settembre, il consenso al Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale (FSLN) – o a quel che ne rimane, dopo che quasi tutte le figure storiche del sandinismo l'hanno abbandonato in questi anni – è sceso al 23% della popolazione; era al 38% nel 2006, quando Daniel Ortega tornò al potere.
In questo quadro, non c'è dubbio che la crisi apertasi in aprile abbia accelerato la perdita di consenso della “coppia presidenziale”, peraltro già minata da scandali; in particolare, su Rosario Murillo, vicepresidente e consorte di Daniel Ortega, sembrano accanirsi i giudizi negativi di parte della popolazione.
Secondo lo stesso sondaggio, il 60% dei nicaraguensi vorrebbe anticipare le elezioni nel 2019, come richiesto dalla piazza in questi mesi, a fronte di un 34% che si dice contrario e un 6% di indecisi. Ed è interessante notare come, davanti ad un'eventuale scelta fra elezioni anticipate – e, va da sé, monitorate da osservatori indipendenti ed internazionali – e la ripresa del negoziato, il cosiddetto Dialogo Nazionale, il 54% si dica favorevole al voto, a fronte di un 34% più incline alla ripresa dei colloqui e un 12% di indecisi. Tuttavia, Daniel Ortega ha ripetutamente escluso di anticipare il voto previsto nel 2021 e non pare minimamente intenzionato a garantire un processo elettorale trasparente e democratico nemmeno per quella data.
Quanto all'affluenza alle manifestazioni filogovernative, così come a quelle dell'opposizione, bisogna essere cauti: è noto come, a volte, il regime metta a disposizione veicoli pubblici per trasportare i partecipanti, molti dei quali impiegati pubblici in qualche modo “precettati”, pena la perdita del posto di lavoro. Ciononostante, i “numeri” vantati dal governo paiono gonfiati dalla propaganda, grazie anche a qualche trucco di mestiere, e contestati dalle immagini raccolte da altri media e dall'opposizione. Che a sua volta, dopo le manifestazioni di massa dei mesi scorsi, con cui sperava di dare la “spallata finale” al regime, sembra aver optato per manifestazioni decentrate nei quartieri, forse meno visibili e numerose, ma più a contatto con la gente.
Molto si è parlato della brutale repressione da parte del governo. Ma è vero che anche tra i manifestanti c'è chi si è macchiato di gravi atti di violenza?
Sì. Soprattutto nel contesto delle violente operazioni di “pulizia” delle strade e città del Paese da barricate e blocchi stradali si sono prodotti scontri assai duri fra la polizia, spalleggiata da corpi paramilitari creati dal regime, e insorti. Tali fatti sono documentati dalle organizzazioni di difesa dei diritti umani. Ma il numero di vittime di tali episodi, comunque esecrabili, non ha paragone con quello dei caduti fra i manifestanti. Enorme è la sproporzione di strumenti militari utilizzati: polizia e corpi paramilitari dispongono di armamento sofisticato – tra cui il micidiale fucile Dragunov, con il quale tiratori scelti hanno dato la morte a decine di manifestanti –, cui gruppi minoritari di giovani ribelli oppongono il più delle volte armi di fabbricazione artigianale. Molti di quegli episodi paiono reazioni di “legittima difesa” di fronte alla violenza sistematica perpetrata da corpi dello Stato e paramilitari. Ma, ad oggi, non ci sono segnali di una deriva violenta della protesta. L'opposizione sa benissimo che una scelta di quel tipo gioverebbe solo al regime, che forse non aspetta altro per sedare gli “opposti estremismi”. Del resto, il popolo nicaraguense è stanco di guerre e, con ogni probabilità, non seguirebbe chi volesse avventurarsi su quel cammino. In un Paese dove non mancano certo le armi, l'essere riusciti a preservare fin qui il carattere pacifico della rivolta appare già un grosso risultato e una novità degna di nota nel panorama latinoamericano.
La comunità internazionale come è intervenuta?
In questo contesto, lo scorso 2 ottobre, la rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha nuovamente esortato il governo nicaraguense a «mettere fine all'uso sproporzionato della forza», «liberare i manifestanti pacifici » detenuti «sulla base di leggi che criminalizzano le proteste pacifiche», cessare la repressione e le detenzioni arbitrarie, e sciogliere i gruppi armati irregolari. «La situazione nel Paese continua a essere motivo di grave preoccupazione per la UE» ha proseguito Mogherini, che ha denunciato la «mancanza di impegno di Managua nel dialogo nazionale», mentre «la repressione delle autorità mina gravemente i principi di base della democrazia e lo Stato di diritto». La UE sollecita in tal senso il governo nicaraguense a permettere il ritorno nel Paese dell'Ufficio dell'Alto Commissario dei Diritti Umani dell'ONU e dare tutto l'appoggio necessario al Gruppo Interdisciplinare di Esperti Indipendenti, per monitorare il rispetto dei diritti umani. Nei fatti, il citato Ufficio dell'ONU è stato espulso a fine agosto da Ortega, dopo aver pubblicato un duro rapporto sulle violazioni perpetrate dal regime, il quale, secondo la UE, «lungi dal riconoscere gli atti illeciti commessi» da polizia e altri corpi, ne attribuisce la responsabilità alla «violenza golpista».
Non c'è dubbio che l'intero assetto istituzionale del Nicaragua sia stato piegato agli interessi di Ortega e Murillo, che controllano tutti gli organi costituzionali e i poteri legislativo, giudiziario, elettorale. Non solo: la polizia ha cessato di essere un corpo neutrale, a protezione di tutta la cittadinanza – è sotto gli occhi di tutti come attacchi i manifestanti dell'opposizione e protegga quanti li attaccano –, mentre la creazione di corpi paramilitari (gli “incappucciati” armati di tutto punto che seminano il terrore nel Paese), sembra foriera di nuovi e gravi problemi di sicurezza: che ne sarà di essi, infatti, quando la crisi terminerà, in un modo o nell'altro? Di certo, la loro presenza è già oggi mal vista, tra gli altri, da settori dell'esercito, il cui ruolo nella crisi è cruciale.
Sulla drammatica crisi in Nicaragua il campo progressista e di sinistra latinoamericano non potrebbe essere più diviso: governi, partiti, esponenti politici, intellettuali si scontrano e si accusano reciprocamente in nome dei valori sandinisti.
Che l'attuale situazione in Nicaragua interroghi la sinistra, latinoamericana e non, mi pare salutare. La riflessione può contribuire, tra l'altro, a comprendere alcuni dei motivi del declino delle forze progressiste che, pur con qualche eccezione, si osserva da tempo nel continente. A patto di scavare nella realtà, rifuggendo da facili schematismi.
Il “modello” economico di Ortega è stato non meno “estrattivista” – oro, legname, allevamento intensivo, ecc. – di altri applicati nel continente dalle sinistre al governo, con i risultati che sappiamo. Gli aiuti venezuelani – petrolio, soprattutto – hanno favorito un'accumulazione di capitali in mani private, mitigata solo in parte da una copiosa erogazione di sussidi di vario tipo alle classi popolari, ma non solo, alimentando clientele politiche, non certo un “progetto socialista”...
I primi a parlare di “dittatura” nel Paese sono stati eminenti e storiche figure del sandinismo, che hanno denunciato la progressiva riduzione dell'FSLN ad apparato di potere al servizio di Daniel Ortega e Rosario Murillo.
La narrazione dei fatti propagandata dal regime e ripresa da settori di sinistra nel mondo tende, invece, ad accreditare l'idea di un governo “rivoluzionario” aggredito dall'imperialismo statunitense che non tollera una “rivoluzione socialista” nel suo “cortile di casa”, al pari di Cuba e Venezuela. In questo quadro, l'insurrezione di aprile sarebbe frutto di un “complotto” dell'amministrazione Trump ed i manifestanti dei “terroristi” foraggiati da Washington che avrebbero tentato, senza riuscirci, un “colpo di Stato” contro il governo di Managua, con il sostegno della Chiesa cattolica e dell'impresa privata nicaraguensi.
L'unico punto di contatto appare il giudizio sul ruolo de gli Stati Uniti, decisi a sfruttare, sostenere e finanziare le proteste al fine di recuperare il terreno perduto nel loro eterno patio trasero (il cortile di casa). Ma quanto è legittimo parlare di un tentativo di golpe suave?
Sostenere che l'insurrezione civica iniziata in aprile sia frutto di una macchinazione dell'impero solleva domande cui pare difficile rispondere per il governo nicaraguense.
Intanto, di tale tentativo di golpe non c'è traccia secondo l'ONU, per citare solo una fonte. Di quali atti di terrorismo si sarebbero, poi, macchiati i manifestanti non è dato sapere. E dov'erano queste migliaia di “terroristi” prima del 18 aprile? Possibile che nessun organo di sicurezza interna si fosse accorto della loro esistenza e delle loro trame?
Al riguardo, va ricordato come fino al marzo scorso il Nicaragua facesse piuttosto sfoggio della sua “stabilità” istituzionale, politica ed economica. Il governo di Daniel Ortega poggiava su una solida alleanza con la gerarchia cattolica (e le chiese evangeliche) e l'impresa privata, evidentemente poco preoccupate del carattere “socialista” del progetto orteguista...
Quanto agli Stati Uniti, la politica di tacita, ma sostanziale “non belligeranza” osservata durante la presidenza Obama ha cominciato ad incrinarsi dopo la rielezione di Ortega, a fine 2016, e il successo elettorale dichiarato dall'FSLN nelle elezioni municipali dell'anno seguente, entrambe le “vittorie” considerate dagli USA – e non solo – frutto di frodi elettorali. Di conseguenza, l'amministrazione Trump ha cominciato a sanzionare – per corruzione e violazione dei diritti umani – uomini del circolo di potere più vicino a Ortega; quali Roberto Rivas, presidente del Potere Elettorale e figura chiave nell'alleanza con il cardinale Obando; Francisco Díaz, oggi capo della Polizia e consuocero di Ortega e Murillo; Francisco López, tesoriere dell'FSLN e vicepresidente del consorzio di imprese che ha gestito, in forma privatistica – cioè, al di fuori del bilancio statale –, la cooperazione venezuelana; Fidel Moreno, segretario politico dell'FSLN di Managua.
Quale strategia statunitense si intravede per il futuro del Nicaragua?
Altre sanzioni appaiono all'orizzonte, forse più pesanti delle prime, che potrebbero imprimere una svolta alla crisi. Washington pare preoccupata per la presenza russa in settori strategici e per il possibile riciclaggio nel Paese di denaro “sporco” frutto di corruzione e traffici illeciti.
Tuttavia, l'insurrezione civica di aprile sembra aver colto di sorpresa anche gli Stati Uniti, come tutti del resto. E proprio per la natura spontanea e ancora disorganizzata di tale movimento – anche se un tentativo di unificazione dell'opposizione è proprio di questi giorni, con la creazione dell'Unione Nazionale Azzurro e Bianco (i colori della bandiera nicaraguense) –, essi faticano a individuarne la “testa” con cui eventualmente trattare. È vero: ingenuità politica sono state commesse da qualche giovane leader della rivolta in occasione di visite negli Stati Uniti, ma sono parsi “incidenti di percorso” dettati da inesperienza, che non modificano il quadro di fondo.
Quanto nuoce alla causa della ribellione popolare la repentina conversione del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), che, dopo aver felicemente cogovernato, a tutto vantaggio del capitale internazionale, si è spostato armi e bagagli all'opposizione?
Per anni, la grande impresa nicaraguense ha tratto enormi profitti dall'alleanza con il regime, esportando, fondamentalmente, prodotti agricoli in Venezuela nel quadro degli accordi commerciali fra i due paesi e godendo di ogni tipo di agevolazioni fiscali.
Oggi, al pari di altri settori, essa ha compreso come Daniel Ortega si sia infilato in un vicolo cieco. Ha sperato nel Dialogo Nazionale, come sede negoziale, ma anche quella porta è, al momento, chiusa. Ha tentato di esercitare la propria egemonia sul movimento ma senza riuscirci, almeno finora. Va da sé che nella soluzione della crisi, in qualunque scenario, essa può avere un ruolo cruciale, anche se, al momento, non pare in grado di determinare alcun esito della stessa.
Come giudichi l'operato di vescovi e sacerdoti? Se è ben noto il patto stretto da Ortega con il cardinale Obando y Bravo, anche da parte del card. Brenes sono mancate in questi anni vere critiche all'operato del governo. E rare e deboli sono apparse le posizioni della gerarchia rispetto, per esempio, alla questione del Canale interoceanico, che pure è stato il tema che ha più suscitato resistenza all'interno della popolazione. Non sono un po' tardive le denunce dei vertici ecclesiastici?
Invero, già nel maggio del 2014, la Conferenza Episcopale nicaraguense aveva consegnato al governo un documento, articolato in 45 punti, in cui parlava di involuzione autoritaria, crisi istituzionale, abusi di potere, manipolazione dei sentimenti religiosi del popolo, concentrazione della ricchezza in poche mani... Quel documento dedicava anche un punto alle problematiche sollevate dal progetto di Canale interoceanico. Di conseguenza, i vescovi affermavano la necessità di un dialogo nazionale, di elezioni trasparenti, di un rinnovamento politico – «nessuno è eterno», scrivevano in riferimento esplicito a Ortega – per ristabilire «la normalità politica di un autentico Stato democratico».
Il regime si è mostrato sordo a quell'appello e ha continuato a tessere relazioni con vari esponenti ecclesiastici, elargendo loro favori, del resto sollecitati e bene accolti dal clero nicaraguense in ragione di una concezione “preconciliare” dei rapporti fra Chiesa e Stato, che, apparentemente, né la Teologia della Liberazione, né la Rivoluzione Sandinista negli anni '80 sono riuscite a scalfire sul piano culturale. Ciò spiega anche la varietà e, persino, la contraddittorietà di posizioni all'interno della Chiesa cattolica.
Anche quello schema è, tuttavia, saltato in aprile: forse, ai vescovi nicaraguensi difetterà la carica profetica di un monsignor Romero, ma vari di essi e, soprattutto, parroci delle città teatro della repressione più sanguinosa, hanno evangelicamente preso le difese dei più deboli – in quella congiuntura, i giovani aggrediti dal regime –, mostrando una relativa unità di intenti sotto la guida del cardinale Brenes.
Quanto all'eventuale ripresa del Dialogo Nazionale, Ortega ha del tutto screditato i vescovi nel ruolo di mediatori. Di conseguenza, le prospettive in tal senso paiono quanto mai incerte.
Riguardo al Canale, qual è ora il quadro della situazione?
Del progetto si sono perse le tracce. Nei fatti, non un metro è stato scavato. L'operazione, dai più giudicata finanziariamente e ambientalmente insostenibile, ha partorito, tuttavia, un “mostro” giuridico, sancito addirittura nella Costituzione e teoricamente immodificabile per un secolo, a favore del “concessionario” – l'imprenditore cinese Wang Jing, di cui pure non si hanno più notizie – che, nei fatti, sta favorendo un processo di spoliazione di terre contadine a beneficio di vecchi e nuovi latifondisti. Contro questa “controriforma agraria” è sorto negli ultimi anni un forte movimento contadino, che si è saldato con la protesta giovanile nelle città, maturata tra l'altro anche sull'onda della protesta per l'inerzia dimostrata del governo in occasione dell'incendio della riserva naturale Indio-Maíz, nel sud del Paese. Alcuni leader del movimento contadino contro il canale sono oggi in carcere.
Ad oggi, non vi è alcun indizio di un coinvolgimento della Repubblica Popolare Cinese nel progetto. In passato, lo stesso Wang Jing ha negato una partecipazione in tal senso. È emblematico che, quando il leader cinese Xi Jinping visitò l'America Centrale, nel 2013, fece tappa in Costa Rica, ma non in Nicaragua, e nemmeno in quella occasione accennò a quel progetto.
Il Nicaragua mantiene relazioni diplomatiche (ed economiche) con Taiwan e fino a quando Managua non riconoscerà il governo di Pechino come unico ed esclusivo rappresentante del popolo cinese è improbabile un cambio di scenario.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


