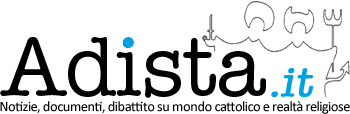Riforma del Diritto canonico. Dei delitti, delle pene e delle vittime
Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 23 del 19/06/2021
Anche la Chiesa, come ogni ordinamento, ha le sue “sanzioni penali”. Ma sarebbe un grave errore comparare il “codice penale” di uno Stato moderno con il libro VI del Codice di diritto canonico. La “logica” delle sanzioni è, nella Chiesa, profondamente diversa. Perché al centro della esperienza ecclesiale non vi è la condanna e la reclusione, ma il perdono e la assoluzione. È evidente, perciò, che il sistema funziona in modo profondamente diverso. Mentre nel sistema penale degli Stati moderni vi è una presunzione di innocenza e la condanna avviene sempre e soltanto con un procedimento “in foro esterno” che irroga una sanzione – anzitutto la classica pena carceraria – come esito di un processo, nella Chiesa la presunzione del peccato, come orizzonte comune di possibile caduta, approda solo eventualmente ad una procedura “giurisdizionale”, perché ordinariamente percorre la via del “foro interno”, alla “correzione fraterna”, mediata dal sacramento del perdono.
Questa differenza percorre la storia della cultura occidentale, con grandi interferenze tra i due piani: il concetto stesso di “pena” nasce, almeno in parte, come elaborazione del “foro interno”, che sapeva, almeno fino al Concilio di Trento, che la “pena temporale” meritava una attenzione particolare da parte della pastorale ordinaria. Così un raffinato sistema di “pene” ha segnato spesso il rifiorire della esistenza. La sua traduzione in “anni di carcere” è assai recente e costituisce, per certi versi, una stilizzazione e semplificazione del concetto di pena, anche se permette una certa parità di trattamento, una certezza prevedibile e una delimitazione dell’arbitrio.
Questo permette di comprendere una seconda grande differenza del “sistema penale canonico”. Esso procede secondo un concetto di pena “più antico”, che consiste non nel “mettere dentro”, ma nel “mettere fuori”: la scomunica è la forma classica di questo sistema. Non è anzitutto privazione della libertà, ma privazione della comunione. Un terzo aspetto generale, che si deve considerare per comprendere che cosa è accaduto con questa riforma del libro VI, è una conseguenza del primo aspetto che ho presentato: la sovrapposizione tra “foro esterno” e “foro interno” – ossia tra una procedura pubblica e un sacramento “segreto” – è che il sistema storicamente non si è posto in modo centrale la “tutela dei terzi”. Il comportamento delittuoso ha avuto una risposta graduata dell’ordinamento verso colui che compie il delitto, ma non ha elaborato un sistema di garanzie per i terzi che siano vittime del comportamento delittuoso. L’esempio classico, e purtroppo di attualità, è il seguente: se io Vescovo (e giudice) ho notizia di comportamenti devianti e gravemente lesivi di terzi, da parte di un presbitero della mia diocesi, per tradizione posso “risolvere” la questione in foro interno, o in una procedura di foro esterno che non considera come rilevanti gli interessi e i diritti della parte lesa. Questo ha di fatto messo in campo competenze di un altro ordinamento – quello degli Stati moderni – la cui impostazione risultava in grado di tutelare le ragioni, i diritti e le legittime aspettative delle vittime. La “divisione dei poteri”, frutto della elaborazione politica del XVIII e XIX secolo, è una delle condizioni per tutelare le vittime. La Chiesa segue, sul piano dell’ordinamento, il principio del “potere indiviso”, non quello della “divisione del potere”. Questo ha ragioni storiche ben chiare, ma ha anche il limite di alcuni punti ciechi, che chiudono pericolosamente il sistema in modo autoreferenziale.
Aver chiarito questi aspetti strutturali della tradizione penale interna alla Chiesa, e che non dipendono da fattori contingenti, ma da secolari articolazioni della autorità umana ed ecclesiale in relazione al dono di grazia, di cui è destinataria e custode, ci permettono di giudicare della riforma del libro VI con maggiore consapevolezza. Lo facciamo rispondendo ad alcune domande elementari.
a) Da dove viene l’istanza della riforma?
Viene da una esigenza di risistemazione del complesso del libro del 1983, a causa di una serie di nuove norme che sono state introdotte nell’ordinamento a partire dal 2001. Ma già 5 anni dopo il nuovo codice, ossia nel 1988, era chiaro che il “sistema penale”, decentrato sui vescovi, faticava ad amministrare efficacemente la giustizia. Il motivo preponderante di questo nuovo testo è la integrazione delle nuove norme nel corpo del codice.
b) Che cosa cambia davvero nel testo?
L’enfasi della presentazione è stata messa, anche giustamente, su una maggiore efficacia nel colpire gli abusi che hanno chierici o laici come soggetti, di cui il nuovo testo porta il procedimento “in foro esterno”, come maggiori garanzie. Ma ciò che cambia davvero non è molto: alcuni titoli significativi e alcune integrazioni testuali. Una categoria nuova e molto eterogenea è quella dei “delitti contro i sacramenti”.
c) Ci sono “nuove fattispecie di reato”?
Le nuove fattispecie sono nate in realtà tra 2001 e 2010 e non riguardano, direttamente, la questione più bruciante. Anzi, per certi versi, rischiano di distrarre da essa: il reato di “tentata ordinazione di una donna” – che reduplica penalmente la esclusione canonica della donna come soggetto ordinabile – può incentivare una chiusura istituzionale che favorisce l’abuso di potere: una Chiesa che voglia escludere addirittura sul piano penale il legittimo dibattito sulla ordinazione diaconale delle donne e sulla loro integrazione a livello di ministeri istituiti rischia solo di complicare i problemi.
d) La riforma è sufficiente a offrire tutela ai terzi/vittime?
Questo è il punto più delicato. Resta la impressione che i terzi/vittime, se vogliono garantirsi, debbano ricorrere ad “altri ordinamenti”, che sono dotati di strumenti procedurali e di un potere di sanzione molto più articolato ed efficiente. E che la necessaria correlazione tra ordinamenti diversi faccia appannare la pretesa di assoluta autonomia della autorità della Chiesa nell’irrogare pene (“diritto nativo e proprio”), che apre il libro sulle sanzioni nel 1917, nel 1983 e ancora nel 2021.
In sintesi
Nella storia iniziata 20 anni fa, e di cui papa Francesco non ha alcuna diretta responsabilità, si sono esasperate alcune “fattispecie delittuose”, portandole a livello di “scandalo di sistema”. Ciò costituisce una obiettiva forzatura della tradizione, di cui un canonista avrebbe il dovere professionale di accorgersi. Il fenomeno nasce insieme ad altre forzature: nel 2001 si approva Liturgiam authenticam e si esaspera la autorità del latino, si imposta Redemptionis sacramentum e si censura la assemblea celebrante, mentre si offre un elenco dei graviora delicta in cui alle figure classiche si avvicinano figure nuove, direttamente correlate al cammino di riforma della Chiesa: la ministerialità femminile o l’ospitalità eucaristica ecumenica non si dovrebbero mai confondere con la aggressione fisica al papa o con la profanazione delle specie eucaristiche. Questa confusione è grave, teologicamente e canonicamente. Così un “dispositivo di blocco” trova anche sul piano penale la sua affermazione poco lungimirante. Astratta-mente si sarebbe potuto fare, almeno fino allo scorso gennaio, un crimine della “tentata istituzione di una donna come accolito o come lettore”. Fino ad Amoris laetitia si sarebbe potuto fare un crimine specifico della “tentata comunione sacramentale di divorziato risposato”. Dove nella Chiesa vi è dibattito – sulla ministerialità femminile, cui non è precluso il ministero ordinato nel grado di diaconato, o sulla cosiddetta intercomunione ecumenica – creare fattispecie di reato come “deterrente ad ogni evoluzione” è una forma di “blocco della tradizione” che si pretende di imporre con sanzione penale. Assomiglia molto al divieto di parlare della donna in relazione al ministero ordinato, che una lettura microcardica vorrebbe imporre ad ogni teologo anche oggi. Lo scandalo per la comunione che si vorrebbe “negata” cerca di tacitare la sorpresa per una comunione differenziata.
Ma qui dobbiamo riconoscere che vi è ormai una sapienza comune superiore, che dice: “Ogni pena che non derivi da assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica” (Beccaria, Dei delitti e delle pene, c. 2). Un uso tirannico del diritto penale è l’ultima delle cose di cui ha bisogno una Chiesa che voglia “uscire” verso un nuovo paradigma.
Andrea Grillo è docente di Teologia dei Sacramenti e Filosofia della Religione al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma e insegna Liturgia presso l’Abbazia di Santa Giustina, a Padova; è saggista e blogger (www.cittadellaeditrice.com/munera/come-se-non)
Immagine originale e licenza tratta da flickr, Yale Law Library
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!