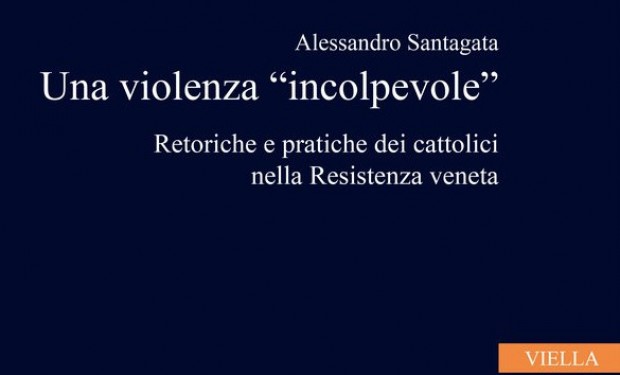
Una violenza “incolpevole”
Tratto da: Adista Documenti n° 5 del 12/02/2022
Per l’introduzione a questo articolo, clicca qui
Le storie di Resistenza raccontate in questo libro sono molto lontane dall’immagine del partigiano a cui siamo abituati: una narrazione che si è rafforzata dopo il passaggio degli anni Sessanta, fatta di sangue versato, ma anche di sangue fatto versare, di «dura vendetta» contro il fascista «vile e traditore». Verrebbe da dire, forzando volutamente la mano, che sono storie quasi al contrario, nelle quali è l’amore per la patria, ma soprattutto per il Cristo, a far premere un dito recalcitrante sul grilletto dello Sten. Racconti di patrioti animati dalla carità che si percepivano, o comunque che sono stati raccontati, come privi di odio nei confronti del nemico e, per questo motivo, più capaci di combattere la «giusta guerra». Queste pagine nascono dunque dall’osservazione di una discrepanza che assume il senso di una distanza carica di significati.
La storiografia sulla Resistenza non ha certo ignorato la questione. […] Eppure l’aspetto più macroscopico di quell’esperienza – la partecipazione dei credenti alla lotta armata e alla guerra civile – sembra essere ancora oggi il più trascurato, quasi abbandonato ad un’apologetica di cui la Chiesa è ancora la principale custode e promotrice attraverso la sua politica di canonizzazioni (si pensi, per esempio, alla recente beatificazione di Teresio Olivelli voluta da papa Francesco. La celebrazione è avvenuta il 3 febbraio 2018. Il partigiano delle Fiamme verdi è stato proclamato «martire in odium fidei». La scelta di questo tipo di motivazione sembra indicativa della volontà di insistere su un «paradigma vittimario» che inevitabilmente fa rientrare la Resistenza nel più rassicurante spazio occupato dalla storia dei martiri cristiani).
Quella che un tempo veniva definita la storiografia del «movimento cattolico» si è mostrata reticente nell’affrontare il tema della violenza agita dai credenti, forse anche per le difficoltà che il mondo religioso ha avuto nell’accettare che in Italia fu combattuta una guerra civile e che anche i militanti cattolici vi presero parte. Il focus è stato posto sulla propensione dei cristiani al dare la vita per la causa lasciando decisamente in secondo piano il come e perché dare la morte. Dopo la svolta del Concilio Vaticano II, in particolare, l’interesse si è focalizzato sulle ragioni dell’antifascismo patriottico e religioso, sulle forme di Resistenza non violenta e sulla questione dell’autonomia dei laici dalla gerarchia nel momento in cui optarono per la lotta. […] Da parte loro, gli studiosi legati agli Istituti storici della Resistenza hanno mostrato scarsa attenzione nei confronti di un insieme di rappresentazioni, spesso considerate troppo sbrigativamente come figlie della guerra fredda, senza domandarsi da dove venissero e perché fossero state elaborate. Se è vero che dalla seconda metà degli anni Novanta sono caduti gli steccati che avevano portato a isolare la storiografia sui cattolici, nella produzione successiva non si è verificato lo scarto che pure era stato auspicato. Il risultato è stata l’esclusione della questione religiosa dal dibattito sulla «moralità» della Resistenza, e il replicarsi, più o meno consapevolmente, delle retoriche che avrebbero dovuto essere invece decostruite.
La presente ricerca prende le mosse da Claudio Pavone e dalla sua definizione di «moralità» – intesa non come sinonimo di «morale» (parola che isola il dato di coscienza individuale) e neppure più genericamente di «mentalità», ma come lo spazio individuale e collettivo in cui politica e etica si sono incontrate e scontrate. Lo studio si propone di affrontare la storia di un dispositivo retorico che abbiamo chiamato la violenza “incolpevole”. La locuzione è ancora di Pavone, che parla della militarizzazione come garanzia per le brigate autonome, e per i cattolici in primis, di un «uso non colpevole della armi» in assenza di una copertura istituzionale. Al centro dell’indagine ci sono dunque i meccanismi di legittimazione della violenza da parte delle formazioni partigiane legate all’area cattolica veneta. […]
Intendiamo mettere in luce […] che la tesi che le formazioni autonome, legate a vari livelli dai loro vertici all’area cattolica, fossero le uniche a desiderare una rispettabilità che sarebbe derivata loro da un sapiente calcolo del rapporto tra costi e benefici, è del tutto campata in aria. Così come, al contrario, non può essere accolta la teoria, altrettanto denigratoria, che i cattolici non intendessero davvero combattere, e che si limitarono ad azioni di sabotaggio in attesa degli Alleati. […]
Le fonti del 1943-1945 e la successiva memorialistica hanno tramandato una narrazione del partigiano cattolico dai contorni via via più precisi. Nei suoi caratteri principali, è descritto come colui che accetta di salire in montagna per un’istanza di tipo morale, cioè per reazione a una violenza inconciliabile con la sua concezione cristiana; decide di combattere per difendere la patria; infine, e soprattutto, si rifiuta di scendere al livello della guerra civile. Non solamente combatte per amore, ma anche con amore, cioè con spirito di carità: sempre pronto al sacrificio, nella versione più nobile, non ha sparato mai un colpo.
La ricerca che sta alla base del volume si è sviluppata dalla necessità di decostruire questa rappresentazione sottraendola così tanto al piano dell’apologetica quanto a quello della polemica politica, dove aveva prosperato nel dopoguerra. L’ipotesi di partenza è che già durante la guerra avesse iniziato a prendere forma un immaginario che va considerato come il prodotto di una stratificazione culturale di lungo periodo. Più precisamente, l’immagine del partigiano cattolico deve essere analizzata come un dispositivo culturale in fieri. Attingendo a un consolidato deposito di retoriche militari sulla civilizzazione e sul contenimento della violenza – e più specificamente a quella pedagogia, investigata recentemente da Francesco Piva, che aveva teorizzato il modello del soldato cattolico, moralmente e militarmente superiore perché capace di «uccidere senza odio» [v. Adista notizie n. 4/16] – le agenzie culturali coinvolte a vario titolo nella Resistenza (il clero, l’Azione cattolica e la Democrazia cristiana, in primis) hanno cercato di presentare la lotta armata come legittima sia politicamente sia religiosamente.
Non si trattò ovviamente né di un processo lineare e pianificato né di una semplice riproposizione della dottrina tradizionale sulla guerra – era il contesto a renderlo impossibile – ma di un riadattamento di categorie che provenivano dal «nazionalismo cattolico», con le quali erano stati confessionalizzati il primo conflitto mondiale e le imprese del regime fascista. Categorie impiegate ora per sostenere l’esigenza di opporsi con le armi al nazifascismo, senza cadere nell’errore della guerra fratricida. O meglio […] per combattere un conflitto fratricida, ma in modo considerato “incolpevole” e dunque anche moralmente giustificato, anche se non da un’autorità statuale e neppure da quella ecclesiastica. […]
La storia delle bande partigiane, poi organizzate in brigate, fu quella di gruppi spontanei, di movimenti spesso casuali, di cambi di casacca e così via. […] Ci occuperemo principalmente di quei militanti nelle organizzazioni ecclesiastiche e nei circuiti clandestini che scelsero di fare dell’appartenenza religiosa anche un fattore di identità politica. Il «momento della scelta» fu diverso per ciascuno: dettato da motivazioni che in buona parte sfuggono alle categorie dello storico. Il tentativo di dare una lettura culturale della Resistenza si scontra quindi di continuo con il problema delle generazioni – da quella degli ex-popolari a quella dei ventenni cresciuti nell’Azione cattolica e del tutto digiuni di politica attiva –, nonché con la storia degli uomini nella sua specificità individuale e casualità. […]
Tra le questioni più discusse troviamo, ancora una volta, quella dottrinale. Nonostante la presenza di alcuni appigli, tra i quali la liceità della guerra difensiva, ma anche, almeno a livello teorico, della resistenza a una tirannia prolungata, la tradizione non risolveva il problema di come combattere la guerriglia senza entrare in contrasto con gli stringenti criteri formali previsti dal magistero. La risposta fu cercata da un lato nell’esercizio di una guerra di liberazione che si diceva rispettosa del criterio di proporzionalità tra costi e benefici. Dall’altro nella rappresentazione del bravo partigiano (cattolico). Il tedesco veniva invece descritto in tutta la sua disumanità, opponendo alla sua «violenza» una «forza» sana e virtuosa, cioè incompatibile con la retorica del fascismo repubblicano e della sua componente clerico-fascista.
Un secondo livello di distinzione passava dal confronto con gli altri partigiani, accusati (più o meno esplicitamente) – mutuando qui le categoria di Tzvetan Todorov – di anteporre l’etica della convinzione (politica) a quella della responsabilità nei confronti delle popolazioni inermi. Nella sostanza l’accusa era falsa e denigratoria. Innanzitutto, nella maggioranza dei casi, la guerra partigiana fu presentata come una dura necessità. Inoltre, come insegna la letteratura resistenziale, il problema del dare la morte fu vissuto nella coscienza dei singoli secondo logiche che sfuggono alla storiografia. Secondariamente, tutte le anime della Resistenza, si confrontarono con le ambiguità della categoria dell’odio e con il problema della giustificazione della violenza. Le riviste degli autonomi di montagna presentano contenuti talvolta in contraddizione con il paradigma della violenza controllata. Tuttavia, come emerge dal confronto con la stampa garibaldina, furono effettivamente divulgate due visioni quasi antitetiche dell’“odio”, che riflettevano concezioni altrettanto opposte della violenza. Mentre i comunisti consideravano la violenza come la «levatrice» della storia, i cattolici si sforzarono in ogni modo per sostenere la loro estraneità, morale alla guerra civile, ma attenzione, non alla guerra e alla violenza in quanto tale. A differenza del “crucco”, infatti, il combattente in camicia nera poteva essere disprezzato per la sua immoralità, per il suo tradimento, ma era più difficile sostenere che non fosse un fratello. Una tesi avanzata in questo libro è che i teorici del cattolicesimo politico fossero perfettamente consapevoli di essere coinvolti attivamente in un conflitto che era, nello stesso tempo, contro lo straniero e civile: affermare di combattere una guerra di liberazione, dichiarando di agire senza odio, di utilizzare le armi principalmente come uno strumento di deterrenza e cercando di limitare al minimo la violenza era il modo migliore per affrontare la guerra fratricida, senza nasconderla, ma presentandola come una variabile incidentale e comunque vissuta in modo apatico. Non si trattava dunque di negare la possibilità di sparare: i partigiani cattolici affermavano piuttosto di essere i migliori interpreti di una grammatica condivisa, che aveva tra le parole chiave il concetto di “rispettabilità”. Andando alla radice, sembra legittimo sostenere che tale impalcatura ideologica, fondata sul rifiuto dell’odio, fosse funzionale a commettere il fratricidio senza assumerne pienamente la responsabilità morale e politica.
Sarà chiaro a questo punto perché le retoriche oggetto di esame sono state considerate come performative. Un riscontro arriva dallo studio delle biografie dei militanti nella Gioventù cattolica e nella Federazione universitaria. I pochi diari e gli epistolari dei protagonisti, spesso raccolti da amici e parenti, restituiscono esitazioni, paure, oscillazioni che, vale la pena ribadirlo, non sono certo esclusive dei cattolici. Due elementi ricorrenti, e realmente distintivi, sono invece il desiderio di conservare una certa coerenza con l’educazione ricevuta tra la famiglia e la parrocchia e la sofferenza per i momenti di esitazione e per la caduta nel peccato. La scelta per la Resistenza viene solitamente spiegata sulla base di motivazioni morali, religiose e non politiche, ma che possiamo più correttamente interpretare come scelte politiche di matrice religiosa. A farla da padrona è la battaglia interiore per il disciplinamento delle passioni, a partire da quelle sessuali, per arrivare a controllare l’esercizio della violenza. Quest’ultima è quasi un tabù: il dare la vita ha dunque sempre la preferenza sul dare la morte in un percorso verso la purezza interiore e l’apostolato. […]
Del “partigiano cattolico” si occupa l’ultimo capitolo che prende in esame un’ampia sezione della stampa cattolica (ecclesiastica e democristiana) per poi concentrarsi su come le biografie commemorative completarono la costruzione di un “canone”. Siamo nella società veneta dell’immediato dopoguerra in cui a fatica si sarebbe sentito spirare il «vento del Nord». All’interno del paradigma di unità antifascista figure e agenzie culturali diverse si assunsero il compito di celebrare il lutto delle famiglie e delle comunità colpite dalla guerra civile, mentre la Chiesa, che a quel paradigma non si sentiva vincolata, e la Dc combattevano il “primo round” della «guerra della memoria» con le sinistre. Era importante rendere “accessibile” e digeribile alla propria parte la memoria della Resistenza, farne un «quadro collettivo», anche per intestarsi il merito della liberazione, condannando chi aveva cercato di deviare il corso della lotta in altre direzioni. Uno degli artifici retorici più efficaci fu legare la figura del partigiano cattolico a quella del «bravo italiano», in contrapposizione al «cattivo tedesco». L’altro rispondeva alle categorie del cattolicesimo politico e portava a termine, distorcendola ulteriormente, la rappresentazione elaborata durante la guerra. Mentre esplodeva la polemica anticomunista, stampa e libretti di martirologio celebrarono il loro prototipo di «santo partigiano martire», diversamente eroico dal martire garibaldino, e a lui moralmente superiore perché coerente con la propria cultura di provenienza. Nella narrazione agiografica, tale visione si tradusse nell’attitudine a ricorrere il meno possibile al proprio Sten e, nei casi più “nobili”, addirittura nel non avervi mai fatto ricorso: non certo perché i patrioti non fossero disposti a sparare o non l’avessero mai fatto, ma in virtù della loro astuzia, della capacità di utilizzare le armi solo come deterrente. Da qui si sarebbe dovuta evincere la loro superiorità morale oltre che militare. […]
Un’altra strada sarebbe passata nei decenni a venire per l’avvio dei processi di canonizzazione, questa volta nel segno del pressoché completo “disarmo” dei patrioti caduti in odium fidei, mentre il cattolicesimo politico aveva già disinvestito sulla memoria della Resistenza. Il dibattito sulla liceità della violenza conoscerà invece una nuova stagione di riflessioni con il Concilio Vaticano II, che avrebbe fornito argomenti tanto ai sostenitori della non-violenza, e questa volta ai critici della dottrina sulla guerra giusta, quanto a coloro che sarebbero andati alla ricerca di una legittimazione religiosa della lotta armata rivoluzionaria.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


