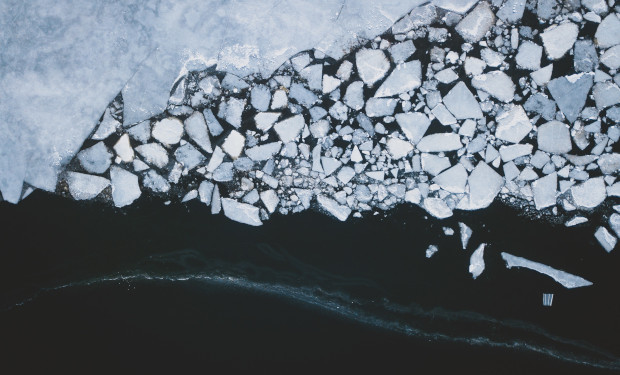
Ambiente. Negazionismo climatico: a chi conviene
Tratto da: Adista Segni Nuovi n° 34 del 14/10/2023
Stefano Caserini è docente di "Mitigazione dei Cambiamenti Climatici” al Politecnico di Milano, professore associato all’Univeristà di Parma, nonché fondatore e coordinatore del blog scientifico Climalteranti.it, che si occupa di cambiamenti climatici. Su questi temi ha scritto diversi libri, tra i quali A qualcuno piace caldo. Errori e leggende sul clima che cambia, edito da Edizioni Ambiente nel 2008 (disponibile gratis sul sito caserinik.it), dove esamina le tesi negazioniste di chi contesta la Scienza del Clima, e ne mostra la totale infondatezza. Proprio di negazionismo e delle conseguenti visioni politiche abbiamo voluto parlare con il professor Caserini nell’intervista che segue.
Secondo lei a chi giova il negazionismo?
Giova a chi vuole impedire le politiche climatiche. Poi molte delle voci negazioniste esprimono una sorta di narcisismo di chi ama dire cose diverse dagli altri per mettersi in mostra. Certo le grandi campagne di disinformazione, soprattutto negli Stati Uniti, sono state finanziate dalle lobby del gas, del carbone, dei fossili che vogliono ritardare le politiche sul clima perché la riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili comporterebbe una riduzione dei loro enormi fatturati.
Le argomentazioni negazioniste, parte del più ampio discorso sull’analfabetismo scientifico, in quale veste si presentano per essere convincenti?
Le argomentazioni possono essere le più varie. In A qualcuno piace caldo avevo mostrato l’evoluzione della struttura di queste tesi. Inizialmente si contestava che qualcosa stesse cambiando, poi davanti all’inequivocabile evidenza del cambiamento del clima si è iniziato a dire che si tratta di cicli perché il clima è sempre cambiato. Falso. Successivamente si è detto che l'essere umano non è responsabile delle forti anomalie climatiche. Tuttavia, una volta dimostrato in modo inequivocabile quanto il cambiamento climatico sia causato dall’ingerenza umana, qualcuno ha detto che magari fa bene. Dopodiché si è affermato che comunque costa troppo e che non ce lo possiamo permettere, perché abbiamo altre priorità (benaltrismo). Adesso si dice che le politiche climatiche creano disuguaglianza, quando in realtà è proprio il cambiamento climatico un grandissimo motore di disuguaglianza. L’approdo finale del negazionismo è che è troppo tardi per agire. Falso anche questo. Sono tesi sviluppatesi nel tempo, ma sono del tutto inconsistenti e senza fondamento scientifico.
Taluni falsificano i dati, negando l’evidenza...
Gli esseri umani sono capaci di crearsi delle realtà di comodo, per non voler vedere realtà scomode. I meccanismi della negazione sono spiegati dalla psicologia, dalla sociologia. Sono fenomeni già avvenuti e studiati in passato, non deve quindi sorprendere. Primo Levi ne I sommersi e i salvati ha mostrato come tante persone, pur avendo saputo della Shoah, non avevano voluto credere a una realtà così spaventosa e ne negavano dunque l’esistenza. Sono meccanismi a volte inconsci in cui non è facile dire dove cominci o finisca la cattiva fede. Spesso si è portati a negare a causa della propria struttura psichica.
Le politiche dell’attuale governo, che sembrano frenare la transizione verde, non rischiano di bloccare l’innovazione e lo sviluppo industriale italiano, rendendoci in futuro davvero schiavi di Paesi come la Cina?
Credo sia possibile ritenere questo governo, in cui non mancano le voci negazioniste, più dedito alla propaganda dell’inattivismo. Ossia appartiene alla schiera di coloro che cercano di dire che si può aspettare perché non c'è urgenza. Tutto ciò contraddice la politica europea sul clima che desidera fare della transizione energetica una leva di sviluppo per creare nuovi posti di lavoro, in modo da divenire indipendenti dal punto di vista energetico da ogni regione da cui compriamo combustibili fossili ogni anno per decine di miliardi di euro. Luoghi che sono spesso sede di regimi autoritari che negano i diritti umani. Produrre l’energia in casa, invece, ha anche un senso di sviluppo industriale. Queste cosa però non viene colta e può portare a un ritardo nella transizione, facendoci perdere in competitività nella grande sfida tecnologica del futuro. Ne consegue che se non si investe in ricerca e sviluppo promuovendo la tecnologia green e il suo sviluppo su larga scala, non sarà nemmeno possibile il progresso tecnologico e la diffusione rapida che ci serve. Dietro l’European Green Deal ci sono delle valutazioni economiche che non vengono considerate da chi ha una visione molto ristretta.
Non c’è una eccessiva fede nella “tecno-scienza” (che non significa demonizzare la tecnologia) con poteri “magici”?
Questo è un problema globale che non può essere risolto con soluzioni a livello individuale, perché bisogna cambiare il sistema energetico. Attualmente ci sono miliardi di persone che non possono accedere al progresso tecnologico nel settore delle energie rinnovabili, infatti anche la tecnologia è un modo per uscire dal sottosviluppo. Sicuramente vi è un maggior bisogno di energia e questo richiede tecnologia che permetta di sostituire il carbone, il petrolio e i gas con altre fonti energetiche. Si tratta anche di un discorso etico, il cambiamento climatico non è solo una questione tecnologica, di tecnoscienza, quanto un problema che società evolute e complesse come la nostra hanno bisogno di un ampio consumo di energia e quindi devono mettere in atto una transizione “di sistema”. I Paesi ricchi e benestanti sono a un tal punto di consumo di energia che possono anche ridurre i loro consumi. Ma sulla Terra sono miliardi quelli che non possiedono elettrodomestici oggi per noi scontati. Purtroppo il discorso tecnologico rischia di essere un discorso troppo elitario, se non è accompagnato da un impegno sulla “transizione giusta”.
Il problema infatti è dell’utilizzo che se ne fa, come di tutte le cose...
Certo, tenendo però presente come l’energia fossile sia molto meno democratica di quella rinnovabile. Tale energia è in mano a pochi gruppi di potere e quindi si presta facilmente a essere fonte di disuguaglianze. Ricordiamo che oggi i pannelli fotovoltaici stanno portando l’energia lì dove il fossile non arrivava, rappresentando un fattore di democratizzazione o di riduzione delle disuguaglianze, se usato in modo equo.
Ma questo fattore di democratizzazione non disturba chi detiene il potere sull’energia?
Chiaramente questi gruppi di potere stanno cercando di contrastare la transizione. Però non si può generalizzare, perché al loro interno ci sono persone e aziende che hanno capito e stanno investendo nel fotovoltaico, nell’eolico e nell’efficienza energetica. Naturalmente, dovremo porci il problema che, essendo il nostro pianeta limitato, non è possibile avere livelli di consumo di energia in continua crescita, illimitata. Tale consumo, anche se prodotto da fonti rinnovabili, crea molteplici problemi. Perciò la produzione di energie rinnovabili deve accompagnarsi con l’efficientamento dei consumi.
Un ulteriore problema etico...
Sì: ormai dal punto di vista scientifico ciò che doveva essere spiegato è stato più o meno spiegato. Esistono ancora dettagli da capire, ma la sostanza è chiara e solida. La questione energetica è una questione politica, sociale, etica che deve valutare quali siano i diritti in un clima pesantemente alterato dalle attività umane. Decidere se farlo, o goderci tutto noi scaricando sul futuro i danni, è una scelta etica.
È stato durante la pandemia e la campagna vaccinale che questa cultura antiscientifica sembra essersi rafforzata e legittimata?
Io non credo in uno spartiacque del Covid. Il mio libro è del 2008 e l’antiscienza era già attiva allora, non soltanto in Italia. I movimenti di disinformazione, anche in ambito climatico, non sono aumentati particolarmente dopo il Covid; anzi devo dire che dal 2008 ad oggi c’è stata una riduzione del negazionismo. Oggi ci sono ancora alcune frange, alcuni giornali che negano la crisi climatica ma meno di 15 anni fa. Se leggeva il Sole 24 ore o il Corriere della Sera allora si trovavano articoli che negavano il cambiamento climatico, ma ora non succede più.
Come viene accolta la Scienza del Clima in un contesto culturale italiano ancora profondamente pervaso dal pensiero cattolico?
In passato ci sono state visioni negazioniste sul clima all’interno della Chiesa, nel mio libro nel 2008 ho dedicato un capitolo alle voci teocon. Nella Chiesa non c’è l’abitudine ad accettare i risultati della scienza in modo laico, specie nella sua ala reazionaria, tradizionalista e conservatrice. È una questione storica di origine molto antica. Però le evidenze scientifiche oggi sono talmente rilevanti, che non c’è a mio parere un discrimine religioso nell’accettare la Scienza del Clima. Ci sono, specie negli USA, dei movimenti integralisti e fondamentalisti religiosi che rifiutano tale Scienza, come rifiutano l’Evoluzionismo. Ma si tratta di un contesto ideologico lontano da quello italiano. È possibile definirlo un non interesse verso la gravità della situazione, con affermazioni che parlano della "provvidenza" come risolutrice del cambiamento del clima. Un famoso senatore degli USA, durante un’audizione al Senato, ha affermato che «non bisogna preoccuparsi del riscaldamento globale perché Dio ha detto che non ci saranno altre catastrofi dopo il diluvio universale descritto dalla bibbia». Non è una battuta, ma testimonia il fatto che molti non credono alla possibilità di danni molto consistenti come l’innalzamento dei mari di 5 o 10 metri, perché ritengono sia uno scenario non permesso da Dio. Ciò significa non fidarsi della Scienza e pensare che esista un essere superiore "tappabuchi". Questo è molto pericoloso in quanto rappresenta una visione integralista fondata su un’ideologia reazionaria, spesso religiosa, che vuole negare l’azione dello Stato e la sua forte azione regolatrice, privilegiando una visione dello Stato molto leggera, che corrisponde all’ottica liberista della società, più vicina al modello statunitense che a quello italiano. In Florida ci sono dei casi in cui è stato vietato l’insegnamento della Scienza del Clima, ma anche dell’Evoluzionismo. Tuttavia, è anche vero che gli USA posseggono i più grandi laboratori che si occupano di cambiamento climatico, e di conseguenza stanno tentando di rieducare quel 20% della popolazione che ancora non accetta la crisi climatica.
Tornando all’Italia: perché nella politica italiana destra e Clima non sembrano fare rima?
Questa domanda esula dalle mie competenze scientifiche e si pone su un differente piano di discorso: quello politico. I due piani vanno distinti. Quindi le rispondo non in quanto studioso ma da un punto di vista politico, sulla base della mia visione e del mio impegno politico che mi ha portato a essere Assessore all’ambiente, mobilità e azione sul clima del Comune di Lodi (dove risiedo). Innanzitutto, bisogna distinguere tra la destra in generale e la destra italiana. Ritengo che, in particolare dalla discesa in campo di Berlusconi, la destra si sia ridotta a difendere posizioni di basso profilo, “di bottega”. Il berlusconismo ha avuto l’obiettivo di proteggere interessi economici particolari, privi di una visione di società o di interesse al bene comune. Il disinteresse della destra italiana verso la questione ambientale si lega alla volontà di perseguire l’accumulazione della ricchezza senza nessun vincolo, non solo ambientale. Una prospettiva reazionaria che guarda solo all’interesse immediato, da perseguire con una sistematica propaganda quotidiana televisiva in primo luogo, senza sguardo verso il medio e lungo periodo. Alla destra si salda una componente neoliberista, che strutturalmente non può fare i conti con i limiti del Pianeta. Il neoliberismo ha bisogno di una visione di comodo della realtà che non considera i reali problemi sociali e ambientali negandoli e impedendo in tal modo interventi statali. Una sorta di religione secondo cui il mercato per magia risolverebbe ogni problema. Ma il cambiamento climatico è un esempio del fallimento dell’ideologia del libero mercato senza freni, incapace di considerare i danni causati dai cambiamenti climatici. Inoltre, alla giustizia climatica è collegata alla giustizia sociale. La prima è un’evoluzione della seconda.
Ricordo un video di Nicola Porro (uno dei principali esemplari della destra reazionaria attuale), che mostro anche durante la conferenza-spettacolo tratta dal mio libro A qualcuno piace caldo, in cui afferma deciso: «Ma cos’è la giustizia climatica, non riesco a capire cosa sia la giustizia sociale, figuriamoci quella climatica». Molti sono al suo livello. La giustizia sociale è un tema difficile su cui si discute da più di un secolo, la giustizia climatica è un concetto più recente che molti a destra neppure capiscono. Giornali quali Libero, La Verità o Il Giornale, espressione della destra nostrana, manifestano una povertà culturale paurosa sulle tematiche ambientali. Anche la visione dell’enciclica Laudato si’ è limitata perché propone come unica soluzione la conversione dei cuori, degli animi; questo per le destre è un alibi, perché lascia tutto in mano ai comportamenti individuali. Invece c’è bisogno di un’azione politica molto forte a livello internazionale, nazionale o regionale che affronti la crisi climatica. Se alle prossime elezioni europee del 2024 vincessero le ultradestre reazionarie e populiste la questione climatica sarebbe dimenticata a livello europeo o almeno fortemente ridimensionata. Già adesso le destre stanno sabotando l’azione sul clima. Tutto ciò vorrebbe dire rinunciare a perseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, gli impegni presi con gli altri Paesi del mondo per il contenimento del riscaldamento globale (Agenda 2030, ndr).
Infatti al Parlamento Europeo sistematicamente i deputati di destra italiani votano contro ogni risoluzione che combatta il cambiamento climatico spostando la questione sul nucleare...
È un non voler affrontare la realtà e assumersi le proprie “responsabilità” sulla crisi climatica. Un esempio di enfasi sull’energia nucleare è rappresentato dalla proposta di Salvini di costruire una centrale nucleare a Baggio, all’interno di Milano. Ma voler costruire centrali nucleari in Italia significa essere fuori dal mondo. Oltre al fatto che il nucleare non conviene economicamente, puntare su questi “slogan” risponde alla precisa volontà di non affrontare il problema. Gli slogan fungono da “spot” elettorali che attraggono consenso: «Io parlo alla pancia degli elettori indipendentemente che sia sensato o meno». Purtroppo si riteneva che con l’uscita di scena di Berlusconi fosse finito il berlusconismo, invece i populismi che lui ha introdotto in modo massiccio hanno lasciato un’eredità estremamente dannosa nella politica italiana di cui ancora paghiamo pesantemente le conseguenze.
A che punto siamo riguardo le auto elettriche?
È una delle questioni da affrontare per superare la crisi. Sappiamo già adesso come le auto fossili siano molto inefficienti, mentre tutti gli studi fatti mostrano come l’auto elettrica sia più vantaggiosa. Tanto più noi produciamo energia da fonti rinnovabili, tanto più l’auto elettrica diventa conveniente. Certo, è necessario che tutta la filiera sia pulita, ma ricordiamoci che anche il petrolio non ha una filiera pulita. Nessuna tecnologia oggi viene introdotta in modo del tutto sostenibile. Bisogna lavorare perché migliori la filiera, ma con il motore elettrico riusciamo a contenere l’emissione di gas serra rispetto al motore a scoppio. Quindi la norma europea che prevede la sostituzione entro il 2035 del motore fossile con quello elettrico nei veicoli di nuova produzione è necessaria per proseguire verso la transizione energetica.
Riguardo all’Agenda 2030, a che punto siamo?
Io posso esprimersi solo sul clima: stiamo facendo qualcosa, ma non abbastanza.
Con questo livello di sforzo non raggiungeremo gli impegni che abbiamo già sottoscritto. Lascia perplessi la decisione di far organizzare a Dubai la Cop28...
L’Onu ha queste regole. La conferenza nel 2023 toccava all’Asia, è stato scelto questo luogo. L'Onu è la sede di un negoziato basato sul consenso di tutti i partecipanti. Però dopo questa Cop ve ne sarà un’altra. Dobbiamo vedere il processo negoziale come un cammino in fieri. Dispiace soprattutto che la Cop28 si svolga in un Paese che anche come immaginario è legato in modo profondo ai combustibili fossili. Ma questo lo renderà osservato speciale, ricordando come sia importante che anche i Paesi simili agli Emirati Arabi facciano dei passi sostanziali verso il cambiamento.
Giusi D’urso laureata in Filosofia, collabora con diverse testate. Si occupa di temi ambientali, di Studi di Genere e di Storia della Scienza.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


