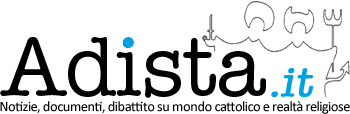.jpg)
La parola “dio” tra l’ambiguità e il silenzio
Tratto da: Adista Documenti n° 40 del 23/11/2024
Qui l'introduzione a questo testo.
Una parola diversa e ambigua
La parola Dio è la più sovraccarica di tutto il linguaggio umano (M. Buber). Tale parola ha giustificato i crimini più efferati e al tempo stesso ha espresso i sentimenti più elevati e ispirato i più grandi gesti di bontà felice.
Paul Tillich (1886-1965), teologo luterano, uno dei più influenti del XX secolo, propose di far passare 100 anni senza più parlare di Dio, ma dedicò la sua vita a pensare, pronunciare e scrivere parole alternative. Anche Raimon Panikkar si chiese se non servisse una cura del silenzio di vari secoli su Dio, ma, pur negando la necessità di utilizzare tale termine, continuò a parlare di Dio sgombrando il campo dagli equivoci e invitando al silenzio.
Gli atei di dio hanno ragione. Hanno ragione riguardo a ciò che negano quanti, sentendo parlare di Dio, intendono solo dio: Sovrano supremo, Creatore onnipotente, provvidente, castigatore o misericordioso… Ma non potrebbero aver ragione anche quanti, malgrado tutti i fraintendimenti e le deformazioni, non temono di dire Dio per riferirsi al Mistero fontale di tutto, alla Realtà fontale infinita oltre dio? A condizione, tra altre cose, che siano coscienti del carattere radicalmente umano del concetto e dell’immagine che veicola.
Theos in greco, Dios in spagnolo, God in inglese, Gott in tedesco, Bog nelle lingue slave, Jainkoa nella lingua basca, Ngenechén in mapuche, Chaac in maya, Kami in giapponese, Unkulunkulu in zulu, Ngai in masai, Nzapa in sango, Onyame in akan, per citare solo alcuni dei nomi di divinità di religioni vive: l’Innominabile è designato con molteplici nomi, e in nessuno si esaurisce e viene imprigionato. E sempre, in tutte le sue molteplici forme, il termine Dio è fatalmente una parola umana, culturale, cangiante. E, in quanto tale, è stata sempre – e continuerà inevitabilmente a esserlo – ambigua, la più ambigua di tutte le parole.
L’etimologia e il significato concreto del termine variano secondo la lingua, la cultura, il modello economico, la situazione politica o l’ambiente ecologico in cui viene usato. Può designare il sole, la luna o il firmamento intero; può indicare un albero (come Yggdrasil, l’albero perenne della vita nella mitologia nordica), un animale (serpente, uccello, leopardo, cane…), la forza cosmica o vitale che abita tutto, un ente supremo, l’Essenza universale, la Causa prima, il Creatore del cosmo… Può anche chiamarsi Dao (Essenza, fondamento, origine di ciò che è), Brahman (Realtà assoluta), Shunyata (Vuoto di tutte le forme).
È impossibile evitare qualunque rappresentazione: che sia più o meno diffusa o più o meno precisa, sempre di una rappresentazione al modo e alla misura umani si tratta. Ricordiamo l’ironica e opportuna osservazione del poeta e filosofo greco Senofane di Colofone (VI-V secolo a.C.): «Neri e col naso camuso: così vedono gli etiopi i loro dei. Con gli occhi azzurri e i capelli rossi: così li vedono i traci. Ma se i buoi, i cavalli e i leoni avessero mani e potessero con le loro mani disegnare e fare quello appunto che gli uomini fanno, i cavalli disegnerebbero figure di dèi simili ai cavalli e i buoi simili ai buoi, e farebbero loro dei corpi come quelli che ha ciascuno di loro». E aggiunge: «Solamente un Dio è il supremo, unico tra gli dèi e gli uomini, né per la figura simile ai mortali né per il pensiero. Senza fatica con la forza del pensiero tutte le cose fa vibrare. Tutto intero vede, tutto intero pensa, tutto intero ascolta».
Il termine Dio è segno di contraddizione non solo per quanti lo affermano come la Realtà più reale, ma anche per coloro che lo negano come interamente irreale. Quanti dicono di “credere” in Dio credono in cose molto diverse, persino contraddittorie; allo stesso modo, quanti rifiutano Dio rifiutano cose assai differenti; e avviene spesso che ciò che affermano molti cosiddetti credenti ha ben poco a che vedere con ciò che negano molti presunti atei, e viceversa.
La parola Dio è, allora, polisemica. Non c’è un Dio universale, poiché la sua immagine concreta dipende dalla cultura e dal linguaggio, sempre particolari.
La storia di Matteo Ricci
La storia di Matteo Ricci (1552-1610) è a tal riguardo illuminante, un buon esempio dei fraintendimenti a cui si presta il termine Dio. Matematico e cartografo italiano, mente lucida e cuore aperto, entrò nella Compagnia di Gesù che era stata da poco fondata e chiese di andare in Cina come missionario come altri compagni prima di lui. Era convinto di professare la vera religione, di conoscere l’unico vero Dio, ma nel profondo, oscuramente, intuiva, benché non potesse dirlo – non poteva dirlo neppure a se stesso senza entrare in agitazione – che ciò che professava come cristiano era in fondo uguale a quanto professavano o vivevano i confuciani cinesi duemila anni prima di Cristo.
Giunto in Cina nel 1582 – a Macao, allora colonia portoghese –, si dedicò con impegno a studiare il cinese, a elaborare mappamondi e a insegnare matematica agli intellettuali del posto. Adottò vesti cinesi e adattò fin dove poteva la sua pratica cristiana alla cultura locale, compresi il linguaggio e i riti, entrando per questo in conflitto con Roma.
Uno dei problemi più complicati fu per lui quello del nome di Dio: come chiamare in cinese il Dio cristiano? Si trovò dinanzi a un grande dilemma: o inventare una parola cinese specifica che potesse suonare più o meno come Dio in portoghese (con il rischio che per i cinesi non significasse nulla) o utilizzare una delle espressioni usate nella tradizione cinese per dire qualcosa di simile al significato di Dio per i cristiani (con il rischio di provocare permanenti malintesi). Ricci optò per questa seconda alternativa. Nella tradizione cinese esistevano tre termini per dire più o meno Dio: Tian (Cielo), Shangdi (Signore delle altezze) e Tianzhu (Signore del cielo), il primo riferito a una realtà “impersonale”, gli altri due a una realtà più “personale”, benché distante dall’immagine personale del “Dio” biblico. Ricci si decise per Tianzhu, pur usando in realtà i tre nomi come sinonimi.
100 anni dopo, però, nel 1704, il papa accettò solo Tianzhu, proibendo gli altri due. Un divieto di enormi conseguenze storiche per il futuro del cristianesimo in tutto l’Oriente.
Sarebbe stato meglio se Ricci avesse scelto Liu si, che suonava simile al Deus portoghese? Ma avrebbe evitato che i cinesi e i portoghesi, pur usando lo stesso nome per Dio, lo rappresentassero e lo intendessero in maniera diversa? E gli stessi cinesi confuciani intendevano e immaginavano tutti allo stesso modo la Realtà che chiamavano Tian? I portoghesi cristiani intendevano e immaginavano forse la stessa cosa quando dicevano Deus? Ovviamente no.
Una confusione senza fine di parole, immagini, significati. È il limite della parola. Ma un limite che costituisce anche la sua forza, in quanto ci apre all’Infinito indicibile.
Possiamo ancora dire Dio?
In mezzo a tanta confusione e tra tanti e gravi fraintendimenti, vale la pena continuare a dire Dio? È discutibile, senza alcun dubbio. Comprendo coloro che hanno deciso di evitare la parola. Malgrado tutto, però, penso che chiamare (anche) Dio la Realtà fontale innominabile, come lo hanno fatto Tillich, Panikkar, ecc. abbia ancora senso.
E lo penso per tre ragioni fondamentali: in primo luogo, perché la parola Dio, con tutta la sua ambiguità, è comunque presente in tutti i nostri dizionari, e nella nostra lingua millenni prima dei dizionari; in secondo luogo, perché, nel bene e anche nel male, quella parola è parte inseparabile della mia storia, che non voglio rinnegare anche se nemmeno santificare; e, in terzo luogo, perché penso che qualsiasi circonlocuzione con cui si volesse sostituire il termine Dio (Mistero, Presenza, Fondo della realtà, Realtà fontale, Soffio vitale…), e che io stesso utilizzo spesso e con piacere, non sarebbe meno fuorviante di questo.
È vero, tuttavia, che viviamo in un’epoca di rapida transizione verso una prospettiva spirituale trans-teista (termine che preferisco a “post-teista”). E nutro la certezza che un giorno – sicuramente più presto che tardi – l'immagine tradizionale di Dio come ente immateriale supremo metafisico, onniesplicativo, personale ed esterno al mondo e forse la parola stessa Dio scompariranno. Ciononostante, ancora oggi non ne rifiuto l'uso. A seconda di come mi sento o di dove mi trovo o con chi, non rinuncio a dire Dio per riferirmi non a qualche ente metafisico supremo ma al Mistero che abita e muove il mondo.
Neppure pretendo che tutti attribuiscano alla parola Dio lo stesso significato, perché il significato cambia incessantemente, e Dio è al di là di tutti i significati dei dizionari e dei credo.
Diciamo Dio, dunque, ciascuno con i termini e le figure che appaiano più significativi e ragionevoli, nel modo che risulti più conforme alla nostra visione, al nostro linguaggio, alla nostra grammatica del mondo. E anche quando parliamo lingue diverse e tracciamo significati diversi, nella misura in cui lo spirito o l'anima della vita ci ispirino, respireremo tutti lo stesso Soffio, ci capiremo tutti nell'Incomprensibile oltre le parole.
La parola Dio nei nuovi paradigmi
Ogni parola acquista il suo significato pieno all’interno di un contesto: una frase, una lingua, una tradizione linguistica, una società determinata, una storia personale, delle circostanze date. E all’interno di una cosmovisione, di un quadro o modello – teorico-practico – generale di comprensione della realtà nel suo complesso. Tale quadro o modello base di comprensione viene chiamato comunemente “paradigma”.
Ebbene, l’immensa maggioranza di quanti dicono Dio associano ancora questa parola a un ente metafisico supremo onnipotente che ha creato il mondo dal nulla e che interviene in esso ed è rappresentato da un’istituzione sacra diretta da persone consacrate. Ma per la stragrande maggioranza, per di più crescente, di questa società cosiddetta occidentale, questa parola non ha più un carattere ispiratore, ha smesso di avere un senso, è diventata una credenza assurda. È incompatibile con la sua visione del mondo. Non rientra nel suo paradigma.
Perché la parola Dio abbia un senso, perché possa ancora essere fonte di ispirazione, dovrà essere reinventata o reinterpretata in linea con il paradigma di comprensione della realtà in generale, dalle particelle alle galassie, dalle emozioni più essenziali fino alle manifestazioni spirituali più complesse e sublimi.
Più concretamente, e a mo’ d’esempio, perché il termine Dio risulti ragionevole, è necessario che significhi o si riferisca a una realtà che non sia essenzialmente incompatibile con Kant (ogni conoscenza razionale critica richiede una base empirica e, pertanto, non possiamo sapere razionalmente ciò che sono entità metafisiche come Dio né se esistono), o con Nietzsche e Heidegger (tutte queste entità metafisiche sono costruzioni umane esplicative e oggettivanti della Realtà), o con Freud (l’immagine di Dio è condizionata dalle relazioni parentali), o con Marx (tutte le religioni e le divinità dipendono – non solo, puntualizzeremmo noi, ma anche – dalle relazioni economiche), o con Galileo, Newton, Einstein, Hopkins e il telescopio James Webb (l’universo o multiverso non ha centro, ma è un sistema unico di sistemi, in cui tutto è relativo a tutto), o con Darwin (tutti i viventi, dall’ameba al Sapiens e a ciò che potrà ancora emergere, sono frutto della stessa evoluzione, dal più semplice al più complesso), o con Simone de Beauvoir (tutte le grandi civiltà, istituzioni e religioni sono state erette a partire dallo sguardo e dagli interessi dei maschi), o con Hans Jonas ed Etty Hillesum e tutte le persone che hanno posto obiezioni nei confronti di un dio a cui chiedere conto dei drammi del mondo, di tutte le Auschwitz di ieri e di oggi in Etiopia, Sudan, Haiti, Palestina, nel Mediterraneo…
In sintesi, la parola Dio non può avere senso se non nella misura in cui sia comprensibile e compatibile con il paradigma o modello interpretativo di base della realtà, un paradigma generale – a sua volta mutevole – configurato da una serie di paradigmi particolari emersi durante gli ultimi secoli o decenni: un paradigma ermeneutico (i nostri saperi non descrivono la realtà così com’è oggettivamente, ma, al contrario, sono interpretazioni sempre parziali e provvisorie); un paradigma non dualista (materia e spirito, per esempio, non sono due principi o elementi distinti della realtà, bensì due modi o stati della realtà), olistico (tutta la realtà è interrelazionata), post-metafisico (non esistono enti reali – dio, spirito, cielo, inferno… – indipendenti dall’universo o multiverso che chiamiamo “fisico”), dinamico ed evolutivo (tutto si muove e si trasforma incessantemente, Homo sapiens incluso, in un mondo autocreatore e radicalmente aperto a un futuro imprevedibile), cosmocentrico (e, pertanto, trans-antropico), ecologico, femminista ed egualitario, e radicalmente pluralista.
Cerco di dire Dio in questo crocevia culturale, religioso, etico-politico, cosmo-bio-ecologico. E credo che possa avere senso dirlo.
Quando dico Dio
Dio è un nome santo e perverso: può essere il più santo e può essere il più perverso. Non voglio aggrapparmi a questo termine a ogni costo, ma neppure voglio metterlo al bando, cancellarlo dalla mia memoria o strapparlo dalle mie labbra.
Voglio dire Dio per dire la bontà creatrice. Per annuire alla realtà nel suo insieme. Per confessare che, malgrado tutti i mali, tutto è o può essere buono, e che possiamo fare in modo che lo sia. Per affermare che l’Essere è tenerezza e cura. Per dire quella beatitudine piena che prova compassione fino a rendere tutto uguale a sé. Per continuare ad avere tale aspirazione. Per professare ciò che ci unisce nel migliore desiderio, nella grande comunione, nella pienezza dell’orizzonte a cui tutti gli esseri tendono, aspirano e verso cui camminano, di vita in vita, di morte in morte, di passaggio in passaggio.
Voglio dire Dio per dire la Grazia dell’Essere che ci fa essere, e liberarla dalle reti – sociali, economiche, politiche, e non da ultimo religiose – di competizione e di menzogna in cui la teniamo imprigionata. Per dire il Mistero che si rivela in tutto, nel vibrante silenzio che abita ogni cosa. Per dire che siamo affidati e perdonati, amati e accolti, ascoltati e compresi, o che possiamo esserlo o fare in modo che sia così. Per dire il “patto di speranza” (Tertulliano, II secolo), il patto sacro universale di speranza attiva che è l’unica cosa che ci può sostenere. Per dire il Mistero indenne e vulnerabile che ci può curare e ricreare. Per dire che c’è e può esserci compassione e consolazione in mezzo a tutte le lacrime e i drammi e i lutti.
E che possiamo sempre ricominciare.
E se tuttavia Dio fosse solo oppio, illusione, proiezione umana in cerca di consolazione? Se c’è vera consolazione, non è proiezione. Se c’è bontà, non è illusione. Se curiamo le ferite, non è oppio. Dio non sarà, o sarà solo a metà o sarà totalmente illusione finché non ci sia giustizia e guarigione; ma dove le ferite comincino a cicatrizzare e l’ingiustizia a scomparire, lì apparirà Dio – lo si chiami come si vuole –, e i discorsi e le prove della sua esistenza reale non serviranno più.
Sorge qui un’obiezione che mi turba e mi priva di una risposta chiara: se difendo la legittimità dell’uso della parola Dio per dire la Realtà, perché dico Dio per dire solo il bene e la bontà, la consolazione e la guarigione, e non anche lo sconforto e l’infelicità, altrettanto reali? Posso solo balbettare: la Realtà si sta creando, è incompiuta, sta nascendo tra dolori di parto. Non facciamo il bene che vorremmo, facciamo il male che non vorremmo. Chiamo Dio la potenzialità del Reale che noi – tutti gli esseri affratellati – dobbiamo tradurre in realtà in questo cosiddetto “qui e ora”. Forse si potrebbe dire che la Realtà pienamente realizzata già “È”, ma più in là dei nostri stretti parametri spaziali (qui, lì) e temporali (passato, presente, futuro), e noi – tutti gli esseri noti – ci percepiamo come creatori in cammino verso una pienezza che ci attrae e ci sospinge. Ancora in cammino, non posso chiamare Dio l’angoscia, l’egoismo, l’avidità, la prepotenza, l’oppressione, la violenza, frutto tutto ciò della finitezza e dell’ignoranza. Ma continuiamo a camminare. È bello camminare, anche senza conoscere la meta e senza sapere se un giorno arriveremo a destinazione e si realizzerà la pienezza in ciò che chiamiamo “tempo”.
La parola Dio tra silenzio e silenzio
Come tutte le melodie, tutte le sinfonie, tutte le parole. Il silenzio precede un pezzo musicale. Facciamo silenzio prima che il canto cominci, prima che attacchi a suonare il piano o il violoncello, prima che inizi il concerto. E dopo l’ultima nota torna il silenzio profondo, anche in mezzo a un applauso scrosciante. Il silenzio precede la parola, e dopo la parola torna il silenzio. La parola nasce dal silenzio e torna al silenzio.
Non mi riferisco al silenzio fisico, che non esiste, in quanto l’universo intero è attraversato da onde che vibrano. Mi riferisco al silenzio mentale, emozionale, spirituale, l’unico in grado di sperimentare il Fondo della realtà come vuoto di tutte le nostre forme sensoriali e mentali. Dio si rivela occultandosi come Silenzio Assoluto, come Pienezza del vuoto. È rivelatrice solo la parola che germoglia dal Silenzio e conduce al Silenzio.
Il silenzio spirituale è la purezza di cuore, fatta di non attaccamento. È l’apertura del terzo occhio al fondo dell’occhio fisico che coglie le forme e dell’occhio psichico che coglie le emozioni e i pensieri. Solo in questo silenzio ha senso la parola Dio, poiché Dio è «silenzio di tutte le parole» (E. Jabès, Le Livre de Yukel).
La parola è un breve interstizio tra il silenzio che precede e il silenzio che segue. E «chi non ha gustato il silenzio non assapora la parola» (R. Panikkar, Il silenzio del Buddha). Facciamo silenzio per negare ciò che è noto o tutto ciò che possiamo comprendere, e per riconoscere l’inconoscibile. Facciamo silenzio per affermare l’indicibile, non con un silenzio muto né con un silenzio che nega soltanto, bensì con un silenzio che ascolta, riconosce, rivela. Le parole devono tacere per riuscire a dire tutto.
Ne deriva che non dobbiamo più dire Dio né parlare di Dio? Non necessariamente. «Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere», sentenziò Wittgenstein. «Su ciò che non si può dire, bisogna parlare», replica Joseba Sarrionandia, scrittore basco, agnostico mistico. Hanno ragione entrambi. Ed entrambe le consegne possono valere per ciò che riguarda il parlare di Dio e il pronunciare la parola Dio.
Nella Tanakh (la Bibbia ebraica), Elohim è il nome comune che equivale a Dio (in realtà Elohim significa letteralmente “dei”, poiché è la forma plurale di El, “dio”), mentre il tetragramma YHWH (Jahvè) è il nome proprio. E la suggestiva particolarità è che, leggendo la Tanakh pubblicamente o privatamente, gli ebrei pronunciano Elohim (il nome comune), ma mai YHWH, il nome proprio, dicendo al suo posto Adonai (Signore). Dio è un nome comune (sempre plurale) e si può pronunciare come qualunque altro nome o parola, ma è anche un nome proprio unico che non si deve mai dire. Intendo tutto ciò come un’immagine di quanto volevo affermare in questo capitolo: che di Dio possiamo parlare, che possiamo anche chiamarlo dio, ma sempre con parole nate dal silenzio che ritornano al silenzio.
*Foto presa da Unsplash, immagine originale e licenza
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!