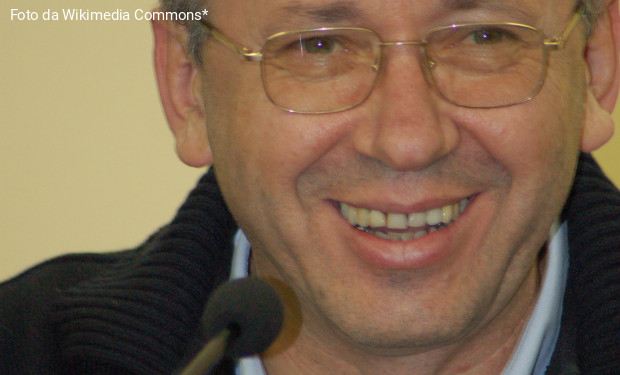
Il caso di Marko Rupnik: la prospettiva di un’artista
Tratto da: Adista Documenti n° 8 del 01/03/2025
Qui l'introduzione a questo testo.
Mentre immergo le dita nell'acquasantiera, noto immediatamente grandi figure dagli occhi spalancati che mi volteggiano intorno in una luminescenza brillante. Mi blocco, cercando di recuperare l’equilibrio. Rimandandomi con ansia alle mie crisi infantili di ipoglicemia, l'ambiente circostante è distorto come se fossi in un circo. I lineamenti delle persone intorno a me sembrano esagerati e il terreno instabile sotto i miei piedi. Mentre mi faccio il segno della croce, i miei pensieri corrono: "Questa è una cappella di Rupnik. Non sapevo che lo fosse. Non ero pronta a questo".
Man mano che mi inoltro nella cappella, il cuore prende a battermi forte nelle orecchie. In preda all’angoscia, faccio un cenno a sr. Theresa Aletheia. Mi guarda con una tristezza consapevole e mi fa sedere con discrezione nel banco più vicino. La mia adrenalina si placa mentre inizio a pregare. Per la prima volta dopo la mia esperienza con un direttore spirituale violento, mi sento in pericolo a messa. Ero venuta con gioia per far visita a un'amica e adorare Dio. Invece sono stata colta di sorpresa, e faccio fatica a nascondere quanto la mia reazione sia profonda.
Circondata dall'effetto delle creazioni di Rupnik, la mia vulnerabilità non aveva un posto dove trovare rifugio, in uno spazio completamente dominato dall'immaginazione di un predatore sessuale. L'arte destinata a elevare la mia anima per l'adorazione aveva invece avvolto i miei sensi ricordandomi come l'abuso clericale può diabolicamente distorcere la bellezza.
Maestoso ma non bello
La cappella col mosaico dal pavimento al soffitto in cui sono entrata quel giorno è stata progettata da Marko Ivan Rupnik. Ex gesuita, il sacerdote ora deve affrontare molteplici accuse di abusi sessuali da parte di religiose, molte delle quali coinvolte nella creazione della sua opera d'arte. Dopo una grande pressione pubblica perché le accuse di abusi venissero affrontate, è stato istituito un tribunale indipendente presso il Vaticano per determinare il destino di Rupnik.
Celebrato per molti anni, Rupnik e il suo team di artisti al Centro Aletti hanno cercato di creare arte liturgica contemporanea fondendo la tradizione orientale e quella occidentale. Come artista, posso capire perché molti siano stati attratti dal suo lavoro. I suoi progetti mantengono una coerenza e una consistenza interessanti, così come un'audacia nel colore e nell'asimmetria che crea un senso di movimento. Le sue installazioni, che attirano l'osservatore in un cosmo di simboli sacri, occupano interi ambienti. Trascinando l'osservatore in un mondo di intenzionalità, il suo lavoro riorienta la tradizione in un modo apparentemente autorevole e mirato.
Il Centro Aletti, la comunità che collabora nella produzione e nell’installazione delle opere di Rupnik, descrive il suo stile artistico concentrandosi sui temi della luce, del movimento e della luminosità. Nel suo «linguaggio organico nuovo»", sostiene, non c’è «niente di tetro, di cupo, di oppressivo, di deprimente, è una esplosione della luce». Questo aspetto della sua arte mi ha sempre turbato; l'abbondanza, lo splendore e la proliferazione dei suoi progetti mi sono sembrati impersonali, più un prodotto dell'influenza del capitalismo sulla Chiesa che qualcosa di sacro o prezioso. Oscurata dalle rivelazioni di abusi, l'enfasi sulla luce esplosiva e brillante nei mosaici di Rupnik diventa non solo scomoda, ma paradossale. Le sue scelte artistiche, purtroppo, hanno senso se considerate nel contesto delle ricerche sulle persone che abusano sessualmente, che spesso sottolineano la fase di “adescamento” mantenendo un'immagine che agli altri appare molto simile alle icone di Rupnik: estremamente "luminosa".
San Giovanni Paolo II chiama gli artisti "profeti" e "ambasciatori della bellezza", incaricati di testimoniare la presenza di Cristo nel mondo. Agli artisti è affidato in modo particolare il compito di salvaguardare la vulnerabilità, un punto di ingresso sacro per la presenza guaritrice di Dio. L'Incarnazione, Dio che diventa un bambino vulnerabile, è l'espressione ultima di questa verità. Nel corso della storia, gli artisti hanno raffigurato questa vulnerabilità primordiale dalla Natività alla Crocifissione. Carismatico, talentuoso e influente, Rupnik ha utilizzato la sua abilità artistica, la sua fama e la sua intuizione, in particolare la vulnerabilità al centro del suo processo creativo, per sfruttare le sue vittime anziché glorificare Dio. Pervertendo il suo compito sacro di artista, Rupnik ha utilizzato la sua autorità di sacerdote e la sua maestria di artista per sfruttare la stessa vulnerabilità che era chiamato a proteggere e a considerare sacra.
Arte sacra o prodotto di un abuso?
Poiché Rupnik era un maestro nel suo campo, alcuni hanno sostenuto la necessità di preservare la sua arte. Questa linea di argomentazione spesso lo paragona ad artisti come Raffaello o Caravaggio, che erano ben lungi dall'essere dei cristiani modello. Tuttavia, mentre i peccati di Raffaello e Caravaggio erano distinti dalla loro arte, l'abuso e il misticismo perverso di Rupnik erano parte integrante del suo processo creativo. Le testimonianze delle sue vittime rivelano che la sua arte non può essere districata dai suoi crimini. Piuttosto, era intrinseca a essa.
Come fanno comunemente i predatori nei contesti ecclesiastici, Rupnik ha preso di mira donne devote e dedite. Co-fondatore di una comunità religiosa femminile, Rupnik è accusato da una delle sue vittime di aver abusato di quasi la metà dei suoi membri. Sulla base delle loro testimonianze, l'abuso in gran parte ha coinvolto il suo processo artistico.
Una vittima ha raccontato in un'intervista: «Una volta mi ha chiesto di posare per un suo quadro perché doveva disegnare la clavicola di Gesù e non cercava delle ragazze “del mondo”, che esprimevano a suo dire solo sessualità, ma una persona in ricerca come me. [...] Non è stato difficile accettare e sbottonare qualche bottone della camicetta. Per me, che ero ingenua e inesperta, significava soltanto aiutare un amico. In quell'occasione mi ha baciata lievemente sulla bocca dicendomi che così baciava l'altare dove celebrava l'eucarestia».
Un'altra ex suora ha descritto come fu abusata sessualmente su un'impalcatura mentre installava mosaici in un santuario. Come ha detto una religiosa, «La sua ossessione sessuale non era estemporanea, ma profondamente connessa alla sua concezione dell'arte e al suo pensiero teologico».
Queste testimonianze decodificano e illuminano uno schema inquietante: il processo artistico di Rupnik era intrecciato con il suo abuso, rendendo le sue creazioni prodotti di un abuso piuttosto che arte sacra.
Nella storia dell'iconografia su cui si basa il lavoro di Rupnik, il processo è importante tanto quanto il risultato finale. Un'icona è scritta, non prodotta. L'iconografia è considerata più una preghiera che un'espressione artistica, in cui si pensa che la mano dell'artista sia guidata dall'ispirazione di Dio. Scrivere un'icona è un'esperienza sacra di annullamento per l'artista, poiché egli o ella è coinvolto nell'azione creativa dello Spirito Santo. Invece di rivelare il Padre attraverso la sua arte, tuttavia, Rupnik ha scelto con le sue azioni di rendere ambiguo, distorcere e sfigurare il volto di Dio. Attraverso la perversione del suo processo artistico, Rupnik ha violato non solo le donne consacrate e se stesso, ha commesso un sacrilegio, la violazione o il trattamento ingiurioso di una persona o di un oggetto sacro. Questo sacrilegio, insito nel processo di creazione della sua arte, è il motivo per cui l'arte di Rupnik non può essere considerata arte sacra.
Conclusione: un invito alla memoria e al rinnovamento
La memoria è centrale nella nostra fede cristiana. I nostri spazi liturgici custodiscono la memoria della nostra salvezza, santificata dalle parole di Cristo: «Fate questo in memoria di me». L'arte sacra ha lo scopo di aiutarci a ricordare ciò che Cristo ha fatto per noi.
L'arte di Rupnik, d'altro canto, serve come promemoria di abusi e tradimenti. In quanto prodotto di abusi, la sua arte racconta una storia di sfruttamento e di fallimento istituzionale. Per riconoscere il danno fatto, onorare le vittime e reclamare questi spazi per un’adorazione autentica, dovremmo impegnarci a rimuovere le sue opere dagli spazi sacri, non come un atto di cancellazione, ma come un passo verso la guarigione e il rinnovamento.
Tra le prime vittime di Rupnik a condividere pubblicamente la sua storia, Gloria Branciani ha sostenuto che «un'opera [...] nata da un'ispirazione di abuso non può rimanere in un luogo dove le persone vanno a pregare». Suggerisce che i mosaici di Rupnik devono almeno essere inseriti in un contesto diverso.
Sono d'accordo e suggerisco che queste opere dovrebbero essere considerate arte contemporanea, piuttosto che arte sacra. A Lourdes, ad esempio, la decisione di non illuminare più i mosaici di Rupnik riflette un'intuizione sacra: ciò che è stato presentato come luce in realtà vela l'oscurità. Lasciare che le sue opere rimangano in uno stato d'ombra riconosce l'abuso e il fallimento istituzionale che rappresentano.
Queste azioni avviano un processo di guarigione riparatrice all'interno del Corpo di Cristo e della sua Chiesa.
Mentre entriamo in questo Giubileo della Speranza, tuttavia, propongo di andare oltre la ricontestualizzazione dell'arte di Rupnik. Se ci teniamo davvero a essere testimoni evangelici in questo mondo moderno, il modo in cui affrontiamo le circostanze complesse degli abusi è importante. Dovremmo rispondere a questa situazione come non ha fatto Rupnik, cioè rispettando la vulnerabilità altrui, e facendo grandi sacrifici che riconoscano e onorino questa vulnerabilità.
In questo spirito, suggerirei che qualsiasi istituzione che debba prendere decisioni sui mosaici di Rupnik dovrebbe impegnarsi a smantellarli. Gli artisti potrebbero usare le tessere per creare nuove installazioni dedicate alle sopravvissute. Questi mosaici potrebbero essere ospitati in una cappella dedicata a chi ha subìto abusi. Comunicando con la voce autorevole della Chiesa, una cappella dedicata alle vittime esprimerebbe questo: "Vi vediamo, ci dispiace di non essere riusciti a proteggervi, voi che esprimete la bellezza di Dio nella vostra vulnerabilità. E vi ascoltiamo. Voi siete la Chiesa".
Quale modo migliore per celebrare questo anno giubilare della speranza se non coinvolgendo gli artisti in quest’opera riparatrice?
*Foto presa da Wikimedia Commons, immagine originale e licenza
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


