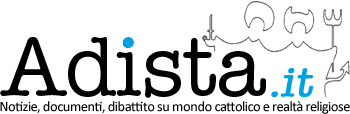PER UNA GIUSTIZIA E UN’ETICA PLANETARIE
Tratto da: Adista Documenti n° 46 del 22/12/2012
(…) Ho trascorso gli ultimi venticinque anni della mia vita a Palermo, una città che, nell’immaginario collettivo, viene piuttosto percepita come un luogo simbolo che trascende la dimensione puramente geografica, come la capitale della mafia, come la patria elettiva degli assassini, come epicentro di un impero del male contro cui nel tempo si sono schierati, venendone inesorabilmente travolti, alcuni solitari paladini del bene di cui si onora la memoria. Eppure questo luogo simbolo è stato una delle più importanti fucine di formazione etica di questa nazione. Un luogo nel quale intere generazioni sono state costrette a misurarsi con i grandi temi della vita. Proverò a spiegare il senso di questa contraddizione.
A Palermo la protagonista occulta della vita cittadina è stata la morte. Quasi non vi è strada, non vi è crocevia, non vi è piazza in cui non sia stato consumato un omicidio, una strage. La città è disseminata di lapidi e di targhe che ricordano che qui è stato ucciso un magistrato con la sua scorta, qui un prefetto, qui un poliziotto, qui una persona che ha avuto il coraggio di testimoniare in un processo di mafia, qui un prete, e via di seguito con una triste contabilità della morte che quasi non ha fine. Ma anche laddove mancano lapidi e targhe, la memoria collettiva degli abitanti conserva tracce indelebili di sparatorie, di corpi crivellati o squarciati dall’esplosivo, di donne piangenti, di volti attoniti e smarriti. (…).
Ma la morte è stata protagonista della vita cittadina non solo per i tanti lutti del passato, ma anche perché ha abitato continuamente, e spesso segretamente, la mente e il cuore dei vivi come una minaccia costante. Mi riferisco a coloro che sono rimasti in vita e che tuttavia, per anni, hanno dovuto convivere col pensiero della propria morte, temendo di essere uccisi perché avevano osato ribellarsi alla mafia. Mi riferisco ai tanti che, invece, hanno ceduto alle richieste della mafia e talora ne sono divenuti complici e che, prima di compiere questo passo, hanno immaginato la propria morte, se non fossero stati arrendevoli, ed hanno rivisto mille volte nella propria mente il film della morte di altri che erano stati più coraggiosi e più onesti di loro. Mi riferisco agli stessi assassini, ai somministratori di morte che convivono quotidianamente con la consapevolezza di poter essere uccisi a loro volta, spesso – come mi hanno confessato – con il ricordo dell’ultimo sguardo delle loro vittime.
Coloro che sono costretti a misurarsi continuamente con l’esperienza della morte sono costretti anche a interrogarsi continuamente sui grandi temi della vita e dell’etica: da che cosa trae origine il male? Esiste una possibilità di giustizia sulla Terra? È possibile una giustizia giusta in una società ingiusta? Che senso ha la vita, se la realtà, che sembra riprodursi sempre uguale a se stessa, è sempre più ridotta ad una competizione senza esclusione di colpi che premia i più forti e i più furbi – siano essi politici corrotti, “colletti bianchi” della mafia, imprenditori, affaristi spregiudicati –, mentre i fragili, gli impotenti, gli ultimi scivolano sempre più giù nella scala sociale? Ha senso morire, sacrificare la propria vita, per opporsi a questo stato di cose, per cambiare la realtà? E in tutto questo dov’è Dio? E, se Dio esiste, qual è il volto di Dio? E come è possibile che vittime e carnefici, sfruttatori e sfruttati, corrotti e onesti siano spesso tutti cattolici, preghino lo stesso Dio e, cosa straordinaria, si sentano tutti in pace con se stessi?
Ho conosciuto killer e mandanti di omicidi i quali mi hanno rivelato che, dopo ogni omicidio, si recavano in chiesa per chiedere perdono a Dio, pronti per il successivo delitto. Ne ho conosciuti altri che mi hanno confessato che si recavano sulle tombe di coloro che erano stati costretti ad abbattere. Il loro motto: “Dio sa che sono loro che hanno voluto farsi uccidere perché non hanno ascoltato i consigli degli amici”.
E perché meravigliarsi dei mafiosi? Non è forse vero che il mondo è pieno di assassini ben più feroci di Riina, di Provenzano, dei mafiosi; assassini responsabili di genocidi, di massacri? Pensiamo ai dittatori latinoamericani, i quali si sono sempre professati buoni cristiani e, in tale convinzione, sono stati confortati da alti prelati che hanno mangiato alle loro mense e che li hanno benedetti sul letto di morte come salvatori della patria.
Ecco, su tutto questo e su molto altro ci si interroga continuamente a Palermo dinanzi alla tragica e perenne realtà della morte (…). Domande che invece sono da molto tempo escluse dall’orizzonte problematico della cultura postmoderna, una cultura che infantilizza gli esseri umani perché li imprigiona in un eterno presente nel quale l’unico scopo della vita sembra essere il consumo illimitato di beni superflui e il successo personale comunque conseguito (…).
IL LUOGO DELLE SCELTE RADICALI
Palermo, dunque, è stata ed è un laboratorio di etica perché in questo luogo si continuano a porre domande radicali e anche perché si coltiva il “vizio” della memoria. A Palermo siamo costretti a ricordare. Il passato è come un film rivisto mille volte nella moviola della memoria e continuamente interrogato, rielaborato, indagato alla ricerca di risposte a domande di senso che restano come sempre eternamente sospese. Lo interrogano i magistrati alla ricerca dei colpevoli, ma lo interrogano anche gli storici, perché la Storia, la Storia nazionale, quella con la maiuscola, è sempre passata da Palermo e dalla Sicilia. Dall’unità d’Italia ad oggi nessuno – destra, centro, sinistra – è riuscito a governare questo Paese senza venire a patti con la borghesia mafiosa, un potentissimo blocco sociale che aggrega attorno ai propri interessi quote imponenti di consenso elettorale in grado da sempre di condizionare gli equilibri politici nazionali. (…). Il passato a Palermo viene continuamente interrogato anche dai parenti delle vittime nello sforzo di elaborare un lutto che non si stanca mai di chiedere perché, e viene interrogato anche dai tanti che in un modo o nell’altro sono stati coinvolti in eventi tragici e non cessano di chiedersi se avrebbero potuto fare qualche cosa per evitarli e se per caso quegli eventi non siano destinati a ripetersi come se vivessimo all’interno di una tragedia inceppata che si ripete sempre uguale a se stessa.
Palermo, dunque, è il luogo in cui si coltiva il vizio della memoria, che è una componente essenziale dell’etica. (…). La memoria sfida la morte perché sottrae la vita vissuta e meritevole di essere ricordata al non senso dell’oblio. La memoria è anche un ingrediente essenziale della giustizia, perché i fatti, fino a quando non vengono dimenticati, sono come un indice puntato nei confronti degli assassini. Come ha giustamente scritto lo scrittore Milan Kundera, «la lotta contro il potere è la lotta della memoria contro l’oblio». E non è un caso che i dittatori abbiano sempre avuto paura della memoria. Il dittatore argentino Videla soleva ripetere: «La memoria è sovversiva».
In questo senso, Palermo è una città di memoria sovversiva perché tiene in vita la domanda di verità e giustizia nei confronti di una criminalità del potere che ha sempre offerto protezione e impunità alla mafia, perché della mafia si è servita per fini di potere e di accumulazione di ricchezze.
Ed è un luogo etico perché costringe a scegliere tra il bene e il male e a conoscere se stessi. In altri luoghi più fortunati, la differenza tra il bene e il male, tra il bianco e il nero, sembra a volte sfumare tra i mille toni grigi intermedi. (…). Così, a volte, si può trascorrere un’intera esistenza a raccontare a se stessi e agli altri più come si vorrebbe essere che come si è. E a volte si muore senza neppure conoscersi. A Palermo, invece, la dura realtà ti afferra prima o poi per il bavero e ti costringe a fare scelte di vita o di morte, rivelandoti a te stesso per quello che sei. Se fai il commerciante, prima o poi ti vengono a chiedere il pizzo o tentano di coinvolgerti in affari sporchi. E allora devi scegliere: se pagare e diventare complice della mafia oppure ribellarti, denunciare e rischiare di venire ucciso, come è accaduto all’imprenditore Libero Grassi. Se sei un sacerdote, devi scegliere se limitarti a essere – come diceva Ernesto Balducci – un “burocrate di Dio”, a fare prediche improntate a un astratto amore per il prossimo, al valore della famiglia, a una carità che spesso si riduce a una comoda cultura dell’elemosina che mette a posto la coscienza con pochi spiccioli, oppure se uscire fuori dal recinto protetto della parrocchia, immergerti nella difficile realtà del quartiere, testimoniare concretamente i valori evangelici tentando di strappare i ragazzi a un destino di mafia, come fece padre Puglisi. Se fai il giornalista, puoi limitarti a un asettico resoconto delle vicende criminali oppure fare giornalismo investigativo sul territorio, portando alla luce storie di sopraffazione e di malaffare, e per questo venire ucciso, come è capitato a Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Mario Francese, Giuseppe Alfano e tanti altri. Se sei un medico e ti chiedono una consulenza compiacente per far uscire un boss dal carcere o scagionarlo da un delitto, puoi accettare oppure rifiutarti e venire ucciso, come accaduto a Paolo Giaccone, medico legale di Palermo assassinato nel 1982 perché aveva respinto la richiesta di falsificare una perizia per evitare la condanna all’ergastolo di un mafioso. E anche se sei un comunissimo cittadino devi fare delle scelte drammatiche. Ti capita di assistere a un delitto e puoi scegliere di voltarti dall’altra parte oppure di andare a testimoniare e trascorrere una vita blindata o essere ucciso, come è successo a tanti. E potrei continuare a lungo.
Palermo, dunque, è il luogo delle scelte radicali e poiché, come affermava il filosofo francese Jean Froissart, «l’etica consiste nello scegliere e noi siamo le nostre scelte», è un luogo etico o un laboratorio permanente di etica. E questo è il motivo per cui in questo luogo ho conosciuto tante persone straordinarie (…). Non mi riferisco soltanto a magistrati, poliziotti, persone variamente impegnate nel sociale, ma anche a comuni cittadini. Uomini e donne improvvisamente strappati alla loro vita normale e proiettati all’interno di storie drammatiche molto più grandi di loro, che hanno dovuto affrontare la paura, sollevarsi al di sopra della propria fragile umanità e reggere sulle proprie spalle il peso di decisioni che li hanno segnati per tutta la vita. Ho visto persone piangere per la paura, nascondersi il viso tra le mani e gridare: “Non potete chiedermi questo!”; altre, scuotendo la testa, ripetere quasi come in una cantilena: “Devo pensare ai miei figli”. Ne ho viste altre ancora raccogliersi in se stesse in silenzio come per trovare, alle radici della propria anima, la forza interiore necessaria, come per prendere la rincorsa e superare, in un balzo, il confine tra una vita normale e una vita ignota. Alcuni di loro non ce l’hanno fatta, si sono spezzati dentro. Qualcuno si è suicidato. Come Rita Atria.
Rita era una giovane donna con un padre e un fratello mafiosi e assassinati da altri mafiosi. All’età di diciassette anni, Rita aveva deciso di raccontare a Paolo Borsellino tutte le confidenze del fratello sui fatti di mafia ed era stata posta sotto protezione in una località segreta come collaboratrice di giustizia. Per questo, era stata ripudiata dalla sua famiglia, al punto che la madre, dopo la sua morte, si è recata sulla sua tomba per sfregiarne la lapide in segno di disprezzo. Rita Atria aveva deciso di affidarsi a Paolo Borsellino perché in lui, nella sua straordinaria umanità, non vedeva soltanto un magistrato, ma una sorta di padre, il simbolo di uno Stato paterno che pone la sua forza tranquilla a difesa dei fragili in un mondo di ingiustizia e prepotenza. Quando, il 19 luglio 1992, Paolo Borsellino venne assassinato, Rita si sentì perduta. Nel suo diario, trovato dopo la morte, scrisse queste parole: «Prima di combattere la mafia, devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta». Una settimana dopo la strage di via d’Amelio, Rita Atria si uccise a Roma, dove viveva in segreto, lanciandosi dal settimo piano di un palazzo di viale Amelia.
IL DIRITTO ALLA FRAGILITÀ
Queste e altre vicende mi hanno profondamente tormentato. Mi sono talora chiesto se era giusto che noi magistrati chiedessimo a persone fragili di reggere sulle spalle un peso che non erano in grado di sostenere. Mi sono chiesto se lo Stato, in casi come questi, debba presentarsi solo con il volto dei magistrati che raccolgono testimonianze e di poliziotti che danno protezione, perché c’è necessità anche di una protezione interiore, di un sostegno umano, psicologico, paterno. Il compito delle istituzioni dovrebbe essere anche quello di farsi carico della fragilità degli altri, di rappresentare uno Stato credibile che faccia sentire il singolo come parte di un collettivo in grado di accoglierlo e di proteggerlo contro la forza straripante del male. Forse la legge, oltre a garantire ordine e stabilità sociale, dovrebbe anche proteggere il diritto alla fragilità. Perché coloro che più hanno bisogno della legge sono i fragili, i deboli, perché i forti, i potenti, le leggi spesso se le fanno da sé. (…).
Garantire il diritto alla fragilità, salvaguardare spazi di protezione e di libertà ai più fragili credo sia anche un valore di “ecologia sociale”. Non è forse vero che la fragilità è anche una straordinaria riserva di umanità? Non è forse vero che tra i nostri fratelli più fragili si incontrano spesso le persone migliori, quelle più sensibili, quelle che rifiutano la logica della competizione, che conservano intatta anche per noi quella riserva di umanità alla quale, in alcuni momenti, sentiamo il bisogno inconsapevole di attingere? In quei momenti, anche i forti hanno bisogno dei fragili, anzi hanno soprattutto bisogno di loro, della loro riserva di umanità speciale e incontaminata.
Non basterebbe un giorno intero per raccontare le mille storie di tante altre persone normali, di eroi sconosciuti, maestri di etica, stelle di un lungo martirologio di cui Falcone e Borsellino sono il simbolo riassuntivo e le icone collettive. Falcone e Borsellino, che ho avuto entrambi l’onore di conoscere, (…) sono stati dei grandi creatori di senso. Nel Sud e in molte altre parti d’Italia, parole come Stato, legalità, giustizia sono state per tanto tempo parole prive di senso. Parole usurate da una bolsa retorica a cui non corrispondeva alcuna sostanza reale. Per troppi secoli la legge, come scriveva Gaetano Salvemini, era stata la voce del padrone e lo Stato solo il simbolo di un potere forte con i deboli e debole con i forti. E anche dopo l’avvento della democrazia e della Costituzione antifascista del 1948, in molte parti del Paese, e in particolare in Sicilia, lo Stato ha continuato a non apparire credibile, perché identificato con la classe politica che ne occupava le postazioni istituzionali, con i volti impresentabili di deputati, senatori, ministri, talora presidenti del Consiglio che con la mafia avevano scelto di convivere o, peggio, grazie alla mafia avevano costruito carriere politiche e accumulato ricchezze.
(…) Proprio perché consapevoli che il vero problema era quello di restituire credibilità allo Stato, Falcone e Borsellino hanno dedicato a questo tutta la loro vita e sono riusciti – io credo – in un’impresa storica: quella di restituire lo Stato alla gente, perché, grazie a loro e a persone come loro, per la prima volta nella storia di questo Paese, lo Stato si è presentato finalmente agli occhi dei cittadini con volti credibili nei quali era possibile identificarsi, dando senso alla frase “Lo Stato siamo noi”.
Falcone e Borsellino sono stati creatori di senso perché hanno strappato la gente alla cupa rassegnazione dell’esistente, al senso di impotenza individuale e collettivo di fronte al prevalere della legge del più forte e del più furbo (…). Grazie al loro esempio e alla ritrovata credibilità dello Stato, della legge, finalmente riacquistava senso parlare di futuro e di libertà. Ma è proprio questo che li ha resi pericolosi. I poteri criminali hanno bisogno di uno Stato debole, privo di credibilità e di sostegno popolare. Il potere alimenta la cultura della rassegnazione fatalistica all’esistente. Il suo messaggio è: “Fatti gli affari tuoi, pensa alla tua famiglia, perché tanto non c’è nessuno in cui credere”. E così la potenza virtuale del collettivo viene frammentata nell’impotenza dei singoli.
La reazione contro Falcone e Borsellino iniziò proprio quando il potere politico ed economico, che costituisce la vera forza della mafia, cominciò a sentirsi in pericolo. Iniziò quando il pool antimafia alzò il livello delle indagini arrestando i potentissimi “colletti bianchi” appartenenti ai piani alti della piramide sociale e del potere mafioso e legati ai vertici della politica e della finanza.
Quando si comprese che il pool antimafia non si sarebbe fermato e, indagine dopo indagine, sarebbe arrivato all’interno dei santuari del potere, venne scatenata contro Falcone e Borsellino una violentissima campagna di stampa (…). Una strategia della delegittimazione e del discredito che è sempre stata un’arma vincente del potere autoritario e di quello illegale nei confronti di tutti coloro che, assurgendo a simbolo e speranza di un altro mondo possibile, mettono in pericolo gli interessi dei potenti. Anche i sacerdoti del sinedrio, per distruggere la credibilità di Gesù e impedire che divenisse il simbolo di un altro mondo possibile, lo delegittimarono agli occhi della gente presentandolo come impostore e sacrilego. (…).
CONTRO IL MALE OSCURO DEL POTERE
Nelle cerimonie ufficiali, Falcone e Borsellino vengono commemorati come eroi che sacrificarono la loro vita per senso del dovere, ma (…) essi ci hanno insegnato che il senso del dovere è poca cosa se si riduce a distaccato adempimento burocratico dei propri compiti e a obbedienza gerarchica. Essi erano guidati da una forza molto più grande, come ha spiegato lo stesso Paolo Borsellino la sera del 23 giugno del 1992 quando, un mese dopo la strage di Capaci, commemorando Giovanni Falcone, disse testualmente: «Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché è sempre stato pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto di amore verso questa città, verso questa terra che lo ha generato».
Ora sappiamo che quella sera, mentre parlava di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino parlava anche di se stesso, comunicando che, se aveva deciso di restare al suo posto dopo la strage di Capaci, malgrado fosse consapevole di essere condannato a morte, era per amore, perché si sentiva chiamato a rispondere della speranza che tutti riponevano in lui dopo la morte di Giovanni Falcone. Sentendosi perduto, consapevole di doversi misurare, come confidò a sua moglie, con un potere che andava molto al di là della mafia e contro il quale non aveva difese, due giorni prima di morire chiamò al Palazzo di Giustizia un sacerdote e si confessò, attendendo la morte.
Uno dei killer mafiosi di padre Puglisi, divenuto collaboratore di giustizia, ha confessato che ciò che più lo aveva colpito di quell’omicidio fu che quando Puglisi aveva visto i suoi assassini andargli incontro e si era reso conto che stava per essere ucciso, li aveva guardati con serenità e aveva loro detto: «Vi aspettavo». Ecco, io credo che, se Paolo Borsellino avesse avuto un attimo di tempo prima che il suo corpo venisse squarciato dall’esplosivo, anche lui avrebbe detto, come padre Puglisi: «Vi aspettavo».
Per questo ritengo che Falcone, Borsellino e altri come loro possano venire considerati, oltre che come martiri dello Stato, anche come martiri cristiani. E poco importa se taluni non erano credenti come lo era invece Borsellino, perché il loro esempio di vita e il loro sacrificio sono stati comunque una testimonianza di fede nei valori cristiani di fratellanza di molto superiore a quella di tanti cattolici che si credono buoni cristiani solo perché frequentano le funzioni religiose (…).
Come sottolinea il teologo Alberto Maggi, Gesù è stato ucciso dal potere. Per catturarlo, venne scatenata un’operazione di polizia senza pari: vennero impiegati una coorte romana (composta da un numero di soldati che variava tra i 600 e i 1.000) al comando del procuratore romano e la guarnigione dei soldati del Tempio di Gerusalemme (composta da circa 200 uomini) alle dipendenze del sommo sacerdote Caifa. Circa mille uomini armati per arrestare un solo individuo che non oppone resistenza.
Ma Pilato e Caifa, simboli del potere politico e di quello religioso, avevano validi motivi per considerare Gesù un pericoloso sovversivo dell’ordine precostituito. Gesù fu ucciso, dice Maggi, perché il suo insegnamento poneva le basi per una democratizzazione della società che poteva destabilizzare l’ordine esistente: l’immagine di Dio da lui proposta comportava un cambiamento profondo non soltanto nel rapporto tra essere umano e Dio, ma anche nel rapporto tra esseri umani, inaugurando una nuova relazione nella quale veniva esclusa qualsiasi forma di dominio. (…). Gesù, dunque, viene ucciso dal potere perché simbolo di un ordine alternativo a quello esistente.
L’alleanza tra Cesare e Caifa è rimasta purtroppo una costante nella storia, riproponendosi sotto svariate forme nei secoli successivi. (…). Com’è stato osservato, il più pericoloso nemico del cristianesimo non fu l’imperatore Diocleziano, che perseguitava i cristiani e ne faceva dei martiri, ma l’imperatore Costantino, perché da allora il potere si è costantemente intromesso nello spazio tra Dio e l’essere umano, contaminandolo. Lo scrittore inglese cattolico Chesterton ha scritto che Dio ha cominciato a morire nel momento in cui istituzioni antidemocratiche e illiberali, per meglio rafforzare il proprio prestigio e potere, si sono presentate alla gente sotto il suo nome, dicendo: “Noi parliamo a nome di Dio. Siamo i suoi servi e i suoi rappresentanti, dunque ci è dovuta obbedienza, perché obbedendo a noi in realtà obbedite a lui. Chi ci contesta e ci critica commette peccato di superbia e di blasfemia”. La lezione della storia offre un ricco e triste catalogo di dittatori sanguinari che in Europa e in America Latina sono stati definiti uomini della provvidenza o salvatori della patria dai vertici vaticani, nonostante si fossero resi responsabili di genocidi e di orrendi delitti.
Se, malgrado tutto, la lezione evangelica contro il male oscuro del potere è giunta sino a noi, lo si deve a tutti coloro che, nel corso della storia, percorrendo talora strade diverse, sono stati accomunati dall’impegno ad umanizzare il potere, a costruire un potere che fosse al servizio degli esseri umani. Su questa strada sono caduti i martiri dell’antimafia, e coloro che sono stati uccisi o ridotti al silenzio da poteri antidemocratici e antiumani (…). Tra questi martiri, un posto di rilievo lo occupano coloro che, per restare fedeli all’insegnamento originario di Gesù, si sono schierati dalla parte degli ultimi, tentando di spezzare il perverso rapporto tra fede e potere, e per questo motivo sono stati spesso emarginati dai vertici ecclesiastici, condannati alla solitudine e al silenzio e talora sacrificati sull’altare del patto tra Cesare e Caifa.
Si potrebbe compilare un lungo elenco dei martiri cristiani che sono stati nello stesso tempo martiri della democrazia, basti pensare a mons. Oscar Romero e a tanti esponenti della teologia della liberazione (…). I mandanti dell’omicidio di Oscar Romero sapevano bene che uccidere quel vescovo, simbolo di un cristianesimo non addomesticabile dal potere, non avrebbe determinato, come non determinò, la reazione del Vaticano, reazione che avrebbe esposto il regime dittatoriale al rischio di una grave delegittimazione politica agli occhi del mondo democratico. Pensando alla morte di Romero, mi sono tornate in mente le parole pronunciate da Giovanni Falcone: «Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno».
Di tutto ciò padre Ernesto Balducci era pienamente consapevole, non stancandosi mai di denunciare le lunghe compromissioni dei vertici vaticani con il potere e il tradimento delle speranze alimentate dalla breve primavera del Concilio Vaticano II. Per questo scrisse: «Non voglio che si diffonda il cristianesimo che io conosco, voglio che si diffonda il Vangelo che io medito, che è un’altra cosa».
Una primavera, quella del Concilio Vaticano II, che doveva aprire una nuova pagina di speranza nella storia della Chiesa e che invece si concluse (…) con la rivincita della burocrazia e dei vertici vaticani. Ed è così che la storia postconciliare sembra riconnettersi con assoluta continuità alla storia preconciliare. (…). E allora il problema resta quello di ricristianizzare il cattolicesimo spezzando il rapporto perverso tra fede e potere sia all’interno che all’esterno della Chiesa. Spezzare tale rapporto significa restituire la voce di Dio e di Gesù agli esseri umani, significa recuperare uno dei nuclei fondamentali del messaggio di Gesù, il suo monito ai potenti affinché prendano atto della loro complicità nel creare la sofferenza degli esseri umani. (…).
Nel Vangelo di Luca Gesù dice: «Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma piuttosto divisione». Quale divisione? Quella che nasce dalla scelta di stare dalla parte degli umili e degli oppressi. Una scelta che si traduce in una carità attiva a favore di una cultura dei diritti e della liberazione dalle catene del bisogno. Una scelta che condannò Gesù a morte e che, nel corso della storia, ha condannato a morte chiunque abbia osato schierarsi contro il potere.
Ripensando a questo insegnamento di Gesù, mi accade di sognare che, proprio come in ogni aula di giustizia italiana si incontra la scritta “La legge è uguale per tutti”, venga affissa un giorno, all’ingresso di tutte le chiese del mondo, la scritta che un grande vescovo brasiliano aveva fatto dipingere sulla facciata della sua cattedrale: «Il mondo si divide tra oppressori e oppressi. Tu, cristiano che stai per entrare, da che parte stai?».
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!