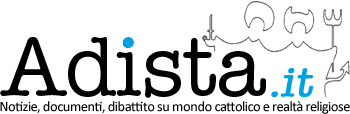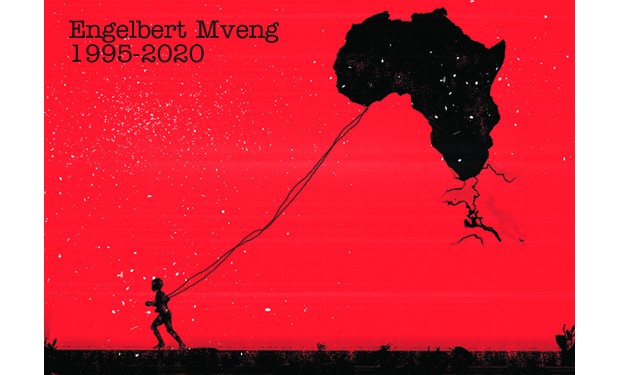
Essere o non essere. La lotta per la vita del padre Engelbert Mveng
A venticinque anni dall’assassinio del grande storico e teologo camerunese p. Engelbert Mveng, gesuita, pubblichiamo l’articolo scritto in suo omaggio dal p. Jean Rwakabuba Muka, barnabita congolese, rettore del Filosofato Isidore Bakanja di Bukavu e parroco a Giheke, in Ruanda. Traduzione a cura di suor Teresina Caffi.
A questo link l'intervento in lingua originale (francese)
Venticinque anni fa, lasciava questa terra dei viventi padre Engelbert Mveng, in circostanze rimaste finora oscure. Storico, teologo, uomo di lettere e uomo di cultura, Engelbert Mveng, prete della prima generazione dei gesuiti camerunesi, fu assassinato nella sua casa a Nkolafeme, in Camerun, nella notte tra il 22 e il 23 aprile 1995. Farne memoria è un dovere di riconoscenza, perché è stato come una meteora nell’universo scientifico africano. La sua luce è brillata un istante ma ha lasciato una traccia indelebile nello spirito e nel dispiegamento del cristianesimo africano. È infatti uno dei pionieri di quella che viene chiamata oggi con fierezza la teologia africana. Eletto segretario nazionale dell’Associazione Ecumenica dei Teologi Africani, lotterà a fianco dei suoi colleghi teologi per un concilio africano. Purtroppo, invece di un concilio, dall’idea nascerà piuttosto un sinodo, il primo Sinodo africano del 1994. Ha testimoniato una vita umana, intellettuale e cristiana unificata attorno a una certa idea che si faceva di questa terra nutrice e di speranza, l’Africa. Ne era così appassionato che tutta la sua vita fu una lotta per la sua emancipazione.
È questa lotta che vorremmo presentare agli eventuali lettori. Sarà approfondita in due ambiti: ecclesiologico e antropologico. Sarebbe stato bello presentarla anche nel suo ambito storico. Pensiamo di farlo ulteriormente.
Per un cristianesimo dal volto africano
Nei suoi scritti e conferenze teologiche, E. Mveng ha militato per un’alleanza riuscita tra il cristianesimo e la cultura africana. Questa lotta s’iscrive nella logica innescata dai teologi africani da quando avevano pubblicato Des pretres noirs s’interrogent nel 1956, nelle edizioni du Cerf, sotto la direzione di Présence Africaine. Nell’introduzione, gli autori così presentano la loro lotta: “Troppo a lungo si sono pensati i nostri problemi per noi, senza noi e nonostante noi. È ora che i neri abbiano una voce in capitolo”. Pensano cioè che è arrivato il tempo per i neri di dire ciò che pensano del Cristo presso di loro. È ora di “indigenizzare” il cristianesimo. Nonostante le opposizioni paranoiche dei teologi occidentali, il Papa Paolo VI a Kampala li stimolerà molto in questa lotta. Nel suo discorso, il santo Padre dice: “L’espressione, cioè il linguaggio, il modo di manifestare l’unica fede, può essere molteplice e di conseguenza originale riguardo alla lingua, allo stile, al temperamento, al genio, alla cultura di chi professa quest’unica fede. Al riguardo, un pluralismo è legittimo, addirittura auspicabile (...). In questo senso, voi potete e dovete avere un cristianesimo africano”.
Certi teologi occidentali considerarono le rivendicazioni di questi giovani preti come arroganza, ingratitudine e ambigua avventura. Convinti dell’inferiorità ontologica e culturale dei negri, negavano infatti loro ogni possibilità di dire adeguatamente Dio negli schemi di pensiero africani. Questa convinzione fu espressa pubblicamente in un dibattito teologico rimasto storico a Lovanio nel 1960, che opponeva da una parte il decano degli studenti Tharcisse Thsibangu e dall’altra il Rettore dell’università, il canonico Vanneste. Quest’ultimo dichiara ad alta voce che la teologia è una scienza e, come tale, non può essere che universale. Impossibile dunque renderla particolare: sarebbe edulcorare la purezza originale e divina della verità rivelata.
I teologi africani non potevano accettare una tale asserzione, convinti com’erano che era venuto il momento di porre il problema del senso e della specificità del cristianesimo considerato come religione storica e rivelata. Era ora per gli africani di assumere la responsabilità di dottrina e di testimonianza loro propria in mezzo ai loro fratelli. A giudizio dei teologi africani, infatti, ciò che gli europei chiamano universalità della teologia non è né più né meno che un’“evidente europeizzazione della religione di Gesù Cristo” (B. Bujo & J. Ilunga Muya (éd.), Théologie africaine au XXè siècle. Quelques figures, vol. I, Kinshasa, Paulines, p. 40).
È nel cuore di questo dibattito e contro questo monopolio degli approcci intellettualisti della Rivelazione cristiana che la voce di p. E. Mveng si leva con autorità. È convinto che questa visione egemonista occidentale soffochi la riflessione africana in gestazione e impedisca una reale appropriazione del cristianesimo da parte dell’Africa. Come può Cristo essere uno di noi quando ci giunge con una modalità di disprezzo?
E. Mveng attinge i suoi argomenti contro i teologi occidentali nella storia stessa del cristianesimo. Esso è nato in Asia e si è all’origine espresso nelle categorie mentali della cultura ebraica. Nel desiderio di appropriarsene, gli occidentali hanno sostituito gli schemi di pensiero ebraici con quelli greco-germanici, senza per questo far perdere al messaggio evangelico il suo vigore e la sua vivacità. Se ciò è stato possibile per l’occidente, è evidente che anche gli schemi di pensiero occidentali attraverso i quali il cristianesimo è giunto all’Africa possono essere sostituiti da altri approcci mentali, tanto più che i costrutti occidentali non sono né evangelici né universali. La fede cristiana è universale, certo, ma le sue espressioni culturali sono, esse, diversificate e particolari.
Ogni cultura è capace del Dio di Gesù Cristo e ogni lingua può dirlo. L’esperienza degli ascoltatori degli apostoli alla pentecoste ne è un esempio eloquente. I primi ascoltavano questi ultimi proclamare le meraviglie di Dio nelle loro lingue (cf. At 2,8). Inoltre, il cristianesimo è giunto in Africa divinizzato in diverse confessioni ecclesiali (anglicani, luterani, calvinisti, romani...). Quale sarebbe la norma di riferimento per questa teologia universale?
A partire da tutto ciò, E. Mveng affermerà che la teologia africana è possibile e deve esistere. Essa deve trarre ispirazione dalle esperienze degli altri per restare aperta all’universale: Cristo e il suo messaggio. Questa vittoria sarà ottenuta il 9 aprile 1985, quando il santo Papa Giovanni Paolo II riconobbe ufficialmente l’esistenza della teologia africana. Perché gli occidentali si sono ostinati a rifiutare un’evidenza? La risposta è data da E. Mveng nel suo libro L’Afrique dans l’Eglise. Paroles d’un croyant pubblicato nel 1985, e costituisce la sua seconda lotta.
Per un’antropologia della vita.
Se l’occidente si è ostinato a rifiutare all’Africa la possibilità di dire Dio nelle proprie configurazioni mentali, la risposta è da cercare nella negazione radicale dell’umanità ai neri. Da molto tempo, l’Occidente ha sempre manifestato nelle sue pratiche (tratta, colonizzazione, evangelizzazione propagandista) una volontà di annichilire e pauperizzare l’uomo nero. Lo dice in questi termini: “La Tratta dei neri rappresenta il nostro annichilimento antropologico. Non è solo la negazione di quelli che oggi vengono chiamati diritti umani. È la negazione pura e semplice della nostra umanità” (E. Mveng, L’Afrique dans l’Eglise. Paroles d’un croyant, Paris, 1986, p. 205):
In una Chiesa egemonica come questa, quale può essere il posto dell’Africa? Considerando l’esperienza concreta della vita in Africa, si sarebbe tentati di rispondere: nessuno. Un forte pregiudizio pesa sul negro: “è senz’anima”. In nome di questo pregiudizio, egli è stato venduto come una bestia da soma nel famoso commercio triangolare. Durante la storia, l’Africa ha subito da parte dell’Occidente delle ingiustizie che l’hanno raggiunta nella sua dimensione più profonda, cioè l’essere africano, con la volontà manifesta di annichilirlo. L’africano ha perso tutto ciò che faceva di lui un umano. È ciò che E. Mveng chiama la pauperizzazione antropologica dell’Africa. Scrive: “La missione e la colonizzazione, viste sotto l’angolo filantropico, sono state alla fine degli agenti della pauperizzazione antropologica dell’uomo africano. Ciò significa che il loro obiettivo ultimo era di proteggere l’uomo nero, per mantenerlo in uno stato d’inferiorità e di dipendenza assolute. L’assimilazione stessa, che aboliva la nostra identità e il nostro diritto alla differenza, era una delle forme estreme di pauperizzazione antropologica”.
Per pauperizzazione antropologica, bisogna intendere un deperimento dei popoli africani dovuto alla colonizzazione. Questa ha provocato una perdita d’identità, un indebolimento della creatività; ha spezzato senza alcun riguardo la vita e l’organizzazione tribali e distrutto i valori indigeni, le credenze religiose e la cultura tradizionale. Le conseguenze di questa barbarie sono lungi dall’essere cancellate. Anziché fasciare le piaghe aperte evocate da E. Mveng, l’Occidente continua a intrattenere queste conseguenze con un neo-colonialismo economico, strategico e culturale. In un’opera postuma, questa povertà antropologica è presentata come una depersonalizzazione, uno spogliamento senza nome dell’africano di ciò che fa di lui un umano: il suo essere, la sua identità, il suo avere, il suo lavoro e la sua cultura. Essa è consistita in una riduzione a uno stato di indigenza e di miseria che lo rende incapace di libertà e di volontà. Essa è una “trasgressione dell’essere africano”.
In una situazione come questa, Mveng cerca la soluzione nel marxismo. Insorgendo contro la povertà economica e sociale di cui soffrono i proletari, Karl Marx preconizza la rivolta come soluzione. È convinto, infatti, che, essendo il proletario è il motore della storia, esso detiene “la chiave della sua salvezza e della sua liberazione”. Vista sotto quest’angolo, la missione della Chiesa in Africa diventa evidente: risvegliare i poveri e metterli di fronte alla loro responsabilità nella realizzazione della loro salvezza. La Chiesa d’Africa è chiamata a non riprodurre gli errori della Chiesa dei secoli passati: mettersi vergognosamente dalla parte dei potenti. La Chiesa in Africa deve “andare al di là di una filantropia paternalista e oppressiva”, che non fa che aggravare il male della dipendenza e dell’asservimento. Con il paternalismo, i Neri sono continuamente sottomessi “alla morte della loro anima, della loro cultura, della loro identità”.
Per svolgere pienamente questo ruolo, la Chiesa d’Africa deve tornare alle sorgenti della sua tradizione che mette al di sopra di tutto la vita. Il Muntu è essenzialmente vita. Il cristianesimo africano deve aiutare a comprendere che cos’è questa vita, il suo dispiegamento e le sue interpellanze. La tradizione africana è convinta che la vita è ricevuta e trasmessa; essa è cosmica e olista. In nessun caso l’africano può concepirsi come un essere isolato; non è né una monade né un mascalzone sartriano. È essenzialmente un essere con e per gli altri. L’africano è comunità. La sua salvezza può concepirsi solo con e attraverso gli altri. Per questo Mveng dirà: “Salvarsi, è salvare il mondo!”. E salvarsi è passare, secondo l’intuizione di Gaston Fessard, attraverso la comunione e la comunicazione: l’uomo monade è chiamato a scoprirsi diade, triade e folla. Per questo E. Mveng sostiene che “il motore della creatività umana non è la ragione, ma l’Amore nel senso africano della parola”.
Riscoprire la vita come sorgente dell’umanità africana permette di non cedere alla fatalità. La Chiesa d’Africa deve lottare perché la vittoria della vita sulla morte è certa. Il suo credo si potrebbe così tradurre: la vita si personalizza nell’uomo attraverso la conquista del diritto all’esistenza. La vocazione umana consiste in questo, nella lotta il cui scopo è assicurare il trionfo della vita sulla morte. Le iniziazioni alla vita delle diverse culture d’Africa hanno quest’obiettivo: fare dell’individuo un lottatore per far trionfare la vita. Nella vita corrente, quando una persona non riesce a far trionfare la vita, è considerata dalla società come un progetto fallito. Non c’è altro passaggio per accedere pienamente alla comunità umana: bisogna lottare, conquistare la propria persona. Questo non ricorda forse il filosofo tedesco Hegel, che fa della lotta per il riconoscimento il motore della storia e delle relazioni interpersonali e interstatali? Secondo Hegel, rinunciare alla lotta è condannarsi alla schiavitù. Allora stesso modo secondo Mveng, non lottare è rendersi indegno della vita: “Davanti alla meraviglia del proprio avvento, l’uomo non ha che una scelta: accettarsi o rifiutarsi”. Un pensiero che ricorda il celebre scrittore inglese William Shakespear (W. Shakespeare, Hamlet, 3, 1), che ha detto: “To be or not be. That’s the question”. Vivere è lottare.
È questo l’antropologia della vita: non una negazione della morte, ma un sorgimento di sé dalla propria morte. Essa trova il suo fondamento nell’Egitto faraonico. Secondo le sue ricerche storiche, Mveng afferma che l’Egitto ha avuto la più antica e sola religione in cui si credeva alla vittoria della vita sulla morte. Attingendo a questa spiritualità di vita, l’Africa si affrancherà dalla morte, dall’odio e dalla servitù. Capitalizzata, questa spiritualità della vita fa di lui un contestatore e un profeta. Prendendo questa via, il teologo africano dovrà comprendere che si espone alla morte, ma non c’è altra scelta per liberarsi: essere o non essere. E. Mveng pagherà con la propria vita questa dura lotta. Ha tracciato la via a quanti seguiranno la sua strada.
Conclusione
Come si può constatare da queste righe, la lotta di E. Mveng è una lotta per la vita. Voleva ricentrare l’uomo africano sulla sua responsabilità davanti alla storia e farne un cooperatore di Dio nella realizzazione della sua salvezza. Questa presa di coscienza non è possibile che a condizione che egli riesca ad appropriarsi dei valori evangelici, a sentirsi a casa sua nella Chiesa e così a non vedere più il cristianesimo come una realtà esogena. L’antropologia della vita immanente di Mveng è anche sociale e cosmica. Abbraccia ogni africano e tutto l’africano.
Un fatto è vero: la colonizzazione l’ha ferito e raggiunto al punto più nevralgico del suo essere, cioè l’amore - in Africa, amare è vivere. Amore è dunque un desiderio molto forte che conduce l’uomo verso il compimento di sé, da non confondere con la passione che è un desiderio romantico che va fino alla fusione dei corpi e all’esclusività come orizzonti ultimi - nel senso africano del termine, come non smetteva di proclamare Mveng, ma nulla è perduto. Tutto può rinascere dalle ceneri. La vita trionfa sulla morte, l’Amore s’affermerà. Mveng ha così lanciato le basi di un’alleanza riuscita tra il cristianesimo e le culture africane. Partendo dalle sorgenti della vita, il cristianesimo rispetterà ciò che c’è di più profondo nell’anima africana e a sua volta, l’Africa vedrà nel cristianesimo un’opportunità piuttosto che una minaccia.
Questa lotta è lungi dall’essere conclusa. Ci sono alcune piccole vittorie, come il riconoscimento dell’esistenza di un pensare teologico proprio dell’Africa, uno sforzo crescente d’inculturazione liturgica, artistica, religiosa… Ma molto resta da fare. L’Africa deve continuare ad evangelizzare le sue culture. Questa evangelizzazione della cultura mirerà a una comunicazione adeguata tra Dio e l’Africa. La fonte di questo dialogo sarà evidentemente la Bibbia compresa come parola vivente di Dio, una parola rivolta a degli africani nelle loro situazioni concrete, come una volta fu comunicata agli occidentali e agli asiatici di tutti i tempi. Per fortuna la Chiesa ha riconosciuto che non c’è né cultura né lingua sacra. Ogni cultura e ogni lingua è capace di Dio e di dirlo adeguatamente. L’Africa non deve più soffrire di alcun complesso. I teologi africani sono chiamati a trovare nelle rappresentazioni culturali, artistiche e sociologiche dell’Africa un linguaggio per dire Dio ai loro contemporanei. È la sola via che rende possibile l’incarnazione del Figlio di Dio in Africa. E il Verbo s’è fatto carne ed è diventato africano.
* padre Jean Rwakabuba Muka, crsp, parroco della parrocchia di Giheke, in Rwanda
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!