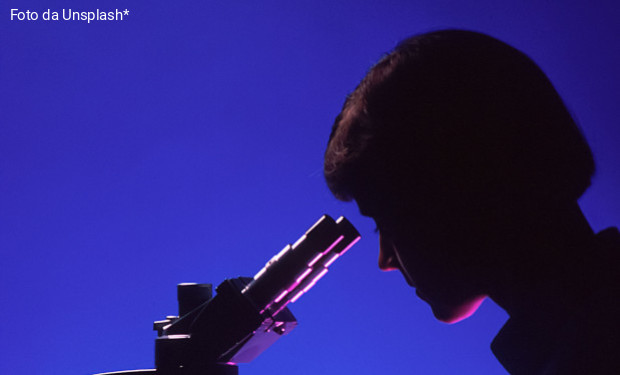
Lo sguardo della scienza: dal riduzionismo fisico alla complessità
Tratto da: Adista Documenti n° 37 del 29/10/2022
Qui l'introduzione a questo testo.
(…). È singolare che una riflessione sugli orizzonti della teologia voglia fare proprio anche lo sguardo della scienza. In genere, le istanze che ci portano a interessarci dell’uno o dell’altro, tra questi due ambiti assai diversi del pensiero umano, sembrano far parte di modi quasi contrapposti di intendere il reale e si concretizzano in linguaggi difficili da conciliare tra loro.
Qual è la ragione che spinge a curiosare in campi così eterogenei?
Credo di aver trovato una risposta a questa domanda in un bel libro di Zygmunt Bauman. In esso, dopo un’analisi critica della società attuale, che propone sostanzialmente la privatizzazione del destino comune, l’autore conclude che l’unico argine sta nella riscoperta, in ciascuno di noi, di un’etica rigorosa. Essa va perseguita con tenacia, anche se, in questa ricerca, «l’incertezza non è un problema temporaneo [...]. Al contrario, è una condizione permanente della vita». Ciò nonostante, «la responsabilità morale è incondizionata e, in linea di principio, infinita».
Io credo che la risposta stia qui: nel cercare radici sicure per una responsabilità etica incondizionata e infinita, nonostante l’incertezza. Questo può richiedere anche di indagare l’assoluto, ma di farlo con rigore, determinati a non contraddire ciò che sappiamo sulla realtà. Costruire un’etica per l’essere umano ha, come premessa, accettare l’incertezza di Baumann, ma vivendo anche questa con rigore. Un’incertezza che deve essere immune dalle illusioni e alimentata dalla speranza; che mantenga un’ancora nella realtà (da qui il perseguire la conoscenza scientifica), eppure sia sostenuta dall’interrogazione continua sul mistero che sta al di là, di cui cercare le tracce anche superando i limiti delle religioni.
Se questo è vero, allora lo scopo di questo capitolo è quello di muoversi tra la conoscenza accertata delle cose e l’attenzione al mistero, provando a trarre dalla prima motivi per contribuire a fondare un’etica incondizionata e infinita. (…)
Un cosmo incomprensibile, le due culture e qualche cautela
(…). C’è un curioso racconto di Jorge Luis Borges, nel Libro degli esseri immaginari (El libro de los seres imaginarios, originariamente pubblicato come Manual de zoología fantástica nel 1957, ndr) dal titolo A-Bao-AQu. Non conosco la critica letteraria a sufficienza per sapere se qualcuno si sia mai accorto che esso è una metafora della meccanica quantistica. Secondo me è, in effetti, una dimostrazione degli interessi poliedrici di questo autore, che per questo amo moltissimo. È una testimonianza rara di come nel mondo umanistico qualcuno stesse, in realtà, a sentire le voci della fisica.
Il racconto narra come a Chitor (città del Rajastan) esista una altissima torre (la torre della Vittoria) da cui si ha una vista incomparabile sul mondo. Solo chi ha un cuore davvero puro può, però, riuscire a salire per intero la sua lunghissima scala. Chi sale, desta A-BaoA-Qu, entità senza colore né forma, che dorme raggomitolata sul primo gradino. Questa «solo fruisce di vita cosciente quando qualcuno sale la scala». È l’interazione con questo qualcuno che sveglia l’essere informe e lo fa illuminare e pulsare di vita, tanto più quanto più in alto questi riesce a salire. È un bell’esempio della teoria dell’interazione quantistica di Born e Bohr trasfigurata dalla poesia di un altro grande del Novecento.
Nella letteratura del secolo breve vi sono altri segni di attenzione a cosa stava succedendo nella fisica. Sono frequenti in Borges, ma due molto notevoli stanno anche nella letteratura italiana. A leggere i racconti di Dino Buzzati ci si rende conto che parecchi tra essi sono paradossi relativistici (che forse suscitavano la sua curiosità, nelle discussioni con il fratello scienziato). Ancora più evidente (e in questo caso ben noto) è l’interesse generale per la scienza di Calvino, che percorre tutta la sua produzione. Nelle arti figurative, alcuni hanno voluto vedere la ricerca di una dimensione in eccesso, come nella relatività ristretta, nel primo cubismo di Picasso (ricordate quei profili di donna con entrambi gli occhi dallo stesso lato?). Tuttavia questi esempi apprezzabili sono quasi casi isolati. Troppa distanza c’era tra l’universo di novità, equazioni e scoperte della scienza e la cultura umanistica principalmente esistenzialista del Novecento.
L’equazione della relatività generale di Einstein era stata detta “la più bella delle equazioni”, così bella da non poter non essere vera. All’incirca la stessa cosa si disse dell’equazione di Dirac, che sintetizzava in una formula brevissima tutto ciò che era possibile sapere sul mondo microscopico.
Eppure, sulle vie astratte della nuova fisica, comprensibili a stento da chi vi si fosse inoltrato, il pensiero umanistico e filosofico non fu in genere in grado di capire. Nella sua grande maggioranza non seguì la fisica nei suoi tentativi di spiegare il mondo e da ciò nacque una frattura culturale profonda nell’Occidente, tuttora non superata.
Nel 1959, C. P. Snow (romanziere e chimico britannico, creatore della locuzione «le due culture») lamentava questa frattura in modo sferzante. Sosteneva che nessuno dei suoi interlocutori umanisti sapeva rispondere a semplici domande sulla scienza, persino a quelle che erano oggetto di insegnamento nella scuola (domande del tipo: “Cos’è il secondo principio della termodinamica?”). A seguito di ciò, commentava: «Così il grande edificio della fisica moderna si innalza, e la maggior parte delle persone più intelligenti del mondo occidentale ha di esso circa la stessa comprensione dei loro antenati neolitici».
Il nuovo modo della scienza novecentesca di guardare alla natura delle cose era diventato in realtà l’esatto contrario di quello positivista, al servizio del potere, descritto criticamente da molti filosofi successivi. Eppure, oltre sessant’anni dopo, il pregiudizio diffuso sulla scienza rimane, anche se nelle tasche di ciascuno di noi i cellulari hanno componenti (CCD, GPS) in cui la relatività generale e la meccanica quantistica sono diventate oggetto di consumo quotidiano. Pochi lo sanno e quasi nessuno è in grado di capirne il significato e così ci rendiamo sempre più dipendenti da tecnologie controllate altrove, mentre l’atteggiamento di paura e le ipotesi di oscuri complotti da parte della scienza hanno contaminato ormai settori vitali, come la medicina, anch’essa sempre più basata (specie nelle sue radici microbiologiche, nella virologia, o nelle neuroscienze) su cose incomprensibili come la fisica, la chimica e la biologia quantistiche.
Nonostante queste diffidenze, oggi molti risultati innovativi della scienza sono diventati di dominio e apprezzamento comuni. In questi mesi, per esempio, il mondo ha avuto largo (e ben pubblicizzato) accesso ai dati di quella meraviglia tecnologica che è il nuovo James Webb Space Telescope (JWST). (...).
È diventato allora sempre più comune, in questi anni, il tentativo lodevole di recuperare anche alla cultura umanistica i risultati della fisica e delle scienze della natura in genere. È così anche nelle descrizioni del mondo utilizzate in varie opere della nuova teologia, come ad esempio in quella di Diarmuid O’Murchu.
Tuttavia, un fisico che legga un titolo come “teologia quantistica” probabilmente resterebbe perplesso. Della meccanica quantistica, di cui ho tentato di far intuire l’estrema difficoltà e la visione antitetica a quella della fisica classica (si ricordi il rifiuto di Einstein), si vedono oggi, infatti, usi e abusi; soprattutto abusi, in campi alieni alla scienza.
Non è questa una critica ai teologi; è più un’autocritica come fisici, per non essere riusciti a trasmettere l’idea che questi concetti non si possono maneggiare con disinvoltura senza conoscerli a fondo. Si rischia di scottarsi terribilmente, di finire per esporre tesi in contrasto con la scienza accettata, come le affermazioni delle chiese sono in contrasto con l’archeologia.
Eppure, nel nostro caso, penso che le cose che a prima vista appaiono come un “uso troppo disinvolto” dei concetti della fisica microscopica siano in realtà soprattutto equivoci abbastanza innocenti sui termini, ai quali si può forse trovare rimedio.
Trovo questo spiegato, in realtà, nella straordinaria introduzione a questo volume, in cui l’autrice pare anche suggerire la via, pur senza dare ad essa un nome specifico. Io penso che questo nome potrebbe essere “complessità”: uno sbocco che ritroveremo, con qualche chiarimento, nel prossimo paragrafo.
Come abbiamo già detto, la meccanica quantistica vale infatti solo nel mondo microscopico; ogni estensione “incontrollata” è preclusa dal principio di corrispondenza di Bohr. Ciò è oggi interpretato come l’effetto dei citati miliardi di interazioni, di somme caotiche con le funzioni d’onda delle particelle dell’ambiente. Questo fatto prende il nome di de-coerenza quantistica e la sua conferma è ormai oggetto di prove sperimentali autorevoli.
L’immagine di JWST testimonia in modo evidente che nell’universo a grande scala si vedono effetti relativistici, non quantistici. Tuttavia si coglie anche una grandissima complessità, che forse richiede qualche riflessione specifica. (…).
Un universo complesso e una scienza che si affaccia sul sacro
(…). Come s’è detto, i due grandi paradigmi della fisica, relatività generale e meccanica quantistica, non sono ancora fusi in una teoria coerente più generale, la teoria del tutto, che i fisici cercano ormai da parecchi anni. I due tentativi più evoluti oggi in piedi sono la teoria delle stringhe cosmiche, sostenuta dal già citato Brian Greene, e la gravità quantistica, di cui un esponente di primo piano è Carlo Rovelli. Entrambe sono ancora idee del mondo non suffragate a pieno da esperimenti, quindi miti. (…).
Le insufficienze dei nostri miti nello spiegare la realtà sono diventate oggetto di seria riflessione da parte di molti. Come detto nella sezione 1, ogni volta che la complessità cresce troppo, la fisica arranca: i moti dell’atmosfera, le correnti del mare, la struttura fine delle galassie (...) sono troppo difficili da seguire, anche se conosciamo ognuna delle leggi da cui questi fenomeni derivano. Molte regolarità d’insieme emergono per le strutture complesse senza che la fisica riesca a spiegarsele: si pensi solo a come si intrecciano e si compongono gli stormi degli uccelli. Oggi molti pensano che, a partire dalla fisica, ma trascendendola, sia possibile far emergere, auto-organizzare nuove leggi collettive per la complessità. A questa, anche la fisica vera e propria guarda con attenzione: si ricorderà che il premio Nobel 2021 per la fisica è stato assegnato a Parisi, Manabe e Hasselman proprio per i loro studi sulla complessità. Tuttavia, anche altre scienze sono coinvolte, dalla chimica alla biologia e fino all’economia e alla sociologia.
Un esponente di spicco di questi studi è il biologo Stuart Kauffman, che ne presenta il corpus di ricerche a volte con libri tecnicamente approfonditi, a volte con narrazioni poeticamente ispirate all’esigenza di oltrepassare le scienze riduzioniste della natura conosciute fin qui. Singolarmente, da ricercatore noncredente, egli rivendica a questi studi l’ambizione di esplorare campi che sconfinano nel sacro.
Abbiamo iniziato questo capitolo sottolineando, con Baumann, l’esigenza di aiutarci con la scienza a fondare un’etica rigorosa per l’umanità, anche utilizzando la creatività propria dell’Homo sapiens nel costruire i suoi miti. Possiamo allora, alla fine del nostro percorso, mostrare come la scienza cominci a interessarsi proprio a questo, partendo dalle conoscenze acquisite e dalla consapevolezza della realtà fornita dalla fisica, ma andando oltre.
Citerei per questo proprio Kauffman, come prototipo dello scienziato che tenta di superare i limiti tradizionali, affacciandosi al mistero: «Dio è la creatività stessa che emerge dall’universo»; e «Se prendiamo questa creatività come un senso di Dio che possiamo condividere, il significato risultante è la sacralità dell’intera vita e del pianeta; e può orientare le nostre esistenze oltre il consumismo [...], curare la frattura tra scienze naturali ed umane, il bisogno di spiritualità, la ferita derivata da [...] un mondo di fatti senza valori, aiutandoci tutti insieme a costruire un’etica globale. Questo è ciò che è in gioco nel [...] reinventare il sacro».
È qui che ho trovato una sintonia quasi perfetta con le cose dette da Claudia Fanti nell’introduzione a questo volume. Qui, più che nelle radici quantistiche della realtà, potrebbe essere cercato un mondo (le citazioni sono dall’introduzione menzionata) di «interconnessione e interdipendenza». Negli sbocchi ancora misteriosi della complessità oltre, non sotto, la fisica ordinaria, potrebbe trovarsi la strada per «ricomporre il divorzio tra mente e materia» e per cercare «un divino da assaporare e respirare, in cui immergerci», riscoprendo «mistero, incanto, interconnessione, stupore, amore». E lo si potrebbe fare in dialogo, non in contrasto, con la scienza, cercando sentieri da percorrere insieme oltre i limiti finora raggiunti. (…).
A pale blue dot: irrilevanza, mistero, empatia
(…) Vorrei concludere brevemente mostrando un’immagine che per me riassume in modo profondo lo sguardo della scienza sul mistero e, insieme, su di noi. Si tratta di una foto – Pale blue dot, pallido punto azzurro – scattata tanto tempo fa (nel 1990) dalla sonda Voyager 1, che a quel tempo aveva da poco superato l’orbita di Nettuno. Su richiesta dell’astronomo Carl Sagan, la Nasa fece voltare la sonda per realizzare l’immagine. Illuminato da un raggio di Sole forse riflesso da qualche superficie del veicolo spaziale, appena visibile nell’immensità vuota del cosmo, appare un pallido punto azzurro.
Quel puntino è l’intero sistema Terra-Luna, visto tra l’altro da una distanza ancora modesta, anche solo rispetto a quella raggiunta oggi dal Voyager 1, da poco uscito dal Sistema Solare. Non appare trascurabile quel piccolo punto, sul quale passiamo la breve stagione della nostra esistenza a consumarci in guerre senza senso, mentre una parte troppo grande dell’umanità rimane esclusa, vittima della povertà, dell’ingiustizia, delle malattie, delle carestie, dell’ignoranza? Qual è lo scopo di tutta questa follia? Per chi, come me, è italiano, quel raggio di sole isolato che illumina la nostra insensatezza ricorda i versi celebri di Salvatore Quasimodo: «Ognuno sta solo/sul cuor della terra/trafitto da un raggio di Sole./Ed è subito sera».
Eppure c’è un altro modo di essere, c’è un’etica, nonostante tutto, da perseguire, prima che si faccia sera, per nobilitare la nostra irrilevanza. Anche la scienza ce lo mostra: gli esperimenti che servono a verificare le teorie di frontiera, sempre più difficili, non possono essere fatti da un solo Paese. Come per le prove di Psiche da cui siamo partiti, anche questi richiedono tutti gli aiuti possibili dalla natura e dagli altri esseri umani. E oggi la big science, quella che ha costruito il gigantesco telescopio spaziale che ci ha regalato l’immagine della Figura 2, o quella che ha rivelato il bosone di Higgs, è fatta da collaborazioni planetarie, che superano le divisioni di etnia, religione, opinioni politiche, scontri tra le nazioni. È fatta dalle donne (sempre più numerose) e dagli uomini di questo pianeta, insieme.
La prima idea di scienza nacque su questa pale blue dot all’epoca di Pericle, insieme alla democrazia; e oggi essa ci impartisce, prima di tutto, una lezione di democrazia. Solo una volta stabilito questo principio, che l’umanità può provare empatia anziché odio, collaborazione anziché sopraffazione, il nostro sguardo può estendersi seriamente al di là, umili nella nostra irrilevanza, ma uniti dall’impossibilità di fermarci; consci che possiamo certamente fallire, ma che fallire insieme, avendoci comunque provato, è già un destino che vale la pena di essere vissuto, un’eredità da lasciare con orgoglio a chi abiterà dopo di noi quel piccolo puntino azzurro.
*Foto presa da Unsplash, immagine originale e licenza
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!


