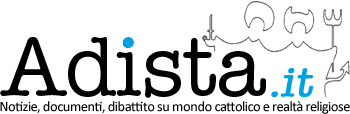LA SFIDA DI UNA CITTADINANZA ATTIVA ED ESIGENTE
Tratto da: Adista Documenti n° 3 del 26/01/2013
Credo che il tema della democrazia sia la questione fondamentale di questi anni e di quelli a venire, perché oggi la democrazia che conosciamo, vale a dire quella rappresentativa, penso attraversi una crisi irreversibile e vada quindi reinventata. Ciò dipende dalla crisi del modello in cui siamo immersi, il cosiddetto modello neoliberista, diffusosi circa 50 anni fa quando, di fronte ad una serie di innovazioni tecnologiche nel campo della comunicazione, dei trasporti, dell’informatica, si è immaginato l’intero pianeta come un unico grande mercato, con il conseguente drastico ridimensionamento delle economie nazionali, degli Stati come sistemi chiusi.
Si è creduto così che, se si fossero eliminati tutti i vincoli sociali e ambientali e si fosse lasciato il mercato libero di dispiegarsi, si sarebbe prodotta un’enorme ricchezza la quale, pur senza eliminare le diseguaglianze, avrebbe creato a cascata benessere per tutti. In questo consiste la favola neoliberista raccontata circa 50 anni fa. Tutti ritengono che gli iniziatori siano stati Margaret Thatcher e Ronald Reagan, ma in realtà il primo esperimento ha avuto luogo nel Cile di Pinochet - dopo il colpo di Stato militare che ha rovesciato il governo democratico di Allende -, con l’arrivo dei Chicago Boys, gli economisti che hanno promosso per primi le politiche liberiste in Cile, procedendo alla privatizzazione di tutti i servizi in un sistema di mercato totalmente libero. Dal Cile questa teoria è passata in Europa e negli Stati Uniti, appunto con il governo Thatcher in Inghilterra e con il governo Reagan negli Stati Uniti, e piano piano si è diffusa in tutto il mondo.
UN MODELLO IN CRISI
È proprio tale idea del mercato come principale regolatore della società a costituire oggi uno degli elementi della crisi che stiamo attraversando, una crisi globale che è al tempo stesso una crisi economica, finanziaria, ecologica - per quanto di quest’ultimo aspetto si parli sempre molto poco, salvo poi sperimentarlo nella vita quotidiana (e di certo in maniera sempre più drammatica con il passare degli anni) - ma anche e soprattutto una crisi di democrazia. È una realtà che viviamo quotidianamente. Chi ha partecipato, per esempio, all’esperienza del referendum sull’acqua si sarà reso conto di come le istituzioni, invece di obbedire al mandato popolare, facciano a gara per negare l’esito referendario, ritenendo che il risultato del referendum debba essere interpretato, che il voto abbia espresso un’emozione che occorre razionalizzare, o che, in attesa di nuove norme, non convenga intervenire su quelle esistenti. Proviamo ad immaginare il contrario: che il Parlamento promulghi la riforma delle pensioni e noi ritenessimo di doverla interpretare o di dover razionalizzare l’emozione espressa dai parlamentari. E questo solo per dare l’dea di come si tenga conto oggi della voce del popolo.
Io penso che questo modello, il modello capitalistico nella fase che definiamo neoliberista, sia in crisi da tempo, da 25/30 anni, e che si tratti di una crisi profonda. Il vero problema, insomma, non è quello di una finanza cattiva a fronte di un’economia reale buona. In realtà, la finanza ha permesso a questo modello di rimandare l’esplosione di una crisi che è iniziata già dalla fine degli anni ‘80. L’idea del mercato come unico regolatore sociale ha comportato prima di tutto un livello di disuguaglianze sociali senza precedenti nella storia. Ciò significa che la popolazione povera del mondo, cioè la maggioranza degli abitanti di questo pianeta, non è mai stata così depredata e così depauperata come in questi ultimi 30 anni, al punto da perdere completamente ogni potere d’acquisto. E che, contemporaneamente, la parte minoritaria, quella a cui anche noi apparteniamo, ha comprato praticamente tutto.
Il fatto, tuttavia, è che possiamo pure essere indotti a cambiare la nostra automobile ogni due anni, ma non possiamo comprare 10 automobili a testa. Si può anche convincere i più giovani, sempre spendendo miliardi in pubblicità, che il cellulare che hanno in tasca è obsoleto perché il mese dopo ne uscirà uno con nuove funzioni, ma non si possono comprare 10 cellulari a testa. C’è un limite di saturazione oltre il quale l’unica possibilità che resta è quella di aprire nuovi mercati. Ma se i nuovi potenziali acquirenti sono talmente impoveriti da non poter comprare più nulla, si finisce in una impasse. Ed è esattamente questo il punto in cui si è trovato il modello neoliberista. Cosa succede allora? Poiché il fine del modello è il profitto, se non è più possibile ottenerlo vendendo cose, oggetti materiali, si cerca allora un’altra modalità di fare utili, che è quella dello scambio di denaro. È qui che entra in gioco quel settore della finanza che oggi è diventato un mostro incontrollabile, perché non credo che ci sia qualcuno sul pianeta in grado di tenere sotto controllo i processi finanziari.
L’insieme degli scambi fra i Paesi relativi a beni materiali è pari, in un anno, a circa 10mila miliardi di dollari. Una cifra che nello scambio di denaro con denaro si raggiunge in 3 giorni. E parliamo solo della cosiddetta finanza controllata, che è quella soggetta alla Borsa. Perché poi c’è la finanza ombra, quella che non è sottoposta ad alcun controllo: l’insieme di scambi monetari quotidiani non sottoposti a controlli è pari a 12 volte il Pil mondiale. Il che vuol dire che viene scambiato ogni giorno sui mercati finanziari ombra un valore 12 volte superiore a tutto quello che viene prodotto nel pianeta in un anno.
Un’altra nuova fonte di profitti è quella dei beni comuni. Una volta vendute tutte le automobili possibili, una volta venduti tutti i telefonini possibili, bisogna inventarsi nuovi prodotti. Per esempio, si potrà passare a considerare l’istruzione o la salute non più come diritti, ma come beni economici: ciò vuol dire che una parte della popolazione non studierà o non si curerà perché non se lo potrà permettere, ma chi potrà dovrà pagare per essere istruito o ricevere cure. Oppure, l’acqua sarà vista non più come un bene comune ma come una merce, con il vantaggio che non c’è neppure bisogno di pubblicità per promuoverne il consumo. Siamo dunque entrati nella fase in cui tale modello, per continuare ad esistere, deve espropriarci di tutto, e mettere tutto sul mercato.
LA PRIVATIZZAZIONE DELLA POLITICA
Veniamo alla democrazia. È ovvio che, nel momento in cui ci viene tolto tutto, ci venga sottratta anche la possibilità di prendere delle decisioni, perché altrimenti noi decideremmo di seguire una strada diversa. Basti pensare all’esito del referendum sull’acqua. Se la democrazia fosse in vigore, insomma, tale modello non starebbe in piedi. In Val d’Aosta, per esempio, si è votato recentemente un referendum contro un inceneritore. All’inizio, tutti i grandi partiti erano schierati a favore dell’inceneritore, ma poi, dopo aver annusato l’aria, hanno cambiato idea in tempo per saltare sul carro dei vincitori (il quorum, che in Val d’Aosta è fissato al 45%, è stato superato di 4 punti e il 94% dei votanti si è espresso contro l’inceneritore). Ovunque i cittadini, quando hanno la possibilità di scegliere, si oppongono all’idea del mercato come unico regolatore sociale.
Così, dopo aver sentito ripetere per anni che privato era bello, adesso ci viene semplicemente detto che privato è obbligatorio. Non importa che si votino i referendum: il privato è obbligatorio perché lo dice l’Unione Europea, perché lo dice la crisi, perché lo dice lo spread. E tutto ciò ci abitua a pensare che il quadro è immodificabile.
Per mantenere tale modello, insomma, è necessario che ci venga sottratta la possibilità di decidere. E a tale scopo la politica è stata progressivamente privatizzata, trasformandosi da luogo in cui sono rappresentati interessi diversi, ma tutti radicati nella società, a una sorta di confronto fra gruppi di potere (nel migliore dei casi) o fra clan quasi familiari (nel peggiore). E ciò avviene, in primo luogo, allontanandoci dai luoghi in cui si prendono decisioni. Quali sono, non a caso, le istituzioni più colpite dalla crisi? Gli enti locali. Se si continuano ad applicare le politiche messe in campo dall’Unione Europea e dai governi, il risultato finale sarà la scomparsa della funzione storica degli enti locali.
Con il Patto di stabilità interno - l’insieme di misure che occorre adottare per corrispondere all’obiettivo di finanza nazionale, che è la riduzione del debito -, i Comuni sono costretti a rinunciare a ogni tipo di investimento e, dall’anno prossimo, a ridurre drasticamente anche le spese correnti, cioè le spese che consentono il normale funzionamento dell’attività comunale. A ciò aggiungiamo il “Fiscal compact”, l’accordo europeo in base al quale, nei prossimi 20 anni, dovremo ridurre il rapporto debito-Pil del 60%, vale a dire che ogni anno dovremo prevedere dai 50 ai 60 miliardi di spese in meno. E aggiungiamo a questo anche gli interessi sul debito che ogni anno raggiungono i 90 miliardi di euro.
In questo quadro, è chiaro che la capacità di spesa dei Comuni viene drasticamente ridimensionata e che il ruolo di questi si ridurrà, da una parte, a quello di esecutori materiali delle politiche decise dall’Unione Europea e, dall’altra, a quello di una sorta di controllori sociali: non potendo più erogare servizi, la funzione dei sindaci diventerà a poco a poco quella degli sceriffi (non a caso molta dell’attività dei sindaci è ormai quella di emanare ordinanze su comportamenti individuali e collettivi).
Tutto ciò è già chiaro rispetto all’acqua. Se, com’è noto, il servizio idrico viene gestito attraverso Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), aree geografiche che dovrebbero corrispondere ai bacini idrografici, ma che in realtà normalmente coincidono con le Province, la riforma prevista prevede un ATO per regione, con uno spostamento del centro decisionale dall’ambito locale alla Regione e il conseguente ridimensionamento della nostra capacità di pressione e di intervento (perché è ben diverso andare a protestare al municipio o dover percorrere chilometri fino alla Regione).
RIFONDARE LA DEMOCRAZIA
La democrazia partecipativa, quindi, oggi non è un lusso, ma una necessità. E se è vera la mia opinione riguardo alla crisi irreversibile della democrazia rappresentativa, il problema non è solo quello di cambiare i volti di chi ci rappresenta. È ovvio che è meglio un deputato intelligente ed onesto che uno stupido o ladro. Ma finché non si modificherà il meccanismo attraverso il quale si prendono le decisioni, in maniera da collegarle ai bisogni espressi in un determinato territorio, si potranno anche ottenere parlamentari migliori, ma senza la possibilità di incidere sulla vita quotidiana delle persone. Ecco allora che la questione della democrazia partecipativa diventa la strada per rifondare la democrazia in questo Paese. Cosa vuol dire democrazia partecipativa? Non essendoci un manuale, non si può fare un copia e incolla, come pensavano di fare i sindaci italiani tornati dai Forum sociali mondiali di Porto Alegre, una città che aveva alle spalle un lungo percorso in materia di bilancio partecipativo. Perché a Porto Alegre questa esperienza non è partita da un sindaco illuminato, ma da un bisogno reale dei cittadini, i quali hanno cominciato a mobilitarsi e a costruire percorsi, trovando un’amministrazione comunale permeabile. Noi abbiamo bisogno di sindaci permeabili, non di sindaci illuminati. Di sindaci, cioè, che entrano in osmosi con quanto succede nel territorio, con i percorsi, le proposte e i processi che vi vengono costruiti.
La democrazia partecipativa è la possibilità che su ogni tema in discussione si crei un percorso decisionale a cui partecipi il massimo numero di persone direttamente interessate. E ciò implica una vera rivoluzione culturale e sociale, che consenta di condurre i processi il più vicino possibile alla nostra vita quotidiana. Se, per esempio, la politica dei rifiuti viene decisa ai piani alti, in base agli interessi di mercato, noi non potremo incidere in alcun modo e il risultato sarà una politica centrata su discariche e inceneritori (sulle discariche perché è la via più comoda e sugli inceneritori perché si tratta di un grande business). Affinché siano promossi la raccolta differenziata porta a porta, il riciclo, un sistema che guardi ai rifiuti non come scarti ma come possibilità, e che ragioni soprattutto sulla riduzione della produzione dei rifiuti, occorre territorializzare tale politica, coinvolgendo tutti i cittadini in ogni casa, in ogni quartiere, e lasciando che siano i cittadini a costruire questo processo. E lo stesso vale per l’acqua, tanto più che le multinazionali stanno già conducendo studi sulla disponibilità di acqua nel pianeta per accaparrarsene nel prossimo futuro, quando l’acqua sarà (sta già cominciando ad esserlo) il vero e più grande business. Perché dunque ci sia una gestione partecipativa dell’acqua, è necessario avvicinare quanto più possibile al territorio il processo decisionale rispetto alla conservazione della risorsa, ai necessari interventi sugli acquedotti, agli interventi sul servizio per renderlo accessibile a tutti.
Pensiamo alla questione energetica: è necessario far capire che non abbiamo bisogno di produrre ulteriore energia - ne produciamo già troppa - ma che occorre avviare un enorme lavoro di risparmio energetico collettivo; e che l’energia deve essere prodotta non più da combustibili fossili, da materie prime inquinanti, ma da fonti rinnovabili, con impianti piccoli e territorializzati, fino a giungere all’autoproduzione collettiva di energia.
E pensiamo alla questione del lavoro. Vorremmo spedire Marchionne dall’altra parte dell’oceano, dove peraltro andrà comunque per volontà sua, ma, nel difendere il lavoro, dovremmo proporre alternative diverse da quella di continuare a produrre automobili private. Un cambiamento, però, è possibile solo se tutte e tutti cominceremo a partecipare ai processi in cui si decide cosa produrre, come produrre, perché produrre, per chi produrre e dove produrre.
Più concretamente, molto si potrebbe iniziare a fare se le amministrazioni locali predisponessero tavoli di confronto tra le forze imprenditoriali, la società civile, i sindacati. Immaginiamo ad esempio di discutere, nel territorio di Roma, della crisi dell’edilizia, per impiegare i lavoratori del settore nella ristrutturazione dell’esistente e magari anche nella ristrutturazione energetica dell’esistente. In questo modo si creerebbero migliaia di posti di lavoro. E finalmente si farebbero cose di cui rallegrarsi, anziché veder cementificare un pezzo di territorio dopo l’altro.
Dunque, per prima cosa, servono cittadini attivi. E non dobbiamo lasciarci spaventare dall’impegno che questo implica. Perché, nel partecipare, ci si sente parte di un processo, di una collettività, di una comunità, e questo ci rende più sereni anche rispetto a tutto il resto. Dobbiamo essere inflessibili con gli amministratori locali, di qualsiasi colore essi siano, non dobbiamo lasciarli respirare, e ciò per difendere il primo luogo di prossimità democratica alla nostra vita quotidiana, che è l’ente locale.
La prima sfida è quella dell’informazione. L’epoca della cosiddetta informazione di massa sta producendo enormi diseguaglianze di saperi. E, oltretutto, siamo talmente bombardati da informazioni che facciamo fatica a selezionare quelle reali e importanti. La democrazia partecipativa parte dalla socializzazione dei saperi, perché nessuna assemblea realmente democratica è possibile in assenza di una base di sapere comune a tutti.
In secondo luogo, credo che la democrazia partecipativa debba prevedere anche momenti di rappresentanza, ma a patto che questi momenti siano di scopo e a tempo. Vale a dire che nessuno deve rappresentare tutti su ogni cosa nel tempo, ma che deve esserci un diverso rappresentante per ogni tema e per un tempo predeterminato, qualcuno che svolga la funzione di rappresentare un determinato bisogno in un determinato territorio per poi lasciare spazio a qualcun altro. Perché, per quanto si possa essere mossi da ideali, nei luoghi in cui si acquista status si rischia di innamorarsi di quello status. E allora è bene che ci si auto-educhi a non essere indispensabili, ad essere sempre sostituibili.
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!